Copertina ASCL
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Paola Zancani Montuoro
Accademia Nazionale dei Lincei Archivio di Paola Zancani Montuoro Inventario a cura di Paola Cagiano de Azevedo Roma 2015 2 Biografia Paola Zancani Montuoro nacque a Napoli il 27 febbraio del 1901 in una famiglia colta e benestante. Suo padre, Raffaele Montuoro, era un avvocato e brillante giornalista (redattore capo del «Pungolo»1) e sua madre, Clotilde Arlotta, proveniva da una facoltosa famiglia che annoverava tra i suoi membri: banchieri, industriali e uomini politici. Frequentò assiduamente la Napoli dei circoli colti di Benedetto Croce, la cui casa, soprattutto durante il fascismo, divenne punto di incontro di spiriti liberi continuamente alla ricerca di nuovi stimoli per ampliare gli orizzonti culturali. Questo ambiente ricco di fermenti intellettuali indirizzarono Paola Montuoro verso gli studi classici; si iscrisse all'Università di Napoli dove, tra gli insegnanti che ebbero un ruolo nella sua formazione, vanno ricordati gli illustri archeologi Antonio Sogliano e Giulio Emanuele Rizzo. Si laureò nel 1923 con una tesi su L’origine della decorazione frontonale nei templi greci. Dopo aver sposato un collega, Domenico Zancani, partì nel 1927 per Atene insieme a Margherita Guarducci, per frequentare la prestigiosa Scuola archeologica italiana di Atene. La morte del marito a pochi mesi dal matrimonio, allontanò Paola Montuoro dai suoi studi e dai suoi interessi; solo grazie alla collaborazione con la Società Magna Grecia, dopo un lungo periodo trascorso nel lutto, riesce a recuperare quella che era la passione di sempre dedicandosi, con molte difficoltà, allo studio e all’attività di ricerca, buona parte della quale dedicata alla prosecuzione del lavoro iniziato dal marito sui Pinakes di Locri. -

Ceci N'est Pas Un Musée
GUIDE TO THE [DISMANTLED] ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF PAESTUM 3,00 ceci n’est pas € un musée GUIDE TO THE [DISMANTLED] ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF PAESTUM ceci n’est pas un musée EDITED BY GABRIEL ZUCHTRIEGEL AND MARIA BOFFA thanks to cover the work tempi prospettici editorial coordinator (perspective times) maria sapio by carlo alfano redazione page 2 alessandra guadagno metopes with dancing girls from the sanctuary of hera art director at the mouth of the river sele enrica d’aguanno graphic designer vincenzo antonio grillo translation colum fordham arte’m is a registered trademark of prismi certification quality standard ISO 9001: 2008 www.arte-m.net printed in italy © copyright 2019 by archaeological park of paestum ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo printed in november 2019 prismi editrice politecnica napoli srl printing and layout all rights reserved industria grafica letizia srl contents 7 ceci n’est pas un musée the museum beyond its contents gabriel zuchtriegel 13 the museum of paestum from 1952 to the present maria antonietta brandonisio 19 the virtual museum at the mouth of the river sele bianca ferrara 27 the excavations at the mouth of the river sele: in search of the greeks during the twenty-year period of romanisation daniele rossetti 31 the diver in the work by carlo alfano raffaele d’andria 37 rethinking the museum of paestum: notes on the proposed dismantlement maria boffa 45 …so what is it? mariajosè luongo 55 the museum, the architecture and the characters maria boffa, maria antonietta brandonisio 62 map 64 bibliography ceci n’est pas un musée the museum beyond its contents gabriel zuchtriegel director of the archaeological park of paestum This guide is due to be published at what is arguably the most awkward moment im- aginable. -
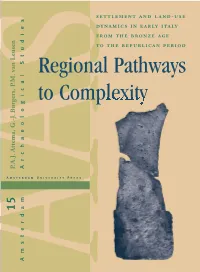
Regional Pathways to Complexity Archaeological Studies P.A.J
settlement and land-use dynamics in early italy from the bronze age to the republican period Regional Pathways to Complexity Archaeological Studies P.A.J. Attema, G.-J. Burgers, P.M. van Leusen van P.M. Burgers, G.-J. Attema, P.A.J. Amsterdam University Press 15 Amsterdam Amsterdam Regional Pathways to Complexity 15 Editorial Board: Prof. dr. E.M. Moormann Prof. dr. P.A.J. Attema Prof. dr. N. Roymans Prof. dr. F. Theuws Other titles in the series: N. Roymans (ed.): From the Sword to the Plough Three Studies on the Earliest Romanisation of Northern Gaul ISBN 90 5356 237 0 T. Derks: Gods, Temples and Ritual Practices The Transformation of Religious Ideas and Values in Roman Gaul ISBN 90 5356 254 0 A. Verhoeven: Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland (8e – 13e eeuw) ISBN 90 5356 267 2 F. Theuws / N. Roymans (eds): Land and Ancestors Cultural Dynamics in the Urnfield Period and the Middle Ages in the Southern Netherlands ISBN 90 5356 278 8 J. Bazelmans: By Weapons made Worthy Lords, Retainers and Their Relationship in Beowulf ISBN 90 5356 325 3 R. Corbey / W. Roebroeks (eds): Studying Human Origins Disciplinary History and Epistemology ISBN 90 5356 464 0 M. Diepeveen-Jansen: People, Ideas and Goods New Perspectives on ‘Celtic barbarians’ in Western and Central Europe (500-250 BC) ISBN 90 5356 481 0 G. J. van Wijngaarden: Use and Appreciation of Mycenean Pottery in the Levant, Cyprus and Italy (ca. 1600-1200 BC) The Significance of Context ISBN 90 5356 482 9 F.A. Gerritsen: Local Identities Landscape and community in the late prehistoric Meuse-Demer-Scheldt region ISBN 90 5356 588 4 N. -

Akhaian Late Geometric and Archaic Pottery in South Italy and Sicily
HESPERIA 70 (200I) MAG N A AC H A E A Pages373-46° AKHAIANLATE GEOMETRIC ANDARCHAIC POTTERY IN SOUTHITALY AND SICILY In memoryofEmilyToionsend ABSTRACT Vermeule ImportedAkhaian and locallyproduced Akhaian-style pottery occurs in SouthItaly, Sicily, and beyond, found not only in the Akhaianapoikiai, but also in other settlements.The most characteristicAkhaian shape the kantharos is discussedwithinthe contextof its homeregion, including Elis. Examplesof ArchaicAkhaian pottery in theWest are assembled and the dis- tributionis comparedto thatof Akhaianand West Greek imports in the Late BronzeAge. A patternemerges that suggests a complexreality of interaction andmovement of people,commodities, and ideas between Greece and Italy in the pre- and protohistoricperiods, thus contributingto a betterunder- standingof the firstwestern Greeks. AIMSAND SCOPE OF THE STUDY Thispaper emerged from a studyof thepottery from the site at Francavilla Marittima,the extramuralsanctuary of theAkhaian apoikia of Sybarison the siteof an earlierindigenous settlement (Fig. 1).1 In dealingwith the potteryfrom the sanctuaryon the Timponedella Motta (see below),I discovereda largenumber of plainbanded and monochrome kantharoi, manyof whichwere locally produced, either in the plainof Sybarisor elsewherein SouthItaly, while others were imported. These are not iso- latedexamples, but together form one of themost numerous categories of potteryafter Corinthian. In shapeand style, these kantharoi are closest to a seriesof vesselsfrom various sites in the northwestPeloponnese, par- ticularlyAkhaia. Despite the factthat Sybaris was traditionally founded by Akhaians,the Peloponnesiancharacter of thismaterial has not previ- ouslybeen recognized in studiesof Greekpottery in SouthItaly and Sic- ily.The relevantmaterial from Francavilla will be fullypublished else- where.Comparative material from other sites in SouthItaly and Sicily formsthe basisof this article,the aimof whichis to track,as faras is 1. -

The Search for Sybaris: an Evaluation of Historical and Archaeological Evidence
BaBesch 76 (2001) The Search for Sybaris: an Evaluation of Historical and Archaeological Evidence Marianne Kleibrink ‘Many times during these past years of searching for con- peu de tout pèle-mèle dans ce livre’ (Lenormant crete evidence of Sybaris I have felt that the famed city 1881, iv). Because the ancient sources on the loca- was a myth’ (Fro. Rainey, in Rainey/Lerici 1967, XIX) tion of Sybaris are meagre, and only report that Sybaris was located between the river Sybaris in the The ancients contrasted normal life sharply with that north and the river Krathis in the south (Diodoros at Sybaris. Many ancient tales of excess do not just XI 90. 3; XII. 9. 2; Strabo VI. 1. 13; Pliny III. 10. describe the luxuries in the streets and houses of this 97; XVI. 33. 81),1 Lenormant’s book caused excite- Greek colony in Southern Italy, but focus on the ment as well as confusion. Excitement because he wickedness and spoiled ways of its inhabitants stated that the discovery and excavation of Sybaris (Ampolo 1993). The story of the complete disap- would certainly surpass that of Pompeii, since it pearance of Sybaris in the floods of the river Krathis would give Europe a Greek town of extreme riches; in 510 BC after its southern rival colony, Kroton, moreover, a town dating to the most exciting had destroyed it (Strabo VI.1.13), seems at first Archaic period in Magna Graecia. Even the well- sight no less fabulous than these tales. A ‘Sodom known temples from this period at Paestum were, and Gomorrah’ ending is a good way to enhance after all, only constructed by a town dependent on such stories with a sense of impending doom. -

1 Paola Zancani Montuoro
1 Paola Zancani Montuoro (1901 - 1987) by Licia Vlad Borrelli Before the unification of Italy, Naples had been the great capital of a kingdom and, up to the end of the nineteenth-century, it was considered the second most important city in Europe after Paris. The signs of this ancient prestige were still visible in the first decades of this century. A pleasure-seeking aristocracy occupied its splendid palaces with Spanish-like splendour, while an enlightened bourgeoisie produced an independent culture and established relationships with the most advanced intellectual movements north of the Alps. Benedetto Croce united the tradition of a Neapolitan philosophical school that was open to the lesson of Hegel with his “philosophy of the spirit.” Generations of young scholars would nourish themselves from his teachings and his home would become a meeting place for free spirits during the Fascist era. At the same time, brilliant journalists endowed with strong and assertive personalities like Eduardo Scarfoglio and Matilde Serao, founded newspapers, fought political battles, and highlighted the vices and virtues of city life. The painters of the school of Posillipo, poets like Salvatore di Giacomo, and actors like Eduardo Scarpetta and later the De Filippo brothers, depicted the images of a Neapolitan reality that would soon be canceled by urban demolition programs and the ravages of war, or would be weakened by the transformation of Italy at the hands of the Piedmontese and by the subsequent homologation of customs. This was the ambience, full of lively cultural ferment, into which Paola Zancani Montuoro was born in Naples on February 27, 1901. -

In Fascist Italy
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/79374 Please be advised that this information was generated on 2021-09-28 and may be subject to change. Anabases 9 (2009) varia ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Nathalie de Haan The “Società Magna Grecia” in Fascist Italy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Avertissement Le contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de l'éditeur. Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue, l'auteur et la référence du document. Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable -

Envisioning the Unseen: Sisyphos in Chthonic Landscapes Elizabeth Graff Olw Fson Washington University in St
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship All Theses and Dissertations (ETDs) Spring 5-1-2013 Envisioning the Unseen: Sisyphos in Chthonic Landscapes Elizabeth Graff olW fson Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/etd Part of the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Recommended Citation Wolfson, Elizabeth Graff, "Envisioning the Unseen: Sisyphos in Chthonic Landscapes" (2013). All Theses and Dissertations (ETDs). 1114. https://openscholarship.wustl.edu/etd/1114 This Thesis is brought to you for free and open access by Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in All Theses and Dissertations (ETDs) by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS Department of Art History and Archaeology Envisioning the Unseen: Sisyphos in Chthonic Landscapes by Elizabeth Graff Wolfson A thesis presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts May 2013 St. Louis, Missouri © 2013, Elizabeth Graff Wolfson. TABLE OF CONTENTS Acknowledgements iii Dedication iv Introduction 1 Chapter 1: Sisyphos in Literature 7 Chapter 2: Sisyphos in Art 25 Sisyphos on the Greek Mainland (Black-Figure, ca. 565-470) 26 Sisyphos on the Greek Mainland (Other Media, ca. 500-430 BCE) 37 Sisyphos in South Italy and Etruria (ca. 4th-1st century BCE) 48 Conclusions 67 Chapter 3: Sisyphos the “Scene Setter” 68 Abbreviations 81 Bibliography 82 List of Plates 85 Plates 91 ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank the Graduate School of Arts and Sciences, the Department of Art History and Archaeology, and the Visual Resources Curator Betha Whitlow for providing me with financial support throughout my two years at Washington University. -

Magna Grjecia Archeologia Di Un Sapere
MAGNA GRJECIA ARCHEOLOGIA DI UN SAPERE Catanzaro, Complesso Monumentale di San Giovanni 19 giugno - 31 ottobre 2005 SOMMARIO .. 19 Il viaggio del sapere. Magna Graecia tra università e mostra Salvatore Venuta 23 Magna Graecia: ragioni di una mostra Salvatore Settis 29 Introduzione Giovanni Pugliese Carratelli 33 Megale Hellas, Magna Graecia, Italia: dinamiche di nomi Federica Cordano 41 L'immagine della Magna Grecia nella geografia antica Francesco Prontera 49 La Magna Grecia, tra archeologia e storia Carmine Ampolo 59 Dalla Grecia all'Italia: movimenti antichi, tradizioni moderne e qualche revisionismo recente Emanuele Greco 65 Da Napoli alla Calabria, tra antiquaria e viaggio, leggendo casi esemplari Maria Cecilia Parra 72 Cronologia antica Anna Magnetto 83 Le principali tappe della riscoperta della Magna Grecia in età moderna Ilaria Cavazzuti I. L'inizio della storia 88 Le Tavole di Eraclea, la scoperta e l'edizione del Mazzocchi Carmine Ampolo 91 Tavole di Eraclea: aspetti storici ed epigrafici Maria Letizia Lazzarini 95 William Hamilton e la diffusione in Europa della moda dei vasi greci Andrea Milanese, Stefano De Caro 101 L'attività di Bonucci a Canosa Marisa Corrente 108 Le antichità della collezione Caroline Murat Claude Pouzadoux 113 Considerazioni intorno al Museo Santangelo Andrea Milanese • ll 7 Dalla collezione famigliare al Museo Nazionale Jatta di Ruvo Claude Pouzadoux 121 Primi scavi archeologici a Paestum Marina Cipriani, Giovanni Avagliano 133 Ricerche intorno a Sibari: da Cavallari a Zanotti Bianco Pier Giovanni Guzzo 140 La religiosità salvifica in Magna Grecia fra testo e immagini Angelo Bottini 150 "Medaglie, monete e vasi di gran pregio": la collezione Capialbi di Vibo Valentia Maurizio Paoletti 156 La collezione numismatica "Vito Capialbi" di Vibo Valentia Giorgia Gargano 165 Taranto: dal saccheggio alla tutela Enzo Lippolis 185 La Magna Grecia nella cartografia storica: dalla riscoperta di Tolomeo a Luca Holstenius Francesco Prontera II.