Annales Oratorii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
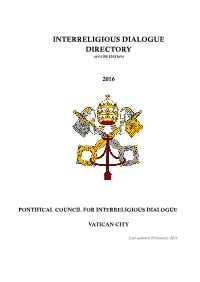
Interreligious Dialogue Directory 2016
INTERRELIGIOUS DIALOGUE DIRECTORY (ON-LINE EDITION) 2016 PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE VATICAN CITY Last updated 20 January 2016 INDEX PCID EXECUTIVE STAFF MEMBERS CONSULTORS COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH MUSLIMS ALPHABETICAL LIST OF THE NATIONAL EPISCOPAL INTERRELIGIOUS DIALOGUE COMMISSIONS ALBANIA ANGOLA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BANGLADESH BELARUS BELGIUM BOLIVIA BOSNIA HERZEGOVINA BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBODIA CAMERUN CANADA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CHAD CHILE COLOMBIA CONGO-BRAZZAVILLE ECUADOR EGYPT EQUATORIAL GUINIEA ETHIOPIA FRANCE GERMANY GUATEMALA GUINEA (REPUBLIC OF) GUYANA INDIA INDONESIA IRAQ IRELAND ISRAEL ITALY IVORY COAST JAPAN KAZAKHSTAN KENYA KOREA LA REUNION LEBANON LESOTHO MALAYSIA MALI MALTA MAURITIUS MEXICO MOZAMBIQUE MYANMAR NETHERLAND NEW ZEALAND NICARAGUA NIGERIA NORWAY PAKISTAN PAPUA NEW GUINEA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND ROMANIA SALVADOR SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE S LOVA K I A SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SUDAN SURINAME SWEDEN SYRIA TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY UGANDA UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VIETNAM ZIMBABWE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE (PCID) Instituted by Pope Paul VI on 19th May 1964 under the name of “Secretariat for non-Christians” (Secretariatus pro non Christianis) and later renamed “Pontifical Council for Interreligious Dialogue” (Pontificium Consilium pro Dialogo inter Religiones) in the Apostolic Constitution on the Roman Curia Pastor Bonus of 28th June 1988, the PCID promotes the Church’s Dialogue with other religions as promulgated in the Declaration Nostra Aetate of Vatican Council II, favouring and orienting the Church’s relationship with members and groups of those religions that are not included under the Christian name and also with those who have in some way a religious sense. -

Acta Apostolicae Sedis
An. et vol. CIX 7 Iulii 2017 N. 7 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA FRANCISCI PP. CONSISTORIA Consistorium Ordinarium Publicum pro novis Cardinalibus creandis. « Gesù camminava davanti a loro ». Questa è l’immagine che ci viene dal Vangelo che abbiamo ascoltato (Mc 10, 32-45), e che fa da sfondo anche all’atto che stiamo compiendo: un Concistoro per la creazione di alcuni nuovi Cardinali. Gesù cammina decisamente verso Gerusalemme. Sa bene che cosa lo attende e ne ha parlato più volte ai suoi discepoli. Ma tra il cuore di Gesù e i cuori dei discepoli c’è una distanza, che solo lo Spirito Santo potrà col- mare. Gesù lo sa; per questo è paziente con loro, parla loro con franchezza, e soprattutto li precede, cammina davanti a loro. Lungo il cammino, i discepoli stessi sono distratti da interessi non coerenti con la “direzione” di Gesù, con la sua volontà che è un tutt’uno con la volontà del Padre. Ad esempio – abbiamo sentito – i due fratelli Giacomo e Giovanni pensano a come sarebbe bello sedere alla destra e alla sinistra del re d’Israele (cfr v. 37). Non guardano la realtà! Credono di vedere e non vedono, di sapere e non sanno, di capire meglio degli altri e non capiscono… La realtà invece è tutt’altra, è quella che Gesù ha presente e che guida i suoi passi. La realtà è la croce, è il peccato del mondo che Lui è venuto a prendere su di sé e sradicare dalla terra degli uomini e delle donne. -

Bishop Barron the Faith, He Deep-Dish Chicago Pizza, Satisfying Like, Say, Tively Said
Catholic Volume 34 No. 23 www.biloxidiocese.org July 14, 2017 Vatican asks bishops to ensure validity of matter for Eucharist BY CAROL GLATZ Eucharist,” it said, “is a grave abuse.” Catholic News Service -- Low-gluten hosts are valid matter for people who, “for varying and grave reasons, cannot consume bread VATICAN CITY (CNS) -- Bishops should look at made in the usual manner,” provided the hosts “contain ways to help verify and guarantee the validity and wor- a sufficient amount of gluten to obtain the confection of thiness of the bread and wine used for the celebration of bread without the addition of foreign materials and with- the Eucharist, the Vatican said in a recent document. out the use of procedures that would alter the nature of Because bread and wine for the Eucharist are no lon- bread.” ger supplied just by religious communities, but “are also -- Completely gluten-free hosts continue to be “inval- sold in supermarkets and other stores and even over the id matter for the celebration of the Eucharist.” internet,” bishops should set up guidelines, an oversight -- Wine used in the celebration of the eucharistic body and/or even a form of certification to help “remove “must be natural, from the fruit of the grape, pure and any doubt about the validity of the matter for the incorrupt, not mixed with other substances,” well con- Eucharist,” the Vatican’s Congregation for Divine Atlanta Archbishop Wilton D. Gregory, right, served and have not soured. “Convocation of Worship and the Sacraments said. concelebrates Mass during the -- “It is altogether forbidden to use wine of doubtful Catholic Leaders: The Joy of the Gospel in America” The recommendations came in a circular letter, “On authenticity or provenance.” the bread and wine for the Eucharist,” sent to diocesan July 2 in Orlando, Fla. -

Le Rapport Église-Monde Dans Les Interventions Des Évêques D'afrique Noire Aux Assemblées Du Synode Des Évêques De 1967 À 2009
Le rapport Église-monde dans les interventions des évêques d'Afrique noire aux Assemblées du Synode des évêques de 1967 à 2009 Thèse Alain Patrick David Doctorat en théologie Philosophiæ doctor (Ph. D.) Québec, Canada © Alain Patrick David, 2015 RÉSUMÉ Quelle conception du rapport Église-monde émerge des interventions des évêques d’Afrique noire aux Assemblées du Synode des évêques tenues entre 1967 et 2009? Telle est la question que cherche à élucider la présente étude. Il s’agit, d’une part, de procéder à une étude des interventions des évêques et, d’autre part, de comprendre la vision que ceux- ci ont de l’Église et de sa relation avec le monde dans lequel elle vit et avec qui elle cherche à dialoguer. La modalité du dialogue avec le monde se pose et elle est à préciser. Dans un premier temps, l’enracinement de cette recherche théologique et ecclésiologique est celui d’un acte de lecture. Le travail de constitution et de présentation du corpus, de même que l’interrogation du contexte de l’Afrique contemporaine et du contexte ecclésial de l’Église d’Afrique comme lieu d’énonciation de la parole épiscopale, ont disposé et conduit à l’analyse des interventions des évêques à partir d’une relation, celle de l’Église au monde. Dans un deuxième temps, par une traversée de l’ensemble du corpus, les éléments recueillis ont été redéployés en vue d’un essai de l’ecclésiologie qui se profile à l’analyse des interventions des évêques d’Afrique subsaharienne. Pour y parvenir, nous avons travaillé successivement la problématique de la relation Église-monde à Vatican II et dans les interventions des évêques africains pour enfin, dégager les principaux modèles ecclésiologiques auxquels ceux-ci recourent. -

Father Michael Smith Dies Atlanta Province Bishops See Record Growth
The Official Newspaper of the Diocese of Savannah Vol. 97, No. 14 Thursday, July 6, 2017 Put Faith in Your Opinions southerncross.diosav.org $.75 Father Michael Smith dies ather Michael H. Smith, 78, a Saint Matthew Church in Statesboro and nephews and many cousins; and his Fpriest of the Diocese of Savannah Saint Boniface Church in Springfield brother priests, especially Father Tom for 51 years, died at Ogeechee from 1988 to 1997, and pastor of Holy Nellis and members of the Jesus Caritas Area Hospice in Statesboro early Redeemer Church in McRae and its fraternity. Wednesday, June 21. mission, Saint Mark Church in Eastman A Funeral Mass was celebrated at Ordained in 1966, he had been liv- from 1997 to 2001. noon on Thursday, June 29, at Saint ing in retirement in Statesboro since He retired after serving as pastor Matthew’s. Bishop Hartmayer was the 2007. of Immaculate Conception Church celebrant and Father Tom Nellis was the He began his priestly service as an in Moultrie and Saint John Vianney homilist. assistant pastor at Blessed Sacrament Mission in Camilla from 2001 to 2007. Memorials may be made to ICMC, an Parish in Savannah. During the period He was preceded in death by his par- international Catholic organization serv- from 1968 to 1979 he served as direc- ents, Walter and Anna Heffernan Smith, ing the needs of refugees and migrants; tor of the Department of Christian and his brother David Smith. Ogeechee Area Hospice, or St. Matthew Formation and the director of Camp Survivors include his sister and broth- Catholic Church in Statesboro, where Villa Marie in Savannah. -

Christmas 2015 a ‘Charade’ I Holy Father Cannot Reconcile Marking Christ’S Birth and Peace on Earth When the World Is at War by Daniel Harkins
Supporters flock Richard Purden to Glasgow questions Celtic Mary’s Meals over austerity open day. stance of board Pages 12-13 SUPPORTING 50 YEARS OF SCIAF, 1965-2015 member. Page 16 No 5648 VISIT YOUR NATIONAL CATHOLIC NEWSPAPER ONLINE AT WWW.SCONEWS.CO.UK Friday November 27 2015 | £1 Pope: Christmas 2015 a ‘charade’ I Holy Father cannot reconcile marking Christ’s birth and peace on earth when the world is at war By Daniel Harkins POPE Francis fears the festivities of Christmas will be a ‘charade’ this year as the ‘whole world is at war,’ rejecting the ‘path of peace,’ so that ‘Jesus Himself weeps.’ The Pope’s powerful announcement was made during Mass at Casa Santa Marta in the Vatican last week, and came after the terrorist attacks in Paris that killed 130 people on November 13, as an increasingly complex war rages on in Syria and tensions build in Africa, where he arrived on Wednesday to visit Kenya, Uganda and the Central African Republic. “Today Jesus weeps as well, because we have chosen the way of war, the way of hatred, the way of enmities,” the Holy Father said, following a recounting of Jesus crying as He approached Jerusalem. “We are close to Christmas: there will be lights, there will be parties, bright trees, even Nativity scenes—all decked out—while the world continues to wage war. The world has not understood were martyred during the Spanish Civil War in the the way of peace.” 1930s. “They were priests, young professed friars On Sunday, the Pope will arrive in the Central awaiting ordination, and lay brothers belonging to African Republic, the first time he has visited an the Capuchin Order of Friars Minor: let us entrust active war zone. -

Announcement of Consistory on 28 June for the Creation of New Cardinals
N. 170521b Sunday 21.05.2017 Announcement of Consistory on 28 June for the creation of new cardinals Words of the Holy Father Brief biographies of the cardinals to be created Words of the Holy Father During today’s Regina Coeli, the Holy Father Francis announced that a Consistory will take place for the creation of new cardinals. The following are the Pope’s words: I wish to announce that on Wednesday 28 June a Consistory will be held to appoint five new Cardinals. Their provenance from different parts of the world manifests the catholicity of the Church, which reaches all around the earth, and the assignment of a title or a diaconate in the city expresses the Cardinals’ belonging to the diocese of Rome that, according to the well-known expression of Saint Ignatius, presides in charity over all the Churches. And on Thursday 29 June, Solemnity of the Holy Apostles Peter and Paul, I will concelebrate Holy Mass with the new Cardinals, with the College of Cardinals, with the new Bishops, the Metropolitans, the Bishops and some presbyters. Here are the names of the new cardinals: 1. His Excellency Msgr. Jean Zerbo, archbishop of Bamako, in Mali; 2. His Excellency Msgr. Juan Jose Omella, archbishop of Barcelona, Spain; 3. His Excellency Msgr. Anders Arborelius, O.C.D., bishop of Stockholm, Sweden; 2 4. His Excellency Msgr. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, titular bishop of Acque Nuove di Proconsolare, apostolic vicar of Pakse, in Laos; and 5. His Excellency Msgr. Gregorio Rosa Chavez, titular bishop of Mulli, auxiliary of the archdiocese of San Salvador, El Salvador. -

Benedict, Me and the Cardinals Three Pdf, Epub, Ebook
BENEDICT, ME AND THE CARDINALS THREE PDF, EPUB, EBOOK William Meredith Morris | 437 pages | 30 Jun 2014 | ATF Press | 9781921511417 | English | Hindmarsh, SA, Australia Benedict, Me and the Cardinals Three PDF Book Yet as I looked at the man more closely, I saw that it was definitely him. Maybe his plans had changed again. Can I view this online? Archived from the original on 15 October Prefect emeritus of the Congregation for the Clergy. I had heard that he is a gossip, a social operator whose calendar is a blur of drinks and dinners with cardinals and archbishops, principessas and personal trainers. James Francis". The Vatican holds secrets so tightly that it can make Fort Meade look like a sloppy drunk. Marco Politi speculates that perhaps as many as 30 were eased out. During an impromptu press conference aboard the papal jet, en route from Rio de Janeiro to Rome after his first overseas trip, Francis was asked about the so-called gay lobby. The term could refer to a shadowy group like the Illuminati, whose members quietly exercise supreme power. Whether he received this privileged access from some friend or family member, or from a client, is impossible to say; to see a known rent boy in black leather on a private Vatican balcony does raise an eyebrow. Some such stories are better substantiated than others. Arlindo Gomes Furtado. Oswald Gracias. Prefect emeritus of the Congregation for the Causes of Saints. Aquilino, C. Archbishop emeritus of Khartoum. The book details the background and events which led to my being asked by Pope Benedict XVI to resign as Bishop of Toowoomba when I had a meeting with him in Rome on the 4th of June Denunciation and exposure have made gay priests figures of fascination—though less as people than as symbols— especially to the secular far left and the religious far right. -

GV Netzband KP
A Security (15 USC) A US SEC Tracer Flag Not a point of Law Verpflichtungserklärung/Kommerzielles Pfandrecht RH 40 498 019 3DE (Dies ist eine tatsächliche Darstellung der Fakten) Maximen: Alle Männer und Frauen wissen, dass das Fundament des Gesetzes und Handels im Spre- chen der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der Wahrheit besteht. Die Wahrheit als ein gültiger Ausdruck der Realität ist souverän im Handel/Kommerz. Eine unwiderlegte und beeidigte Erklärung gilt als Wahrheit im Kommerz. Eine unwiderlegte und beeidigte Erklärung steht als das Urteil im Handel/Kommerz. Alle Menschen sollen ein garantiertes Rechtsmittel durch den festgeschriebenen Kurs des Gesetzes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert, oder wenn das vorhandene Rechts- mittel unterwandert ist, dann muss man aus Notwendigkeit ein Rechtsmittel in seinem Sinne schaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen Erklärung unter Eid unterlegt ist. Ein Gesetz zu ignorieren könnte entschuldigt werden, aber es ist kein gültiger Grund für das Be- gehen eines Verbrechens, wenn das Gesetz für Jedermann leicht zugänglich ist, der eine angemessene Anstrengung unternimmt, sich über jene Gesetze zu informieren. Das ganze „Corporate Government“ basiert auf kommerziellen und beeidigten Erklärungen, kommerziellen Versicherung, kommerziellen Pfandrechten und „commercial distress“, folg- lich haben Regierungen keine delegierten Rechte, kommerzielle Prozesse aufzuheben. Die rechtmäßige politische Macht eines Firmenobjekts ist unbedingt von dessen Besitz einer kommerziellen Versicherung gegen öffentlichen Schaden abhängig, denn es gilt: keine Versicherung - keine Verantwortung, welches gleichzusetzen ist mit der Ungültigkeit einer offiziellen Unterschrift, was gleichzusetzen ist mit dem Fehlen einer wirklichen politi- schen Macht des Firmenobjekts, was gleichzusetzen ist mit dem Fehlen von delegierten Rechten nach Statuten als Firmenstütze zu arbeiten. -

Pope Francis Said
Paul, Silvanus, and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, OCTOBER 18, 2020 constantly mentioning you in our prayers, TERHAD remembering before our God and Father PP 8460/11/2012(030939) your work of faith and labour of love and ISSN: 1394-3294 steadfastness of hope in Vol. 27 No. 41 THE CATHOLIC WEEKLY our Lord Jesus Christ. 1 Thes. 1:1-3 Pope’s Nun lend Blessed Carlo Encyclical their Acutis is a echoes building to model for Asian Pope for young people realities refugees to put God first P3 & 10 P5 P16 Time is running out to fix economy, protect the Earth, help the poor ATICAN: The predomi- in taking action. nant global economic sys- “As the term ‘countdown’ suggests, we must act urgently,” Pope Francis said. “Each Vtem is “unsustainable,” one of us can play a valuable role if we all set particularly in its impact on the en- out today — not tomorrow, today.” vironment, Pope Francis said. “Science tells us, every day more precisely, “We are faced with the moral imperative that we need to act urgently — I am not exag- — and the practical urgency — to rethink gerating — this is what science tells us, if we many things” about the economy: “how we are to have any hope of avoiding radical and produce, how we consume, our culture of catastrophic climate change,” he said. “This waste, its short-term vision, the exploitation is a scientific fact.” of the poor, indifference toward them, the As he did in his 2015 encyclical letter, increase of inequality and its dependence on “Laudato Si’, on Care for Our Common harmful energy sources,” the Pope said Oct Home,” Pope Francis insisted in his TEDx 10 as part of the global TEDx Countdown on talk that concern for the environment must go climate change. -

La Sombra De La Pederastia En La Iglesia Católica
CONTENIDOS 2 6 DE JUNIO AL 2 DE JUL IODE2017 BOLETÍN # 219 TEMA DE LA SEMANA: LA SOMBRA DE LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA ........................................ 4 1. El jefe de Finanzas del Vaticano, acusado en Australia de abusos sexuales contra niños ................................................... 4 2. El Vaticano respalda a su responsable de finanzas, acusado de abusos .............................................................................. 4 3. Acusan de pederastia a cardenal tesorero del Vaticano ...................................................................................................... 5 4. Papa reduce a estado laico a “Don Mercedes”, el cura pedófilo ......................................................................................... 5 5. Pell deja la Secretaría de Economía y regresa a Australia para defenderse de las acusaciones de abusos a menores ....... 6 6. Orgía y drogas en el Vaticano .............................................................................................................................................. 7 7. Pell comparecerá ante los tribunales de Melbourne el próximo 26 de julio ....................................................................... 7 8. La Iglesia australiana no pagará la defensa del cardenal Pell .............................................................................................. 8 9. ¿Homosexualidad y homofobia en el Vaticano? ................................................................................................................. -

2. Acts of the 16 Th Plenary Assembly Of
PROGRAMME MONDAY 8TH JULY 2013: ARRIVAL A- WORKSHOP ON THE THEME TUESDAY 9TH - THURSDAY 11TH JULY TUESDAY 9TH JULY 2013 07H00 Morning Prayer (privately) 07H30 Breakfast 08H30 – 09H30: Opening Mass 09H30 – 10H00: Break 10H00 – 11H30: Opening Ceremony ▪ Opening Prayer ▪ Speeches and Goodwill messages 1. President of the National Episcopal Conference of Congo 2. Apostolic Nuncio in DRC 3. Congregation for the Evangelisation of the Peoples 4. Message from the Holy Father M U S I C A L I N T E R L U D E 5. Other speakers (cf. Programme of the opening ceremony for more details) 6. SECAM President 7. President of the Democratic Republic of Congo Group Photo 11H30 – 12H00: Break 12H00 – 12H45: Keynote Address by Cardinal Christian TUMI and free discussions 12H45 Closing Prayer and Blessing 13H00 – 15H00: Lunch and Break 15H00 – 16H30: Talk: «Continuity between Ecclesia in Africa and Africae Munus» by Cardinal Laurent MONSENGWO PASSINYA 16H30 – 17H00: Coffee Break 17H00 – 18H30: Presentation by Facilitators and Workshops 18H30 – 19H30: Groups reports and discussions in Plenary 1 19H30 Vespers 20H00 Dinner WEDNESDAY 10TH JULY 2013 07H00 Mass with Lauds 08H00 – 08H30: Breakfast 09H00 – 10H30: Talk: «Role of the ‘Truth and Reconciliation’ Commissions in the light of Africae Munus» by Bishop Matthew Hassan KUKAH 10H30 – 11H00: Coffee Break 11H00 – 12H30: Workshops 12H30 – 12H45: Midday prayer 13H00 – 15H00: Lunch and Break 15H00 – 16H30: Talk: «Socio-political movements in Northern Africa and the Interreligious dialogue» by Bishop George CHIHANE 16H30 – 17H00: Coffee Break 17H00 – 18H30: Presentation by Facilitators and Workshops 18H30 – 19H45: Groups Reports and discussions in Plenary First reading of the resolutions and recommendations on Reconciliation, Justice and Peace in Africa.