ALBUM Pennino.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Discovery Marche.Pdf
the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

River Bed Changing in the Lower Potenza Valley (Mid-Adriatic Italy
Z. Geomorph. N.F. 53 Suppl.River 1 bed 83 changing ^ 98 Berlin ´ Stuttgart Juni 2009 83 River bed changing in the lower PotenzaValley (mid-Adriatic Italy). A geo-archaeological approach to historical documents Prof. Dr. Cristina Corsi , Prof. Dr. Morgan De Dapper and Prof. Dr. Frank Vermeulen with 11figures Summary. This paper presents the results of an integrated survey project aiming to achieve the diachro- nic reconstruction of changes in river beds during historical times in the PotenzaValley, in mid-Adriatic Italy. Here intensive surveys are being carried out by a team from Ghent University (dir. F.Vermeulen), especially in and around the Roman colony of Potentia, at the mouth of the river. They are aimed at studying occupation history and the relationship man-landscape in this valley between the Apennines and the Adriatic Sea. Interdisciplinary approaches include low altitude aerial photography, systematic archaeological field walking, artefact studies, re-study of excavated evidence, detailed geomorphologic field mapping, geophysical surveys and fine topographic mapping. Thanks especially to active oblique and vertical aerial photography, geomorphologic fieldwork and corings it is now possible to reconstruct a complete frame of the important changes that have affected the river bed during the last two millennia. The archaeological evidence concurs explicitly with the environmental data to understand and deter- mine the general timing of this evolution, allowing us to measure the interaction between mankind and environment through -

Potenza Picena Porto Potenza&
POTENZA PICENA PORTO POTENZA& Al centro delle marche, al mare e in collina. proloco BANDIERA BLU 2 3 INDICE INDEX IL BORGO e L’ARTE 04 MAREeVACANZA 14 ENOGASTRONOMIA 20 EVENTIeTRADIZIONI 24 Una città ricca d’arte, al centro delle Marche, dove le dolci colline scivolano verso il mare. SPORTeRELAX 28 A town rich in art, in the center of the Marche region, where the sweet hills drift to the sea. ILTERRITORIO 31 4 5 IL BORGOthe OLD VILLAGE Marche, nella provincia di Macerata. Nell’età comunale si chiamava Monte Santo, in virtù delle ben 27 chiese all’interno del centro storico, ma dopo l’Unità d’Italia (1862) si aggiun- se al nome ‘Potenza’, recuperato da quello della limitrofa antica città romana di Potentia, l’aggettivo ‘Picena’, per riallacciarsi idealmente al locale popolo protostorico dei Piceni. La più antica notizia riguardante la città è del 947 d.C. e testimonia l’esistenza della pieve di Santo Stefano demolita nel 1796 e corrispon- dente all’odierna Piazza Matteotti, la principale della città. The town is placed on a hill at 237 meters above the sea level. City of art and seaside town, it stands out for its sweet and scenic landscapes drifting to the Adriatic sea, where Porto Potenza is located. The town, embellished with the rural villages of San Girio and Montecanepino, counts more than 16.000 citizens and is located right in the center of the Marche region, in the county of Macerata. During the period of the medieval city-republic its name was Monte Santo, due to the good 27 chur- ches located within the historical center, but soon after the Unification of Italy (1862) to Potenza, name recovered from the adjacent ancient Roman town of Potentia, was added the adjective Picena, A sinistra, la scalinata di Via Trento. -

Il Bacino Del Fiume Potenza Rientra All’Interno Delle Tavolette 1:25000 Numero
STU D IO ID RA U LIC O -A M BIEN TA LE M ED IA N TE L’A N A LISI D EI PRO C ESSI G EO M O RFO LO G IC I IN A TTO PER LA C A RA TTERIZZA ZIO N E D EI BA C IN I ID RO G RA FIC I PRIN C IPA LI D ELLA REG IO N E M A RC H E G IU G N O 2018 IL BACIN O D EL FIU M E PO TEN ZA Responsabile per gli aspetti geologici: Soggetto attuatore Geol. M aurizio Consoli Responsabile per gli aspetti paesaggistico terrritoriali: Arch. Andrea Renzi Responsabile per gli aspetti biologici: D ott. Paolo Perna, Responsabile per la parte gli aspetti s.r.l. ........................... Società di Ingegneria inform atici e GIS: D ott. D anilo Procaccini Consulente scientifico per la parte CO O RD IN AM EN TO E clim atologica: D IREZIO N E TECN ICA: Prof. Carlo Bisci Geol. M aurizio Consoli Colloboratrice: Francesca M onaldi Studio idraulico-ambientale mediante l’analisi dei processi geomorfologici in atto per la caratterizzazione dei bacini idrografici principali delle marche (Atto integrativo alla convenzione sottoscritta in data 27.03.2018 tra il Consorzio di Bonifica delle Marche e la Società Terre.it Srl.) s.r.l. 1 Studio idraulico-ambientale mediante l’analisi dei processi geomorfologici in atto per la caratterizzazione dei bacini idrografici principali delle marche (Atto integrativo alla convenzione sottoscritta in data 27.03.2018 tra il Consorzio di Bonifica delle Marche e la Società Terre.it Srl.) Sommario 1 Caratterizzazione bacino idrografico .............................................................................. -

Asse Viario Marche-Umbria E Quadrilatero Di Penetrazione Interna
ALLEGATO 3 ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1° MAXILOTTO – 2° stralcio: 2^ parte Intervallive di Macerata e di Tolentino – San Severino Marche (Progetti preliminari) Parte A – Prescrizioni - Prescrizioni comuni alle intervallive di Macerata e di Tolentino – San Severino Marche - Prescrizioni specifiche per l’intervalliva di Macerata - Prescrizioni specifiche per l’intervalliva di Tolentino – San Severino Marche Parte B – Raccomandazioni PARTE A - PRESCRIZIONI: Comuni alle due infrastrutture 1) Prevedere il restauro paesaggistico del territorio, a bilanciamento del danno che sotto questo profilo l’opera recherà comunque a un territorio con forte sedimentazione storica. I relativi interventi compensativi e mitigativi siano progettati con l’utilizzo appropriato di fasce di ambientazione (in particolare nelle aree di sfrido) ad incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, di fasce boscate per mantenere e potenziare la continuità dei corridoi ecologici (in corrispondenza dei corsi d’acqua), con la creazione di coni visivi in corrispondenze di beni di valore storico, architettonico, ambientale, ecc. 2) Produrre le necessarie verifiche in rapporto alle relazioni con i flussi interessanti la rete viaria locale individuando gli interventi compensativi sugli impatti che in particolare siano volti a potenziare la viabilità di adduzione ai poli produttivi, i parcheggi, ecc. 3) Individuare e quantificare i materiali inerti derivanti dalla realizzazione delle gallerie e loro destinazione (reimpiego in loco, recuperi ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 ecc.). Devono essere forniti i codici CER delle varie tipologie di materiali. 4) Individuare eventuali cave di prestito necessarie in relazione a quanto previsto nel Piano Provinciale delle Attività Estrattive. -

TRATTE CONTRAM MOBILITA' DA a TARIFFA Via ABBADIA DI FIASTRA
TRATTE CONTRAM MOBILITA' DA A TARIFFA Via ABBADIA DI FIASTRA CAMERINO 8 ABBADIA DI FIASTRA CINGOLI 7 ABBADIA DI FIASTRA CIVITANOVA MARCHE 6 ABBADIA DI FIASTRA MACERATA 2 ABBADIA DI FIASTRA PASSO COLMURANO 2 ABBADIA DI FIASTRA S.GINESIO 5 ABBADIA DI FIASTRA SARNANO 6 ABBADIA DI FIASTRA TOLENTINO 3 ACQUACANINA BOLOGNOLA 1 ACQUACANINA CAMERINO 6 ACQUACANINA MACERATA 10 ACQUAPAGANA CAMERINO 6 ACQUOSI CAMERINO 3 ACQUOSI CASTELRAIMONDO 2 ACQUOSI FABRIANO 5 ACQUOSI MATELICA 1 AGOLLA CAMERINO 4 AGOLLA SAN SEVERINO 5 ALBACINA CAMERINO 6 ALBACINA CASTELRAIMONDO 4 ALBACINA CERRETO D'ESI 1 ALBACINA CUPRAMONTANA 5 ALBACINA ESANATOGLIA 4 ALBACINA FABRIANO 2 ALBACINA FIUMINATA 6 ALBACINA MATELICA 2 ALBACINA SAN SEVERINO 6 ALBACINA SERRA S.QUIRICO STAZ. 3 AMANDOLA ANCONA 14 AMANDOLA CAMERINO 9 AMANDOLA CAMERINO 10 TOLENTINO AMANDOLA COMUNANZA 2 AMANDOLA GABELLA NUOVA 3 AMANDOLA GUALDO 4 AMANDOLA LOC. S.CROCE BV S.GINESIO 4 AMANDOLA MACERATA 9 AMANDOLA PASSO RIPE 5 AMANDOLA PASSO S.GINESIO 6 AMANDOLA PERUGIA 17 AMANDOLA POLLENZA 10 AMANDOLA RUSTICI 1 AMANDOLA S.GINESIO 5 AMANDOLA S.GINESIO 6 MONTEFORTINO AMANDOLA San Venanzo - Monte San Martin 2 AMANDOLA SARNANO 2 AMANDOLA TOLENTINO 6 AMANDOLA VECCIOLA 3 ANCONA AMANDOLA 14 ANCONA CAMERINO 15 ANCONA CAMPOROTONDO 12 ANCONA CASTELRAIMONDO 13 ANCONA CINGOLI 11 ANCONA COMUNANZA 15 ANCONA CORRIDONIA 10 ANCONA ESANATOGLIA 14 ANCONA M.S. GIUSTO 11 ANCONA MACERATA 9 ANCONA MATELICA 13 ANCONA MOGLIANO 11 ANCONA MONTECASSIANO 7 ANCONA MONTEFANO 6 ANCONA MUCCIA 14 ANCONA OSIMO AUTOSTAZIONE 4 ANCONA PASSATEMPO 5 ANCONA -

Mama Box for Your Stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese Mama Box Marca Maceratese
A box of ideas MaMa Box for your stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese MaMa Box Marca Maceratese A box of ideas for your stay in the Marca Maceratese Lago di Fiastra - photo by Federica Baldi 2 Index Guide to MaMa box ................................ 7 Thematic areas ................................ 8 Marca Maceratese Portal ...............................11 MaMa in blue .............................. 13 The sea ................................. 14 MaMa sea ................................. 20 Water parks ................................. 25 Thermal baths ................................. 26 MaMa’s tips ................................. 27 Web experiences ................................. 28 Gentle hills and ancient villages .............................. 31 The most beautiful villages of Italy ................................. 32 / i"À>}iy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{x -«iÃ>`Àiiy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{n The ancient villages ................................. 54 Fortresses and towers ................................. 58 MaMa’s tidbits ................................. 64 MaMa’s tips ................................. 69 Web experiences ................................. 70 MaMa mia what a show! .............................. 73 Mountain, parks, sports and active nature .............................. 97 National Park of Sibillini Mountains ................................. 98 Centres of Environmental Education ................................100 Natural reserves ................................102 Lakes ................................104 -

Valutazione Sullo Stato Di Salute Della Popolazione Di Potenza Picena E
Dipartimento di Ancona Agenzia Regionale Sanitaria Osservatorio Epidemiologico Servizio Epidemiologia Ambientale Osservatorio Epidemiologico Regionale Ambientale delle Marche VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI POTENZA PICENA E COMUNI LIMITROFI Viale Cristoforo Colombo, 106 - 60127 ANCONA Tel. +39 07128732760 - Fax +39 07128732761 1 email: [email protected] COMMITTENTI Comune di Potenza Picena (MC) Nota Ufficio del Sindaco prot. n. 21894 del 02/11/2012 ENTI PARTECIPANTI Osservatorio Epidemiologico Ambientale (OEA) Servizio Epidemiologia Ambientale (SEA) del Dipartimento prov.le di Ancona Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Marche RICERCATORI/CO-RICERCATORI Dr. Mauro Mariottinia Dr. Fabio Filippettib Dr. Marco Baldinia Dr.ssa Katiuscia Di Biagioa Dr.ssa Silvia Bartolaccia Dr. Thomas V. Simeonia a ARPAM - OEA-SEA Dipartimento prov.le di Ancona – Via C. Colombo, 106 – Ancona b ARS Marche – OER Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona DATA REDAZIONE: FEBBRAIO 2013 Valutazione dello stato di salute della popolazione di Potenza Picena…. SOMMARIO PUBLIC SUMMARY ...................................................................................................................................................... V INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................ V CONTROLLO AMBIENTALE -

Geo-Archaeological Implications of River and Coastal Dynamics at the Potenza River Mouth (The Marches, Italy)
GEO -ARCHAEOLO G ICAL IMPLICATIONS OF RIVER AND COASTAL DYNAMICS | 415 AT THE POTENZA RIVER MOUTH GEO-ARCHAEOLOGICAL IMPLICATIONS OF RIVER AND COASTAL DYNAMICS AT THE POTENZA RIVER MOUTH (THE MARCHES, ITALY) T. Goethals, M. De Dapper & F. Vermeulen ABSTRACT In this contribution, the coastal and fluvial dynamics in the Potenza river plain (the Marches, Italy) are discussed, with the spatial and temporal extension of their associated features, to the degree of detail possible with the evidence at hand; and with their implications on archaeological site formation in its broad- est sense, though focused on the Roman period (2nd century BCE – 7th century CE) and the roman city Potentia. The results, both concerning fluvial and coastal dynamics, could be fitted into the general story for the Marche region, as found in literature. The coast, starting off with an alternation of cliffs and bays during the Versilian transgression, was transformed into a beach barrier-lagoon system with a ma- rine terrace at the base of the cliffs after the mid-Holocene, once the sea-level rise slowed down. Potentia was built on such a beach barrier. Behind the bar- riers, sediments were deposited, shaping the coastal plain in two distinct phases, one phase of land formation by deltaic fluvial infill, and a post-medie- val phase with clay-deck formation by floods. The fluvial dynamics include river diversions, from a central position in the coastal plain started before the Bronze Age, via a Roman and medieval course debouching 0.5 km more to the north, to the present artificial course in the extreme north of the coastal plain. -
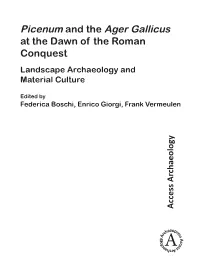
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest Landscape Archaeology and Material Culture Edited by Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen Access Archaeology aeopr ch es r s A A y c g c e o l s o s e A a r c Ah Archaeopress Publishing Ltd Summertown Pavilion 18-24 Middle Way Summertown Oxford OX2 7LG www.archaeopress.com ISBN 978-1-78969-699-8 ISBN 978-1-78969-700-1 (e-Pdf) © the individual authors and Archaeopress 2020 Cover: View of the Tronto Valley in the heart of the ancient Picenum. Drawing by Giorgio Giorgi. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest. Landscape Archaeology and Material Culture Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen (eds.) Contents Introduction - F. Boschi, E. Giorgi, F. Vermeulen I. P. Attema, Data integration and comparison in landscape archaeology: towards analysis beyond sites and valleys II. A. Gamberini, P. Cossentino, S. Morsiani, Romanization dynamics through the material culture analysis in the Ager Gallicus et Picenum III. O. Mei, L. Cariddi, Forum Sempronii and the Romanization of the Metauro Valley IV. F. Boschi, Methodological approaches to the study of the Cesano and Misa River Valleys (2010- 2020). New data: some thoughts and perspectives V. -
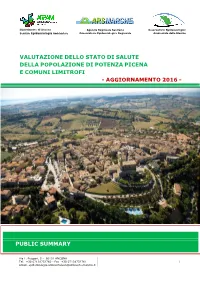
Public Summary
Dipartimento di Ancona Agenzia Regionale Sanitaria Osservatorio Epidemiologico Servizio Epidemiologia Ambientale Osservatorio Epidemiologico Regionale Ambientale delle Marche VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI POTENZA PICENA E COMUNI LIMITROFI - AGGIORNAMENTO 2016 - PUBLIC SUMMARY Via L. Ruggeri, 5 - 60131 ANCONA Tel. +39 07128732760 - Fax +39 07128732761 i email: [email protected] ENTI PARTECIPANTI Osservatorio Epidemiologico Ambientale (OEA) Servizio Epidemiologia Ambientale (SEA) del Dipartimento prov.le di Ancona Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Marche RICERCATORI/CO-RICERCATORI Dr. Mauro Mariottinia Dr. Fabio Filippettib Dr. Marco Baldinia Dr.ssa Katiuscia Di Biagioa Dr.ssa Silvia Bartolaccia Dr. Thomas Valerio Simeonia a ARPAM – SEA/OEA Dipartimento prov.le di Ancona – Via L. Ruggeri 5 – Ancona b ARS Marche – OER Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona DATA REDAZIONE STUDIO: DICEMBRE 2016 DATA RILASCIO PUBLIC SUMMARY MAGGIO 2017 Valutazione dello stato di salute della popolazione di Potenza Picena…. pag. ii VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI POTENZA PICENA E COMUNI LIMITROFI AGGIORNAMENTO 2016 PUBLIC SUMMARY INTRODUZIONE....................................................................................................................................................... IV LO STUDIO ............................................................................................................................................................. -

Fabbricato Residenziale (Parte), Sub. 25, Potenza Picena (MC)
INFORMATION MEMORANDUM 2017 Fabbricato Residenziale (parte), Sub. 25, Potenza Picena (MC) - Marche CAMMINI E PERCORSI INFORMATION MEMORANDUM – Fabbricato Residenziale (parte) – Sub.25 – Potenza Picena (MC) MARCHE Indice Premessa pag. 4 1. Indicazioni progettuali 1.1 Principi generali pag. 7 1.2 Nuove funzioni pag. 9 1.3 Modalità di intervento pag. 11 1.4 Valorizzazione dell’immobile pag. 14 2. Ambito di intervento 2.1 Tracciati di riferimento pag. 17 3. Inquadramento territoriale 3.1 Contesto geografico pag. 20 3.2 Sistema infrastrutturale e logistico pag. 22 3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali pag. 23 2 CAMMINI E PERCORSI INFORMATION MEMORANDUM – Fabbricato Residenziale (parte) – Sub.25 – Potenza Picena (MC) MARCHE Indice 4. Immobile 4.1 Localizzazione pag. 34 4.2 Inquadramento tecnico-amministrativo pag. 35 4.3 Qualità architettonica e paesaggistica pag. 36 4.4 Caratteristiche fisiche pag. 37 4.5 Rilevanza storico - artistica pag. 38 4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica pag. 39 4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa pag. 43 5. Iter di valorizzazione e strumenti 5.1 Trasformazione pag. 45 5.2 Strumenti di valorizzazione pag. 46 5.3 Percorso amministrativo pag. 47 5.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto pag. 48 3 CAMMINI E PERCORSI INFORMATION MEMORANDUM – Fabbricato Residenziale (parte) – Sub.25 – Potenza Picena (MC) MARCHE PREMESSA Il progetto CAMMINI E PERCORSI si colloca nella più ampia e già consolidata iniziativa di valorizzazione Valore Paese - DIMORE promossa a partire dal 2013 dall’Agenzia del Demanio, in linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, in collaborazione con Invitalia e ANCI - FPC con la partecipazione del MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, CDP, Istituto per il Credito Sportivo, Confindustria, AICA, ANCE, Assoimmobiliare e altri soggetti pubblici e privati interessati, che mira alla valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti puntando al recupero e riuso dei beni a fini turistico – culturali.