Digital Collaboration: Forme Sociali in Evoluzione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Towards the Global Virtual Lecture Hall: Case Studies in Global Teaching
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2013 Towards the global virtual lecture hall – case studies in global teaching Labhart, Nathan Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-91634 Dissertation Published Version Originally published at: Labhart, Nathan. Towards the global virtual lecture hall – case studies in global teaching. 2013, Univer- sity of Zurich, Faculty of Economics. Towards the Global Virtual Lecture Hall: Case Studies in Global Teaching /ϱΫАϱЁΞϣ iϑζЅϔЅ 8Ra j@3 /3<a33 R8 /R,jRa R8 BN8RaLjC,c ΞА Аϑζ 7ΞΫЛϣАЭ ϱυ 2ΫϱϩϱϨϔΫЅ. #ЛЅϔϩζЅЅ βϨϔϩϔЅАЁΞАϔϱϩ Ξϩβ BϩυϱЁϨΞАϔϱϩ iζΫϑϩϱϣϱόЭ ϱυ Аϑζ mϩϔЦζЁЅϔАЭ ϱυ xЛЁϔΫϑ $w MΞАϑΞϩ HΞΪϑΞЁА 8aRL bАζΫϡΪϱЁϩ i;. bЧϔАвζЁϣΞϩβ ,,3Uj30 RN j@3 a3,RLL3N0jCRN R8 TЁϱυY /ЁY `ϱϣυ TυζϔυζЁ TЁϱυY /ЁY +ϑЁϔЅАϱϿϑζЁ HЛζό lzSk The Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology of the University of Zurich herewith permits the publication of the aforementioned dissertation without expressing any opinion on the views contained therein. Zurich, July 17, 2013 The Vice Dean of the Academic Program in Informatics: Prof. Dr. Harald C. Gall Abstract The advent of technologies for remote collaboration has led to new developments in work and education during the last few decades, and will continue to profoundly influence work- ing, teaching, and learning in the 21st century. New forms of distance education – MOOCs (Massive Open Online Courses) are just one recent example – make it possible for teachers to reach a large audience, and for students to access educational materials that would not be available to them otherwise. -

Retki Maailmojen Rajoille
RETKI MAAILMOJEN RAJOILLE Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmoja vertailemassa Yrjö Lappalainen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt AVO2 / 3DM-osahankkeen julkaisuja 3DM Retki maailmojen rajoille Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmoja vertailemassa Yrjö Lappalainen Julkaisija: Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö SIS, TRIM-tutkimuskeskus Kansi: Leena Koskimäki Taitto: Yrjö Lappalainen Tämä teos on julkaistu sekä CC-BY-SA -lisenssin versiolla 3.0. Teoksen jatkokäyttö on sallittu lisenssin ehtojen mukaisesti. Tiivistäen: Saat kopioida, jakaa, muokata ja jaella muokkaamiasi versioita kunhan noudatat lisenssin ehtoja. Muokkaamasi teos on lisensoitava samalla lisenssillä. Muokatuissa teoksissa on mainittava käytetty lisenssi ja oltava hyperlinkki lisenssitekstiin tai koko lisenssiteksti. Alkuperäisen teoksen lähde on ilmoitettava ja siihen liittyvät tekijänoikeusmerkinnät on säilytettävä. Yksityiskohtaisempaa lisätietoa saat täydellisestä lisenssitekstistä: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode PK-paino Oy, Tampere 2013 ISBN (painettu julkaisu): 978-951-44-9339-3 ISBN (verkkojulkaisu): 978-951-44-9340-9 Sisällys Lukijalle .......................................................................................... i 1. Johdanto ..................................................................................... 1 2. Second Life .................................................................................. 3 3. OpenSim .................................................................................... -

Volume 2 Sponsored by the Research and Theory Division 36 Anaheim, CA Editor: Michael Simonson
thannual Proceedings Selected Papers on the Practice of Educational Communications and Technology - Volume 2 Sponsored by the Research and Theory Division 36 Anaheim, CA Editor: Michael Simonson Nova Southeastern University, North Miami Beach, Florida 2013 Annual Proceedings - Anaheim: Volumes 1 & 2 Volume 1: Selected Research and Development Papers And Volume 2: Selected Papers On the Practice of Educational Communications and Technology Presented at The Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology Sponsored by the Research and Theory Division And The Division of Instructional Design Anaheim, CA 2013 Editor Michael Simonson Professor Instructional Technology and Distance Education Nova Southeastern University Fischler Graduate School of Education and Human Services North Miami Beach, FL Preface For the thirty-fourth year, the Research and Theory Division of the Association for Educational Communications and Technology (AECT) is sponsoring the publication of these Proceedings. Papers published in this volume were presented at the annual AECT Convention in Anaheim, CA. A limited quantity of these Proceedings were printed and sold in both hardcopy and electronic versions. Volumes 1 and 2 are available through the Educational Resources Clearinghouse (ERIC) System. Proceedings volumes are available to members at AECT.ORG. The Proceedings of AECT’s Convention are published in two volumes. Volume #1 contains papers dealing primarily with research and development topics. Papers dealing with the practice of instructional technology including instruction and training issues are contained in Volume #2. This year, both volumes are included in one document. REFEREEING PROCESS: Papers selected for presentation at the AECT Convention and included in these Proceedings were subjected to a reviewing process. -

Howard Stearns 650-817-5956 [email protected]
1314 Paloma Ave Belmont, CA 94002 Howard Stearns 650-817-5956 [email protected] EDUCATION Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA B.Sc. Ocean Engineering 1986 B.Sc. Electrical Engineering 1987 EXPERIENCE Lead Engineer High Fidelity, San Francisco, CA 2015-present I am responsible for the blockchain economy, high-concurrency servers, personal safety, social services and business services of this industry-leading virtual-worlds R&D startup. We use head-mounted displays and low-latency controllers to create a next-generation, large-scale metaverse for remote-work, creativity, education, and play. Senior Developer / Lead Shocase, San Francisco, CA 2014-2015 This social network for marketing professionals automatically suggests individual pre-loaded portfolios for new members. I prototyped, architected, and deployed the system with 100k portfolio projects identified and processed from the Internet. Senior Developer / Lead TuneUp Media, San Francisco, CA 2011-2014 Working closely with product management, I architected a system that automatically corrects metadata in the music collections of 9 million users. Senior Application Lead HP WebOS (Palm), Sunnyvale, CA 2011 I delivered a new tablet app using Palm’s first test-driven development process, and led the team for the release of Palm’s most complex and visible mobile app: email. Member of the Technical Staff Teleplace (Qwaq), Redwood City, CA 2007-2011 Lead Developer University of Wisconsin, Madison, WI 2004-2007 The Croquet Project was convened by computing pioneers Alan Kay and David Reed to advance 3D virtual worlds for real-time, persistent collaboration. I led the development team at UW before joining the enterprise commercialization, Teleplace. -
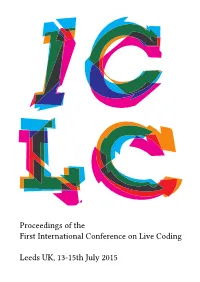
From Live Coding to Virtual Being
Live Coding and Machine Listening Nick Collins Durham University, Department of Music [email protected] ABSTRACT Live coding control of machine listening processes, or more radically, machine listening control of live coding, provides an exciting area of crossover between two research frontiers in computer music. is article surveys the state of the art, and reports a number of experimental projects that point to potentially productive further directions. 1. Introduction Live coding has established itself as a viable and productive method of computer music performance and prototyping, embracing the immedicacy of modern computer programming languages (Collins et al. 2003; Ward et al. 2004; Blackwell and Collins 2005; Brown and Sorensen 2009; Collins 2011; McLean 2011; Magnusson 2014). New avenues in interfacing for programming are being embraced, including tangible computing of unit generator graphs and musical sequences (see for example Mónica Rikić’s buildacode), natural language processing (e.g., Craig Laa’s oth) and computer vision (e.g., Nik Hanselmann’s bodyfuck (2009) brainfuck interface). Performance ventures range from the current vogue for algoraves, showcasing generative and interactive creation of electronic dance music (Collins and McLean 2014) to contemporary dance and live arts. Complementing existing work, this paper explores the interaction of live coding with machine listening, from listening functionality within existing performance systems towards the use of live audio analysis as programming interface itself. -
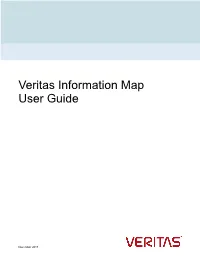
Veritas Information Map User Guide
Veritas Information Map User Guide November 2017 Veritas Information Map User Guide Last updated: 2017-11-21 Legal Notice Copyright © 2017 Veritas Technologies LLC. All rights reserved. Veritas and the Veritas Logo are trademarks or registered trademarks of Veritas Technologies LLC or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners. This product may contain third party software for which Veritas is required to provide attribution to the third party (“Third Party Programs”). Some of the Third Party Programs are available under open source or free software licenses. The License Agreement accompanying the Software does not alter any rights or obligations you may have under those open source or free software licenses. Refer to the third party legal notices document accompanying this Veritas product or available at: https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements The product described in this document is distributed under licenses restricting its use, copying, distribution, and decompilation/reverse engineering. No part of this document may be reproduced in any form by any means without prior written authorization of Veritas Technologies LLC and its licensors, if any. THE DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID. VERITAS TECHNOLOGIES LLC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH THE FURNISHING, PERFORMANCE, OR USE OF THIS DOCUMENTATION. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENTATION IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.