Il Palazzo Ubaldini Di Apecchio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rankings Municipality of Isola Del Piano
9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Marche / Province of Pesaro e Urbino / Isola del Piano Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Acqualagna Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Lunano AdminstatApecchio logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Macerata Feltria Belforte ITALIA all'Isauro Mercatello sul Metauro Borgo Pace Mercatino Cagli Conca Cantiano Mombaroccio Carpegna Mondavio Cartoceto Mondolfo Colli al Metauro Monte Fano Cerignone Fermignano Monte Grimano Fossombrone Terme Fratte Rosa Monte Porzio Frontino Montecalvo in Frontone Foglia Gabicce Mare Montecopiolo Gradara Montefelcino Isola del Montelabbate Piano Peglio Pergola Pesaro Petriano Piandimeleto Pietrarubbia Piobbico San Costanzo San Lorenzo in Campo Sant'Angelo in Vado Sant'Ippolito Sassocorvaro Auditore Sassofeltrio Serra Sant'Abbondio Powered by Page 3 Tavoleto L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Tavullia Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Terre ANCONAITALIA Roveresche ASCOLI PICENO Urbania FERMO Urbino MACERATA Vallefoglia PESARO E URBINO Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia-Romagna Repubblica di Friuli-Venezia San Marino Giulia Sardegna Lazio -

I Primi 3 Servizi Selezionati Come Prioritari Sono
PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO Indagine conoscitiva sulla domanda di servizi provinciali per il territorio (Funzioni di supporto tecnico – amministrativo agli Enti Locali) - Analisi dei primi risultati – A tutti i 59 comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino è stato sottoposto un questionario on-line contenente l’elenco di tutti i servizi offerti, raggruppati in aree e gruppi tematici. I comuni hanno espresso la propria domanda selezionando i servizi di interesse, con la possibilità di segnalare, per ogni gruppo, un servizio di valenza prioritaria. Nel territorio sono presenti 10 Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti e 7 di questi Comuni hanno espresso le loro necessità, il 70% di loro ha compilato il questionario. Per quanto riguarda i Comuni più grandi, al di sopra dei 10.000 abitanti, 3 su 5 hanno segnalato i servizi utili alla loro realtà comunale. 3 su 5 corrisponde al 60% dei Comuni medio-grandi. DATI COPERTURA INDAGINE hanno risposto 43 comuni su 59 pari al 73% I comuni rispondenti suddivisi per fascia demografica (numero residenti) 7% 16% 77% <=5000 >5000 e <=10000 >=10000 Fascia di Comuni Comuni totali % rispondenti popolazione rispondenti per fascia (n° residenti) <=5000 33 44 75% >5000 e <=10000 7 10 70% >=10000 3 5 60% Totale 43 69 73% Fonte: Sistema Informativo e Statistico Elaborazione: Ufficio 5.0.1 - Gestione banche dati, statistica, sistemi informativi territoriali e supporto amministrativo 1 PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO QUADRO GENERALE 8 aree funzionali 20 gruppi di servizi Per un totale di 119 singoli servizi offerti Domanda di servizi espressa dai comuni del territorio In ordine decrescente su 119 servizi presenti nell'elenco dei servizi presentati in sede di assemblea dei Sindaci, il massimo numero di servizi richiesti per Comune è 91 con una media di 31 servizi complessivi per ogni Comune che possono essere confermati o implementati come nuovi. -

Pesaro È in Moto 10 Itinerari Tra L'adriatico
Comune di Pesaro Assessorato allo sviluppo economico e turismo 10 itinerari tra l’Adriatico, gli Appennini e le colline Pesaro è in moto marchigiane. PESARO E LA MOTOCICLETTA Officine Benelli Il motore è nell’anima di Pesaro, il motore nella sua realizzato moto da competizione salite ai vertici delle forma più libera, quella più giocosa e in sintonia con classifiche mondiali, come le famose Morbidelli e le l’ambiente, quella più adatta a muoversi sulle belle imbattibili MotoBi, ma anche le Molaroni, Piovaticci, strade che dal mare Adriatico, attraversando spettacola- Mancini, Righini, Sanvenero, MBA, Grassetti, Iprem ed ri colline, arrivano all’Appennino tra Marche, Romagna altre ancora. C’è poi la straordinaria concentrazione di Umbria e Toscana. campioni, tanti che non si possono neppure citare tutti: Pesaro è una città della motocicletta. Lo è da quasi Valentino Rossi per primo, ma anche i giovani Alex 100 anni se si considera che nel 1911 nasce qui un Baldolini e Simone Giorgi Grotskyj - che corrono con marchio di assoluta importanza nella storia del motoci- successo sulle piste di oggi - e quelli che hanno vinto clismo: la Benelli, ancora oggi attiva, la casa motocicli- sulle piste del passato come Eugenio Lazzarini, 3 volte stica che già negli anni ’20 consacra campione d’Italia campione del mondo, Paolo Campanelli 5 volte campio- Tonino, uno dei suoi fondatori, e fa conoscere la propria ne d’Italia, il mitico Tonino Benelli, 4 volte campione produzione in tutt’Europa. italiano, Graziano Rossi, vice campione del mondo e La motocicletta a Pesaro è dunque passione, lavoro, numerosi vincitori di campionati come Dorino Serafini, sport, storia, cultura, ma è anche il mezzo che esprime Augusto e Paolo Baronciani, Silvio Grassetti, e diversi bene il carattere di questa città, pronta a mettersi in altri ancora. -

Avviso D'asta Pubblica
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO “ M ASSA TRABARI A” dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant’Angelo in Vado Provincia di Pesaro ed Urbino --- Bando di concorso su ambito comunale per la concessione di contributi (c.d. buoni riscatto) per l’acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni (rent to buy) Articolo 1 (Oggetto) Il presente bando disciplina la concessione di contributi (c.d. buoni riscatto) per l’acquisto della prima casa di abitazione dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni (rent to buy), conformemente a quanto stabilito dal Piano regionale di edilizia residenziale per il triennio 2014/2016 approvato con D.A.C.R. n. 115 del 09.12.2014, pubblicata sul B.U.R. Marche n. n.118 del 24.12.2014, con l’obiettivo di: - incrementare l’offerta delle abitazioni a canone moderato ed agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa differendone l’acquisto al termine del periodo di locazione; - ridurre lo stock di alloggi inutilizzati presenti sul mercato con particolare riferimento a quelli ultimati, invenduti, che appesantiscono e condizionano il mercato edilizio medesimo ed il sistema delle imprese edili. Costituiscono pertanto oggetto degli interventi alloggi di proprietà privata (imprese edilizie, cooperative, privati cittadini), aventi determinate caratteristiche dimensionali, tipologiche ed energetiche, indicate al successivo articolo 6, di recente costruzione, ultimati e non occupati, invenduti, da concedere in locazione, con patto di futura vendita, per un periodo minimo di 8 anni al canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998. Sono favorite le operazioni di aggregazione dell’utenza che prevedono il coinvolgimento di interi complessi edilizi e degli operatori economici interessati all’operazione (banche, imprese, cooperative edilizie ecc.). -

Episodio Di ISOLA DEL PIANO, Convento Di Montebello, 21.06.1944
Episodio di ISOLA DEL PIANO, convento di Montebello, 21.06.1944 Nome del Compilatore: Chiara Donati con la collaborazione di Roberto Lucioli (responsabile archivio Istituto Storia Marche) I.STORIA Località Comune Provincia Regione Convento di Montebello Isola del Piano Pesaro-Urbino Marche Data iniziale: 21 giugno 1944 Data finale: Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 4 4 4 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 4 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute De Paola Gabriele, n. a Pesaro il 08/06/1920, paternità Domenico, qualifica Partigiano caduto, Bruno Lugli – distaccamento Balducci (21/05/1944 – 21/06/1944), riconosciutagli il 16/04/1946 ad Ancona. Cucchi Blasco, n. a Fossombrone il 15/12/1922, paternità Umberto, qualifica Partigiano caduto, Bruno Lugli – distaccamento Balducci (21/05/1944 – 21/06/1944), riconosciutagli il 16/04/1946 ad Ancona. Marrone Aldo, n. ad Alghero (Sassari) il 08/09/1920, paternità Nicola, qualifica Partigiano caduto, Bruno Lugli. Berardini Federico, n. a Gioia dei Marsi (L’Aquila) il 23/05/1924, paternità Paris, qualifica Partigiano caduto, Bruno Lugli – distaccamento Balducci (10/06/1944 – 21/06/1944), riconosciutagli il 11/06/1946 ad Ascoli Piceno. Altre note sulle vittime: - Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: - Descrizione sintetica Il 21 giugno 1944 mentre il distaccamento Balducci, della Brigata Bruno Lugli, era appostato sulla Cesena Alta in attesa dei gruppi fascisti lì segnalati, alcuni plotoni del Btg. -

Episodio Di URBANIA, Cà Vitaletto, 08.07.1944 Nome Del Compilatore
Episodio di URBANIA, Cà Vitaletto, 08.07.1944 Nome del Compilatore: Chiara Donati con la collaborazione di Roberto Lucioli (responsabile archivio Istituto Storia Marche) I.STORIA Località Comune Provincia Regione Ca’ Vitaletto Urbania Pesaro-Urbino Marche Data iniziale: 8 luglio 1944 Data finale: Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 2 2 2 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 2 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute Tacchi Luigi, n. a Piobbico il 16/01/1900, fu Giuseppe e Oradea Anna, insegnante, qualifica Partigiano caduto, Brg. Gap Pesaro (20/09/1943 – 08/07/1944), riconosciutagli il 21/02/1946 ad Ancona. Mistura Dante, n. il 02/02/1925 ad Acqualagna, fu Francesco e Tangini Elisa, residente a Cagli, qualifica Partigiano caduto, V Brigata Garibaldi Pesaro (11/01/1944 - 08/07/1944). Altre note sulle vittime: - Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: - Descrizione sintetica La zona di Orsaiola divenne un importante centro di azione delle forze partigiane. Vi operava il capitano Luigi Tacchi che aveva formato la Banda di Orsaiola insieme a Francesco Tumiati, grande eroe della Resistenza che verrà fucilato poi a Cantiano il 15 maggio 1944. L’azione dei partigiani e l’appoggio delle famiglie di coloni di quella vasta zona montuosa spinsero le forze nazifasciste a organizzare un’ampia operazione di rastrellamento tra il 7 e l’8 luglio 1944. -
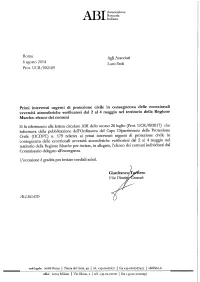
Elenco Comuni
COMUNE PROVINCIA 1 Agugliano AN 2 Arcevia AN 3 Barbara AN 4 Belvedere Ostrense AN 5 Camerano AN 6 Castelfidardo AN 7 Castelleone di Suasa AN 8 Castelplanio AN 9 Chiaravalle AN 10 Corinaldo AN 11 Falconara Marittima AN 12 Filottrano AN 13 Jesi AN 14 Loreto AN 15 Monte Roberto AN 16 Monte San Vito AN 17 Montecarotto AN 18 Montemarciano AN 19 Offagna AN 20 Osimo AN 21 Ostra AN 22 Ostra Vetere AN 23 San Marcello AN 24 Senigallia AN 25 Staffolo AN 26 Trecastelli (già Castelcolonna, Monterado e Ripe) AN 27 Acquasanta Terme AP 28 Acquaviva Picena AP 29 Appignano del Tronto AP 30 Arquata del Tronto AP 31 Ascoli Piceno AP 32 Carassai AP 33 Castignano AP 34 Comunanza AP 35 Cossignano AP 36 Cupra Marittima AP 37 Folignano AP 38 Grottammare AP 39 Maltignano AP COMUNE PROVINCIA 40 Montalto delle Marche AP 41 Montedinove AP 42 Montegallo AP 43 Montemonaco AP 44 Monteprandone AP 45 Offida AP 46 Palmiano AP 47 Ripatransone AP 48 Roccafluvione AP 49 Rotella AP 50 Spinetoli AP .51 Venarotta AP 52 Altidona FM 53 Amandola FM 54 Belmonte Piceno FM 55 Campofilone FM 56 Falerone FM 57 Fermo FM 58 Francavilla d'Ete FM 59 Grottazzolina FM 60 Massa Fermana FM 61 Monsampietro Morico FM 62 Montappone FM 63 Monte Giberto FM 64 Monte Rinaldo FM 65 Monte San Pietrangeli FM 66 Monte Urano FM 67 Monte Vidon Combatte FM 68 Monte Vidon Corrado FM 69 Montefalcone Appennino FM 70 Montegiorgio FM 71 Montegranaro FM 72 Monteleone di Fermo FM 73 Montelparo FM 74 Montottone FM 75 Ortezzano FM 76 Pedaso FM 77 Petritoli FM 78 Ponzano di Fermo FM COMUNE PROVINCIA 79 Porto San Giorgio -

Tour 1 Ciclotur.EN
[email protected] of San Vincenzo al Furlo al Vincenzo San of Provincia di Pesaro e Urbino e Pesaro di Provincia 3. Acqualagna. Crypt at the Abbey Abbey the at Crypt Acqualagna. 3. www.turismo.pesarourbino.it 2. View of Fossombrone sul Metauro sul Fossombrone of View 2. 1. The River Candigliano at Gola del Furlo del Gola at Candigliano River The 1. Cover: Gola del Furlo with lake lake with Furlo del Gola Cover: 3. Urbino (max. alt. 588 m). m). 588 alt. (max. Urbino An easy uphill stretch leads to the town of town the to leads stretch uphill easy An easier and rather picturesque valley roads. valley picturesque rather and easier number of steep sections alternating with alternating sections steep of number (Cesana and Passo di S.Gregorio) include a include S.Gregorio) di Passo and (Cesana spectacular landscape. The two main climbs main two The landscape. spectacular and Cesane mountain chains through a through chains mountain Cesane and The itinerary winds its way around the Furlo the around way its winds itinerary The 2. Follow road signs for Furlo for signs road Follow Superstrada Grossetto-Fano, Acqualagna Exit • Exit Acqualagna Grossetto-Fano, Superstrada Inland: From Superstrada for Rome. Furlo Exit Exit Furlo Rome. for Superstrada Autostrada A14, Fano Exit • • Exit Fano A14, Autostrada Coast: the From How to reach Furlo: reach to How amateur cyclists amateur Intended for: for: Intended asphalt Type of road: road: of Type Level of difficulty: difficulty: of Level m. 961 961 m. FERMIGNANO Total ascent/descent: Total MONTI DELLE CESANE DELLE MONTI 4 h / 4:30 h 4:30 / h 4 Estimated time: Estimated FOSSOMBRONE km. -

Export Mensile Agosto 2018 CH67 20180914 122937
PIANO MENSILE ISPEZIONE RETE GAS AGOSTO 2018 COMUNE Codice AEEGSI DENOMINAZIONE IMPIANTO Via o Località Parte Impianto ispezionata Pressione di rete BORGO PACE 34561 BORGO PACE PIAZZA DEL PINO Rete BP BORGO PACE 34561 BORGO PACE VIA DEL BORGHETTO Rete BP BORGO PACE 34561 BORGO PACE VIA DELLE RIPE Rete BP BORGO PACE 34561 BORGO PACE VIA PAPA CLEMENTE XIV Rete BP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO PIAZZA ROMA Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO PIAZZA UMBERTO I Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO PIAZZA XII SETTEMBRE Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO STRADA PONTE DEGLI ALBERI Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO STRADA SCOTANETO Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA BORGO Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA CAVALLOTTI Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA DEL PIANO Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA GARIBALDI Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA MAZZINI Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA MENTANA Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA QUERCETO Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIA REGINA ELENA Rete MP ISOLA DEL PIANO 34562 ISOLA DEL PIANO VIALE REGINA MARGHERITA Rete MP SANT IPPOLITO 34563 REFORZATE VIA DELLA RESISTENZA Rete BP SANT IPPOLITO 34563 REFORZATE VIA DON MINZONI Rete BP SANT IPPOLITO 34563 REFORZATE VIA GIACOMO MATTEOTTI Rete BP ACQUALAGNA 34565 FERMIGNANO CASE SPARSE NARO Rete MP ACQUALAGNA 34565 FERMIGNANO CENTRO NARO Rete MP ACQUALAGNA 34565 FERMIGNANO CORSO ROMA Rete BP ACQUALAGNA -

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 7 Cartoceto, Colli Al Metauro, Fossombrone, Isola Del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 7 Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito Ente Capofila: Comune di Fossombrone AVVISO PUBBLICO per la presentazione della domanda d’accesso all’ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI anno 2019 (Delibera di Giunta Regionale n. 473 DEL 29/04/2019) (Determinazione del Coordinatore di Ambito n. 59 del 27/05/2019 ) DESTINATARI : gli anziani non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7– di seguito ATS n. 7 – le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari anche non conviventi o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita. COS’E’: Un contributo economico di € 200,00 mensili per massimo 12 mensilità ( salvo interruzione o scorrimenti) che non costituisce vitalizio ma supporto personalizzato nell’ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La persona anziana assistita deve: • aver compiuto i 65 anni di età ; • essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% ( vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità); • aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento ( non sono ammesse a contributo le domande per persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ); vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura; • essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 7 (Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone , Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito) ed ivi domiciliata ; (non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali - es. -

Biologico Pu.Pdf
ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA REGIONE MARCHE Assam - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Elenco Regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - aggiornato al 31 dicembre 2008 - come previsto dal D. Lgs. 220/95. 1 . 4 - Produttori Provincia: PU Aziende biologiche Anno 2008 N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE Pr A Codice Fiscale Partita IVA 545 ABDERHALDEN URS VIA MONTECALENDE, 73 61029 URBINO PU P BDRRSU53B23Z133Q 00796290419 546 AGRIBIOLOGICA AZ. AGR. S.S. VIALE GIULIO PATRIGNANI, 1 61024 MOMBAROCCIO PU P 01343920417 547 AGRICOLA DELLA SERRA VIA DELLA SERRA, 6 61012 GRADARA PU P 00937570414 548 AGRICOLA VERGINETO DI PAGLIARI GRAZIANO & C. S.S. VIA SAN MARTINO DEL PIANO, 56 61034 FOSSOMBRONE PU P PGLGZN65D10D749Z 02035550413 549 ALBERGATI LUCA VIA S.M. DELLE SELVE, 23 61029 URBINO PU P LBRLCU66P12F205Y 01166250413 550 ALESSANDRI MONICA - AZ. AGR. COLVENTOSO LOC. COLVENTOSO 61043 CAGLI PU P LSSMNC58S62B352A 01466970413 551 ALESSANDRINI LOREDANA VIA NAZIONALE, 1 - LOC. 61029 URBINO PU P LSSLON61E57L500H 01347970418 CANAVACCIO 552 ALTAVALMARECCHIA SOC. COOP. A.R.L. VIA CA' CERTINO, 48 - LOC. 61015 NOVAFELTRIA PU P 00992880419 PERTICARA 553 ANGELETTI GABRIELLA VIA MONTESOFFIO 61040 BARCHI PU P NGLGRL50D41G089L 00616670410 554 APICOLTURA INSULA PLANI DI ALUNNI SERENA VIA STRADA VALLI, 12 61030 ISOLA DEL PIANO PU PT 02207230414 555 ARBAU PIETRO E SALVATORE S.S. VIA PIANA, 29/A 61029 URBINO PU P 01395000415 556 ARCANGELI FABIOLA VIA OFANTO, 8 - FRAZ. RIO SALSO 61010 TAVULLIA PU P RCNFRL60T41L081V 02002050413 557 ARRAS MARIO VIA STRADA FALCINO 61100 PESARO PU P RRSMRA54M13E441N 00882980410 558 AZ. AGR. CAL BIANCHINO DI MINNETTI L. E COMANDINI C. VIA GADANA, 114 61029 URBINO PU PT 02168780415 559 AZ. -

Scheda Tecnica Processionaria
Borgo Pace Fermignano Mercatello sul Metauro Peglio Sant’Angelo in Vado Urbania Urbino Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino Ufficio Forestazione Ambiente Agricoltura SCHEDA TECNICA PROCESSIONARIA La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) è un insetto dell'ordine dei lepidotteri che deve il suo nome alla caratteristica di muoversi sul terreno in fila, formando una sorta di "processione". E' uno degli insetti più distruttivi per le foreste, capace di privare di ogni foglia vasti tratti di pinete durante il proprio ciclo vitale. Le specie più colpite sono quelle del genere Pinus e in particolare il pino nero , ma è facile trovarne anche su piante di cedro. La processionaria è attiva durante i periodi freddi dell'anno, dal momento che trascorre i mesi estivi come larva sotto terra per riemergere come falena nel mese di agosto quando inizia la ricerca di piante adatte per deporre le uova. Ogni femmina produce un "ammasso" di uova, fino a 300, che viene fissato ad un ago dell'albero ospitante e dal quale dopo circa 4 settimane nascono le tipiche larve. Nonostante la modesta dimensione, le larve sono dotate di forti mandibole in grado di fagocitare i duri aghi già subito dopo la nascita. In poco tempo, spogliato completamente un ramo, si muovono in fila alla ricerca di nuovo nutrimento. I bruchi vivono in gruppo. Inizialmente sono nomadi, spostandosi di ramo in ramo costruendo nuovi nidi provvisori, ma verso ottobre formano un nido sericeo dove svernano, uscendo a brucare nelle giornate più calde. I nidi invernali di Thaumetopoea, sono inconfondibili e, piriformi e di colore bianco brillante, sono riconoscibili anche a distanza.