Chiesa Di San Francesco D'assisi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ADDENDA Healthpartners Unitypoint Health Align
HealthPartners UnityPoint Health Align (PPO) HealthPartners UnityPoint Health Symmetry (PPO) HealthPartners UnityPoint Health Group (PPO) This directory addenda provides a list of HealthPartners UnityPoint Health network providers. For pharmacy information, refer to your Pharmacy directory. This directory is current as of December 2020. Some network providers may have been added or removed from our network after this directory was printed. We do not guarantee that each network provider is still accepting new members. 2020 HEALTHPARTNERS UNITYPOINT HEALTH PROVIDER DIRECTORY - ADDENDA H3416_119046 IR 11/2019 This document is a list of changes to the HealthPartners UnityPoint Health network providers. Use this list to find the network providers that have had changes. Providers are organized first by the network change. The network change categories are New to the Network, No longer in the Network, Accepting New Patients, Address Changes and Phone Number Changes. After category, it is organized by provider type, then alphabetically by facility name. If you have any questions, please call Member Services at 888-360-0544 (TTY 711). Facility Name Address City, State, Zip Phone Number NEW TO THE NETWORK Primary care physicians and specialists – New to the Network Access Family Medical 1216 Ryan's Rd Worthington, MN (507) 372-2921 Clinic 56187-1722 Access Health - Brookings 400 22nd Ave Ste 1 Brookings, SD 57006- (605) 697-9539 2450 Access Health - Fulda 201 N St Paul Ave Ste 1 Fulda, MN 56131- (507) 425-2933 3004 Access Health - Mitchell 1900 -
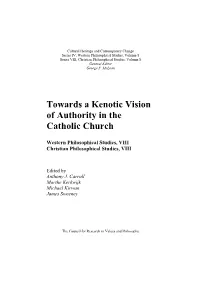
A Description of What Magisterial Authority Is When Understood As A
Cultural Heritage and Contemporary Change Series IV, Western Philosophical Studies, Volume 8 Series VIII, Christian Philosophical Studies, Volume 8 General Editor George F. McLean Towards a Kenotic Vision of Authority in the Catholic Church Western Philosophical Studies, VIII Christian Philosophical Studies, VIII Edited by Anthony J. Carroll Marthe Kerkwijk Michael Kirwan James Sweeney The Council for Research in Values and Philosophy Copyright © 2015 by The Council for Research in Values and Philosophy Box 261 Cardinal Station Washington, D.C. 20064 All rights reserved Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Towards a kenotic vision of authority in the Catholic Church / edited by Anthony J. Carroll, Marthe Kerkwijk, Michael Kirwan, James Sweeney. -- first edition. pages cm. -- (Cultural heritage and contemporary change. Christian philosophical studies; Volume VIII) Includes bibliographical references and index. 1. Authority--Religious aspects--Catholic Church. I. Carroll, Anthony J., 1965- editor of compilation. BX1753.T6725 2014 2014012706 262'.'088282--dc23 CIP ISBN 978-1-56518-293-6 (pbk.) TABLE OF CONTENTS Introduction: The Exercise of Magisterial Authority 1 in the Roman Catholic Church Anthony J. Carroll Part I: Authority in Biblical Sources Chapter I: “It Shall Not Be so among You”: Authority and 15 Service in the Synoptic Gospels Sean Michael Ryan Chapter II: Authority without Sovereignty: Towards 41 a Reassessment of Divine Power Roger Mitchell Part II: Sociological and Philosophical -

Carlo Maria Martini 22 SOC Editoriale 12:Layout 1 25/10/12 11.19 Pagina 3
Copertina Giugno 12 soc:Layout 1 25/10/12 11.13 Pagina 1 u p e r omnia charitas Ciao,Ciao, grandegrande amico! FONDAZIONE SACR AFAMIGLI A SOC - OTTOBRE 2012 - Poste Italiane Spa - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Milano DCB 2, comma 1, art. 46) n° 27/02/2004 L. in (conv. 353/2003 D.L. - A.P. in spedizione - Spa Italiane Poste - 2012 OTTOBRE - SOC ONLUS Abbiamo cura delle persone disabili sommario OTT 12 soc:Layout 1 25/10/12 11.16 Pagina 2 u p e r SOMMariO ottobre 2012 omnia EDITORIALE charitas La casa sulla roccia FONDAZIONE N. 3 - Ottobre 2012 SACR AFAMIGLI A ONLUS Abbiamo cura delle persone disabili Periodico della Fondazione Sacra Famiglia 3 di Cesano Boscone Direttore responsabile 4 Stefano Lampertico SPECIALE T Carlo Maria Direttore editoriale Martini, ciao grande Don Vincenzo Barbante amico!: Coordinamento editoriale T La biografia Stefania Culurgioni T Il profilo T Martini alla Sacra 24 Archivio fotografico Famiglia AGENDA Archivio Fondazione Isf T I ricordi di chi lo ha T Donatella Veronese Casa di Cura Tiziano Bernabè conosciuto Ambrosiana, un nuovo ambulatorio Progetto grafico e impaginazione T Andora, il grande Luisa Torreni concerto di agosto T Stampa - Arti grafiche Bianca&Volta Regoledo, il Trucazzano (Mi) progetto “Case Tiratura - Copie 10.000 management” T Gazzada, costruiamo insieme Direzione e redazione il futuro Piazza L. Moneta, 1 T Cesano Boscone, 20090 Cesano Boscone (MI) la festa patronale Tel. 02.456.77.753 Fax 02.456.77.549 TTodos Santos, le e-mail: [email protected] date del tour T In ricordo di Registrazione - Tribunale di Milano n.332 coloro che ci hanno del 25 giugno 1983 lasciato Garanzia di tutela dei dati personali GOCCE D’ORO L’Editore garantisce ad abbonati e lettori la riservatez- Donazioni e lasciti za dei loro dati personali che verranno elaborati elet- tronicamente ed eventualmente utilizzati al solo sco- po promozionale. -
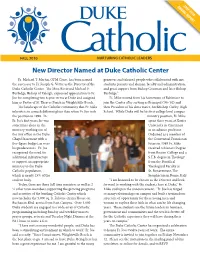
2010 Annual Report
ANNUAL2009-2010 REPORT FALL 2010 NURTURING CATHOLIC LEADERS New Director Named at Duke Catholic Center Fr. Michael T. Martin, OFM Conv., has been named generous and talented people who collaborated with me, the successor to Fr. Joseph G. Vetter as the Director of the students, parents and alumni, faculty and administration, Duke Catholic Center. The Most Reverend Michael F. and great support from Bishop Gossman and later Bishop Burbidge, Bishop of Raleigh, expressed appreciation to Fr. Burbidge.” Joe for completing two 6-year terms at Duke and assigned Fr. Mike moved from his hometown of Baltimore to him as Pastor of St. Therese Parish in Wrightsville Beach. join the Center after serving as Principal (’96-’01) and The landscape of the Catholic community that Fr. Mike then President of his alma mater, Archbishop Curley High inherits is in a much different place than when Fr. Joe took School. While Duke will be his first college level campus the position in 1998. In ministry position, Fr. Mike Fr. Joe’s first years, he was spent three years at Xavier sometimes alone in the University in Cincinnati ministry working out of as an adjunct professor. the tiny office in the Duke Ordained as a member of Chapel basement with a the Conventual Franciscan five-figure budget, as were Friars in 1989 Fr. Mike his predecessors. Fr. Joe received a Masters Degree recognized the need for from Boston College and a additional infrastructure S.T.B. degree in Theology to support an appropriate from the Pontifical ministry to the Duke Theological Faculty at Catholic population, St. -

The Battalion • Impressions of Sunday’S Race Tuesday, August 8, 1978 News Dept
Inside Tuesday » A&M graduates guard Lady Bird Johnson — p. 3. » Manilow concert scheduled for this fall is canceled — p. 3. The Battalion • Impressions of Sunday’s race Tuesday, August 8, 1978 News Dept. 845-2611 - p. 8. College Station, Texas Business Dept. 845-2611 Pope’s successor to be named by large group of cardinals By ERNEST SAKLER Italian “papabili ’ — potential papal candidates — year-old Segri-born Felici is a polished and pungent United Press International include Cardinals Giovanni Benelli, Sergio Pignedoli, speaker who leans toward the conservative. He is dis VATICAN CITY — Pope Paul Vi’s successor, whose Sebastiano Baggio, Pericle Felici, Giovanni Colombo, trusted by church progressives. A cardinal since 1967, election will decide the future of the Roman Catholic Michele Pellegrino, Antonio Poma, Corrado Ursi and his lack of pastoral experience could hurt him in papal church and perhaps the allegiance of nearly 700 million Albino Luciani. balloting. faithful, probably will come from a group of fewer than Non-Italian cardinals, who were given long-shot Luciani: A theologian and philosopher, he is one of 20 cardinals, Vatican experts said Monday. chances for election, include American Cardinals John the newest cardinals, named in 1973. Born in Forno di Predicting the outcome of a papal election is always F. Dearden and John J. Wright, Leon Duval of Canale in 1912 he is vice president of the Italian difficult, but particularly so this time because the Col Algeria, Gabriel Garrone and Jean Villot of France, Bishops’ Conference. lege o* Cardinals is the largest in history. James Knox of Australia, Franz Koenig of Austria, Pellegrino: The retired archbishop of Turin is There will be 115 cardinals meeting in Maurice Roy of Canada, Johannes Willenbrands of Hol viewed by many traditionalists as too liberal. -

Cuadernos Doctorales Separata
ISSN: 0214-6827 EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA cuadernos doctorales DE LA Facultad DE teologÍA PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA UNIVERSIDAD DE NAVARRA / PAMPLONA / ESPAÑA RUBÈN MESTRE ANDRÉS La Iniciación cristiana en Centro,la unidad o servicio de primer nivel enseñanza del beato Ildefonso Centro, unidad o servicio de primer nivel Schuster (1880-1954) Centro, unidad o servicio de segundo nivel VoluMEN 66 / 2017 separata EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA cuadernos doctorales DE LA Facultad DE teologÍA PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / UNIVERSIDAD DE NAVARRA PAMPLONA / ESPAÑA / ISSN: 0214-6827 VOLUMEN 66 /2017 DIRECTOR/ EDITOR Esta publicación recoge los extractos de las tesis doctorales J. José Alviar defendidas en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. UNIVERSIDAD DE NAVARRA La labor científica desarrollada y recogida en esta publicación VOCALES ha sido posible gracias a la ayuda prestada por el Centro Juan Luis Caballero UNIVERSIDAD DE NAVARRA Académico Romano Fundación (CARF) Fernando Milán UNIVERSIDAD DE NAVARRA SECRETARIA Isabel León UNIVERSIDAD DE NAVARRA Redacción, Edita: Fotocomposición: DL: NA 733-1984 administración, Servicio de Publicaciones Pretexto SP ISSN: 0214-6827 intercambios y de la Universidad Imprime: suscripciones: de Navarra, S.A. Ulzama Digital Excerpta e Dissertationibus Campus Universitario in Sacra Theologia. 31080 Pamplona (España) Tamaño: 170 x 240 mm Facultad de Teología. T. 948 425 600 Universidad de Navarra. 31080 Pamplona Precios 2017: (España) Suscripciones 1 año: 30 € Tel: 948 425 600. Extranjero: 43 € Fax: 948 425 633. e-mail: [email protected] EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA cuadernos doctorales DE LA Facultad DE teologÍA VOLUMEN 66 / 2017 Pablo GONZÁLEZ-ALONSO El hijo del Hombre de Jn 3,13 a la luz de la literatura apocalíptica 5-81 Tesis doctoral dirigida por el Prof. -

The Renewal of the Ambrosian and the Hispano-Mozarabic Liturgy After the Second Vatican Council
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 66 (2013) nr 3 REV. TOMASZ BAĆ The Renewal of the Ambrosian and the Hispano-Mozarabic Liturgy after the Second Vatican Council The renewal of the liturgy and its general reform made after the Second Vatican Council generally concerns the Roman Rite, which all instruc- tions of the Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium refer to. The conciliar fathers were well aware of the fact that there is a need for renewing other rites and traditions existing in the Church.1 In the introduction to the first conciliar constitution it was stated that: “In faithful obedience to tradition, the sacred Council declares that holy Mother Church holds all lawfully acknowledged rites to be of equal right and dignity; that she wishes to preserve them in the future and to foster them in every way. The Council also desires that, where necessary, the rites be revised carefully in the light of sound tradition, and that they be given new vigor to meet the circumstances and needs of modern times” (Constitution Sacrosanctum Concilium, 4). In the Latin Church, from among many local rites which, throughout centuries and alongside the Roman Rite, served as evidence of the rich- ness of the Christian liturgy, tradition and culture, only two rites were 1 In the context of liturgy renewal after the Second Vatican Council the terms “rite” and “liturgy” may be considered to be synonyms, although their meaning is not, in fact, identical; cf. A. M. Triacca, La Liturgia ambrosiana, [in:] La Liturgia: panorama storico generale, Genova 2002, p. 88 (Anàmnesis, 2). -

COMUNICATO STAMPA N. 105/2017 SABATO
COMUNICATO STAMPA n. 105/2017 SABATO 20 MAGGIO IN DUOMO LA MESSA PER IL 25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL CARDINALE GIOVANNI COLOMBO ARCIVESCOVO DI MILANO NEGLI ANNI ’60 e ‘70 Milano 18 maggio 2017 – Domani, sabato 20 maggio, alle 17.30, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, presiederà la Messa nel 25° anniversario della morte del cardinale Giovanni Colombo, alla guida della Diocesi ambrosiana dal 1963 al 1979. Giovanni Umberto Colombo nacque a Caronno Pertusella (Va) il 6 dicembre 1902. Nel 1914 entrò come alunno del ginnasio nel Seminario di San Pietro Martire a Seveso. Passò poi al Seminario liceale di Monza, per poi proseguire gli studi di teologia nella Sede del Seminario di Corso Venezia a Milano, l’attuale Centro Pastorale Paolo VI. Il 29 maggio 1926 fu ordinato sacerdote in Duomo dall’allora Arcivescovo cardinale Eugenio Tosi. Subito dopo l’ordinazione sacerdotale si laureò in teologia (1926) e iniziò a frequentare l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si laureò in Lettere nel 1932. Fu presto incaricato come docente di materie letterarie e poi di teologia spirituale nei Seminari diocesani. Fu anche per due anni Lettore di lingua e letteratura italiana presso la Facoltà di Magistero e Lettere dell’Università Cattolica. Nel 1939 il cardinale Schuster lo nominò rettore del Liceo Classico del Seminario nella nuova sede di Venegono Inferiore. Nel 1953 lo stesso Arcivescovo lo nominò Rettore Maggiore dei Seminari milanesi. Tra le iniziative di maggior rilievo da lui promosse durante gli anni del suo rettorato vanno ricordate la fondazione della Scuola Vocazioni Adulte (1947) e l’organizzazione del Corso propedeutico di spiritualità e filosofia, per i chierici che passavano dal liceo alla teologia (1960). -

Evidence from 500 Years of Betting on Papal Conclaves
Forecasting the Outcome of Closed-Door Decisions: evidence from 500 years of betting on papal conclaves October 2014 Leighton Vaughan Williams Professor of Economics and Finance Nottingham Business School Nottingham Trent University Burton Street Nottingham NG1 4BU United Kingdom Tel: +44 115 848 6150 Email: [email protected] David Paton* Professor of Industrial Economics Nottingham University Business School Wollaton Road Nottingham NG8 1BB United Kingdom Tel: +44 115 846 6601 Fax: +44 115 846 6667 Email: [email protected] * corresponding author Acknowledgements We would like to thank participants at a Nottingham Trent University Staff Seminar and at Georgia State University’s ‘Center for the Economic Analysis of Risk’ Workshop, held in January, 2014 at the University of Cape Town, for several helpful comments and suggestions. Forecasting the Outcome of Closed-Door Decisions: evidence from 500 years of betting on papal conclaves. Abstract Closed-door decisions may be defined as decisions in which the outcome is determined by a limited number of decision-makers and where the process is shrouded in at least some secrecy. In this paper, we examine the use of betting markets to forecast on particular closed- door decision, the election of the Pope. Within the context of 500 years of papal election betting, we employ a unique dataset of betting on the 2013 papal election to investigate how new public information is incorporated into the betting odds. Our results suggest that the market was generally unable to incorporate effectively such information. We venture some possible explanations for our findings and offer suggestions for further research into the prediction and predictability of other ‘closed-door’ decisions. -

Benvenuto Monsignor Delpini, Grazie Cardinale Scola Monsignor Mario Delpini, 66 Anni, È Il Nuo- a Partire Da Quel Giorno, in Ogni Celebrazio- Vo Arcivescovo Di Milano
www.parrocchiasanmartinobollate.com ANNO XVII Radio Città Bollate fm 101,7 numero 35 27 agosto 3 settembre 2017 SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO BENVENUTO MONSIGNOR DELPINI, GRAZIE CARDINALE SCOLA Monsignor Mario Delpini, 66 anni, è il nuo- A partire da quel giorno, in ogni Celebrazio- vo Arcivescovo di Milano. La nomina da parte ne eucaristica si ricorderà il nome del vescovo di papa Francesco è stata comunicata lo scorso Mario. venerdì 7 luglio nella Curia arcivescovile dal L’ingresso ufficiale in Diocesi si svolgerà, se- cardinale Angelo Scola. condo la tradizione, domenica 24 settembre, L’annuncio è stato accolto dal suono festoso con la tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16 e delle campane delle parrocchie ambrosiane. l’ingresso in Duomo alle ore 17. Nato a Gallarate (Varese) il 29 luglio 1951, Delpini è stato ordinato sacerdote dal cardina- GRAZIE CARDINALE ScOLA le Giovanni Colombo il 7 giugno 1975. Elet- L’8 settembre ci sarà il saluto al cardinale Sco- to Vescovo titolare di Stefaniaco il 13 luglio la. La Chiesa ambrosiana esprimerà la propria 2007, è stato ordinato dal cardinale Dionigi riconoscenza al pastore che ha guidato la Dio- Tettamanzi nel Duomo cesi negli ultimi 6 anni. di Milano il 23 settem- Aiutatemi Venerdì 8 settembre alle bre successivo. Già Rettore ore 21 in Duomo con la maggiore del Seminario ar- in “questo compito. celebrazione del Pontifi- civescovile di Milano e Vi- Riscopriamo insieme cale nella Solennità della cario episcopale, nel 2012 è Natività della Beata Ver- stato nominato Vicario ge- la gioia di una Chiesa gine Maria, presieduta dal nerale dal cardinale Scola. -

Pope Paul VI
The weather Mostly cloudy and very humid with periods of showers and thunderstorms and patchy fog through Tuesday. Highs both days around 80,27 C. anrljpatpr lEupitiug Hrralft Lows tonight 65 to 70. Chance of rain 80 percent through Tuesday. Outlook: Variable cloudiness A Family NEWSpaper Since 1881 with chance of showers or thunderstorms Home delivered copy 15 cents Wednesday and Thursday. Partial clearing Friday. National weather map: page 17. Vol. XCVII, No. 261°— Manchester, Conn., Monday, August 7, ld78 Newsstand copy 20 cents / V Cardinals summoned to Rome Inside today Church starts ritual il Pope Paul VI to select next pope The guns fell silent briefly in Lebanon, and West German VATICAN CITY (UPI) - The gave up because of the pushing and television broke into its regular Vatican summoned the princes of the shoving and tried to turn back, programming with Mozart’s Roman Catholic church from around further impeding the flow of visitors “R^uiem .” In New York, the the world to Rome today to begin the to the papal chamber. word passed solemnly from ritual of choosing a successor to Flags throughout Italy were church to church: “Ring your ordered flown at half staff for three bells. The pope has died.” See Pope Paul VI, who died Sunday at the age of 80. days — the period of public mourning page 14. ’The Vatican announced that the before the body of the pontiff is Pope Paul Vi’s successor, pope’s body 'wtH- be moved buried in the crypts of St. Peter’s. whose election will decide the Wednesday from the papal summer A man fired several pistol shots in future of the Roman Catholic palace at Castel Gandolfo to the St. -

Necrology O.M.I
NECROLOGY O.M.I. 2019.11.01 - Per diem Curia Generalizia Via Aurelia 290 00165 Roma ITALIA Back to our main database page 1 January Name place of death year of death Sc. Urbanus Vacher Aix 1853 Fr. Nicolaus Crane Sandhurst 1903 Fr. Michael Weber Le Bestin 1912 Fr. Paulus Bonnet Marseille 1919 Fr. Rodulfus Desmarais Hull 1929 Fr. Antonius Nordmann Gelsenkirchen 1935 Fr. Gulielmus Stanton Blenheim 1937 Fr. Gustavus Simonin Hobbema 1941 Fr. Cyprianus Bâtie St-Albert 1949 Fr. Georgius Kalb Usakos 1957 Fr. Ludovicus R. Lafleur Amos 1973 Fr. Kazimierz Czajka Morteaux 1984 Bro. Rémi Lyonnais Cap-de-la-Madeleine 1985 Fr. Paul Dufour Ottawa 1987 Fr. Julien Wijnants Ingolstadt 1992 Fr. Ettore Campagnano Albano 1994 Fr. Raymond Groulx Richelieu 1996 Fr. Bernard Hoffman Marseille 1999 Fr. Joseph Deehan Dublin 2001 Bro. René Darroux Lyon 2010 Fr. Louis Van den Eynde Geel 2014 Fr. Domenico Vitantonio Pescara 2015 Fr. François Buteau Richelieu 2019 2 January Name place of death year of death Fr. Ludovicus Belner Montréal 1879 Fr. Jacobus Walsh Lac Okanagan 1897 Fr. Julius Faugle Paris 1904 Fr. Franciscus Palm Macklin 1929 Bro. Joannes-Maria Pouliquen Le Pas 1936 Fr. Joannes A. Coumet Lyon 1940 Bro. Carolus Gaudel Pontmain 1941 necrology.cfm.html[27-Oct-19 8:26:47 AM] Fr. Jacobus J. Kenny Limerick 1959 Bro. Antonius Lintemeir Windhoek 1962 Fr. Joannes Straka Goyau 1970 Bro. Hugo Dwan Belmont 1971 Fr. Antonius B. McLean Belleville 1973 Fr. Augustinus Bastian Koblenz 1975 Fr. Dominique Noye Maroua 1983 Fr. Pierre Le Cossec Pontmain 1985 Fr. Clément Frappier Maillardville 1986 Bro.