Studi E Ricerche, Vol. V (2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Specola Vaticana: Astronomy at the Vatican
Organizations, People and Strategies in Astronomy 2 (OPSA 2), 217-230 Ed. A. Heck, © 2013 Venngeist. THE SPECOLA VATICANA: ASTRONOMY AT THE VATICAN GUY CONSOLMAGNO AND CHRISTOPHER CORBALLY Specola Vaticana V-00120, Vatican City State [email protected] [email protected] Abstract. The Vatican is an independent nation, with its own national astronomical observatory, the Specola Vaticana (Vatican Observatory). As- tronomy has been supported at the Vatican since the 1582 reform of the calendar; the present-day Observatory has been in operation since 1891. The work of the observatory is divided between two sites, one in the pa- pal summer gardens south of Rome, Italy, and the other affiliated with the Steward Observatory at the University of Arizona, in Tucson, Arizona, USA. Research undertaken by current staff members ranges from cosmol- ogy and the study of galactic evolution to meteoritics and meteors. Given the stable funding provided by the Vatican, the Observatory has specialized in long-term mapping and cataloguing projects that would be difficult to mount under a traditional three-year funding cycle. These have included participation in the Carte du Ciel photographic map of the sky; the at- lases of spectra produced by its Spectrochemical Laboratory; surveys of star clusters and peculiar stars; and the cataloguing of meteorite physical properties. 1. Astronomy in the Holy See Before 1891 To the Christian church, the study of creation has long been supported as an act of worshipping the Creator. Astronomy was one of the seven subjects that made up the curriculum of the medieval universities, which were themselves founded by the Church. -

Historical & Cultural Astronomy
Historical & Cultural Astronomy Series Editor: WAYNE ORCHISTON, University of Southern Queensland, Australia ([email protected]) MARC ROTHENBERG, Smithsonian Institution (retired), USA ([email protected]) CLIFFORD CUNNINGHAM, University of Southern Queensland, Australia ([email protected]) Editorial Board: JAMES EVANS, University of Puget Sound, USA MILLER GOSS, National Radio Astronomy Observatory, USA DUANE HAMACHER, Monash University, Australia JAMES LEQUEUX, Observatoire de Paris, France SIMON MITTON, St. Edmund’s College Cambridge University, UK CLIVE RUGGLES, University of Leicester, UK VIRGINIA TRIMBLE, University of California Irvine, USA GUDRUN WOLFSCHMIDT, Institute for History of Science and Technology, Germany TRUDY BELL, Sky & Telescope, USA More information about this series at http://www.springer.com/series/15156 Ileana Chinnici • Guy Consolmagno Editors Angelo Secchi and Nineteenth Century Science The Multidisciplinary Contributions of a Pioneer and Innovator Editors Ileana Chinnici Guy Consolmagno INAF Vatican Observatory Osservatorio Astronomico di Palermo Vatican City State, Holy See Palermo, Italy ISSN 2509-310X ISSN 2509-3118 (electronic) Historical & Cultural Astronomy ISBN 978-3-030-58383-5 ISBN 978-3-030-58384-2 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-58384-2 © Springer Nature Switzerland AG 2021 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifcally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microflms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. -

15 August 2018 Monthly Year 2
0818 15 August 2018 Monthly Year 2 Power in the Bible Net Neutrality and the Technology Environment .8 O Multitasking: Opportunity or Weakness? Ethical Discernment and Economic- OLUME 2, N 2, OLUME Financial Questions V The War in Syria 2018 Ecumenism and Global Governance: Pope Francis in Geneva Father Angelo Secchi, Jesuit and Scientist The Shape of Water, a film by Guillermo Del Toro CONTENTS 0818 BEATUS POPULUS, CUIUS DOMINUS DEUS EIUS Copyright, 2017, Union of Catholic Asian Editor-in-chief News ANTONIO SPADARO, SJ All rights reserved. Except for any fair Editorial Board dealing permitted under the Hong Kong Antonio Spadaro, SJ – Director Copyright Ordinance, no part of this Giancarlo Pani, SJ – Vice-Director publication may be reproduced by any Domenico Ronchitelli, SJ – Senior Editor means without prior permission. Inquiries Giovanni Cucci, SJ, Diego Fares, SJ should be made to the publisher. Francesco Occhetta, SJ, Giovanni Sale, SJ Title: La Civiltà Cattolica, English Edition Emeritus editor Virgilio Fantuzzi, SJ ISSN: 2207-2446 Giandomenico Mucci, SJ GianPaolo Salvini, SJ ISBN: 978-1-925612-54-7 (paperback) Contributing Editor 978-1-925612-55-4 (ebook) Luke Hansen, SJ 978-1-925612-56-1 (kindle) Contributors Published by Federico Lombardi, SJ (Italy) Union of Catholic Asian News George Ruyssen, SJ (Belgium) Fernando De la Iglesia, SJ (Spain) P.O. Box 80488, Cheung Sha Wan, Drew Christiansen, SJ (USA) Kowloon, Hong Kong Andrea Vicini, SJ (USA) Phone: +852 2727 2018 David Neuhaus, SJ (Israel) Fax: +852 2772 7656 Camilo Ripamonti, SJ (Italy) www.ucanews.com Vladimir Pachkow, SJ (Russia) Publishers: Michael Kelly, SJ and Arturo Peraza, SJ (Venezuela) Robert Barber Bert Daelemans, SJ (Belgium) Production Manager: Thomas Reese, SJ (USA) Rangsan Panpairee Paul Soukup, SJ (USA) Grithanai Napasrapiwong Friedhelm Mennekes, SJ (Germany) Marcel Uwineza, SJ (Rwanda) Marc Rastoin, SJ (France) CONTENTS 0818 15 August 2018 Monthly Year 2 1 Power in the Bible Giancarlo Pani, SJ 13 Net Neutrality and the Technology Environment Paul A. -
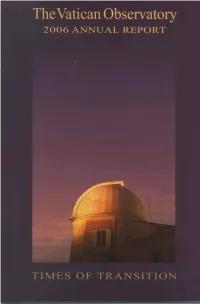
Annual Report 2006
Vatican Observatory Annual Report 2006 Vatican Observatory (Castel Gandolfo) V-00120 Città del Vaticano Rome ITALY Vatican Observatory Research Group Steward Observatory University of Arizona Tucson, Arizona 85721 USA http://vaticanobservatory.org Vatican Observatory Publications Vatican Observatory Staff The following are permanent staff members of the Vatican Observatory, Castel Gandolfo, Italy, and the Vatican Observatory Research Group (VORG), Tucson, Arizona, USA. JOSÉ G. FUNES, , S.J., Director, Vatican Observatory JAMES J. BOWES, S.J., Superior, Jesuit Community, Tucson GIUSEPPE KOCH, S.J., Superior, Jesuit Community, Castel Gandolfo RICHARD P. BOYLE, S.J. ALESSANDRO OMIZZOLO JUAN CASANOVAS, S.J. WILLIAM R. STOEGER, S.J. GUY J. CONSOLMAGNO, S.J. Coordinator for Science and Theology Coordinator for Public Relations Programs CHRISTOPHER J. CORBALLY, S.J., ANDREW P. WHITMAN, S.J., Vice Director for VORG; Administrator VORG President, National Committee to International Astronomical Union Adjunct Scholars: GEORGE V. COYNE, S.J. EMMANUEL M. CARREIRA, S.J. JEAN-BAPTISTE KIKWAYA ELUO, S.J. LOUIS CARUANA, S.J. GIUSEPPE KOCH, S.J. ROBERT JANUSZ, S.J. Vice Director for Administration MICHAEL HELLER SABINO MAFFEO, S.J., GUSTAV TERES, S.J. Special Assistant to the Director Vatican Observatory Foundation Board of Directors Officers GEORGE V. COYNE, S.J., President BEN DALBY, Chairman of the Board CHRISTOPHER J. CORBALLY, S.J., First Vice President RICHARD P. BOYLE, S.J., Second Vice President WILLIAM R. STOEGER, S.J., Secretary MANUEL J. ESPINOZA, Treasurer Directors RENATO BOCCARDO JOSÉ G. FUNES, S.J. RICHARD P. BOYLE, S.J. JOHN B. HENKELS CHRISTOPHER J. CORBALLY, S.J. CHRISTOPHER P. HITCHCOCK GEORGE V. -

Cameron Bellm
Christ Plays in Ten Thousand Places: Through the Year with Ignatian Spirituality Edited by Cameron Bellm Art by Erica Ploucha, Erica Tighe Campbell and Molly Noem Fulton In Celebration of the Ignatian Year 2021-2022 Jesuits.org ©2021 Jesuit Conference of Canada and the United States Contents Introduction, by Cameron Bellm 4 Summer A Prayer for the Feast of St. Ignatius, by Cameron Bellm 8 A Pilgrim’s Summer Vacation, by Josh Utter 9 Creation Again, by Fr. Greg Kennedy, SJ 10 The Examen, by Cameron Bellm 11 Finding God in All Things, by Grace Salceanu 13 The Spiritual Exercises, by Nick Ripatrazone 16 Autumn Divine Presence in the Season of Creation, by Ashley Hai? Vân Trân` 20 St. Alphonsus Rodriguez and the Call to Hospitality, by Br. Matt Wooters, SJ 22 A Prayer for Black Catholic History Month, by Cameron Bellm 24 A Prayer for All Saints’ Day, by Joan Rosenhauer 26 All Souls’ Day, by Mike Jordan Laskey 28 The Challenge of Blessed Miguel Pro, by Christopher Smith, SJ 30 Autumn Speaks, by Vinita Hampton Wright 33 Winter Advent, by MegAnne Liebsch 38 In the Nativity, by Elise Gower 40 Imaginative Prayer: Where We Meet, by Danielle Harrison 41 A New Serenity Prayer, by Fr. James Martin, SJ 43 St. Francis Xavier, by Fr. Michael Rossmann, SJ 45 Christmas, by Shannon K. Evans 47 Mappers of Time and Space, by Br. Guy Consolmagno, SJ 48 Spring Ash Wednesday, by Fr. Mark Thibodeaux, SJ 52 Lent: Resurrection Journey, by Sr. Colleen Gibson, SSJ 54 The Novena of Grace, by Fr. -

WOMEN of the STARS: TWENTY-ONE REMARKABLE ASTRONOMERS with Dr
WOMEN OF THE STARS: TWENTY-ONE REMARKABLE ASTRONOMERS with Dr. Bill Thierfelder Professor of Arts and Humanities, Dowling College (Ret) Visiting Docent, American Museum of Natural History website: www.makingwings.net "We look at science as something very elite, which only a few people can learn. That's just not true. You just have to start early and give kids a foundation. Kids live up, or down, to expectations." --Mae Jemison: first Black woman in space, medical doctor, and astrophysicist INTRODUCTION Women have always studied the night sky. Five thousand years ago, priestesses studied the stars and planets as a way to forecast human and heavenly events. Yet the names of most of these women have been lost. One exception is EnHeduanna, a high-ranking astronomer-priestess in [ancient] Babylon, although it is her poetry [that] survives to the present. Better known by far is Hypatia of Alexandria. And even in her case, the amount of information we have is tiny compared to her status in the ancient world. It is as if we could see two thousand years into the future and find that no one remembers anything about Albert Einstein except his name. From Hypatia’s death around 370 CE to Caroline Herschel’s career in the late 1700s and early 1800s, information about women in science nearly disappeared from Western history. Belief in astrology largely replaced the study of astronomy. Most of those who observed the night sky looked for omens and portents. A few people tried to understand the motion of planets and stars [, but] they lacked the Women of the Stars Dr. -

Angelo Secchi and Nineteenth Century Science the Multidisciplinary Contributions of a Pioneer and Innovator Historical & Cultural Astronomy
Historical & Cultural Astronomy Series Editors: W. Orchiston · M. Rothenberg · C. Cunningham Ileana Chinnici Guy Consolmagno Editors Angelo Secchi and Nineteenth Century Science The Multidisciplinary Contributions of a Pioneer and Innovator Historical & Cultural Astronomy Series Editor: WAYNE ORCHISTON, University of Southern Queensland, Australia ([email protected]) MARC ROTHENBERG, Smithsonian Institution (retired), USA ([email protected]) CLIFFORD CUNNINGHAM, University of Southern Queensland, Australia ([email protected]) Editorial Board: JAMES EVANS, University of Puget Sound, USA MILLER GOSS, National Radio Astronomy Observatory, USA DUANE HAMACHER, Monash University, Australia JAMES LEQUEUX, Observatoire de Paris, France SIMON MITTON, St. Edmund’s College Cambridge University, UK CLIVE RUGGLES, University of Leicester, UK VIRGINIA TRIMBLE, University of California Irvine, USA GUDRUN WOLFSCHMIDT, Institute for History of Science and Technology, Germany TRUDY BELL, Sky & Telescope, USA More information about this series at http://www.springer.com/series/15156 Ileana Chinnici • Guy Consolmagno Editors Angelo Secchi and Nineteenth Century Science The Multidisciplinary Contributions of a Pioneer and Innovator Editors Ileana Chinnici Guy Consolmagno INAF Vatican Observatory Osservatorio Astronomico di Palermo Vatican City State, Holy See Palermo, Italy ISSN 2509-310X ISSN 2509-3118 (electronic) Historical & Cultural Astronomy ISBN 978-3-030-58383-5 ISBN 978-3-030-58384-2 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-58384-2 © Springer Nature Switzerland AG 2021 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifcally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microflms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. -

God's Astronomer
God’s Astronomer Jesuit Priest Father Pietro Angelo Secchi A ‘Catchers Tale’ Featuring Featuringthe Forgotten the Forgotten LivesLives of theof Men the and Men Women and who FirstWomen who First PhotographedPhotographed the Heavens the Heavens Stefan Hughes Contents 1 ‘Catchers Tales’ 1 1.1 Introduction 2 1.2 Pope Francis I 4 1.3 The Roman Catholic Church 5 2. The Life & Work of Father Secchi 6 2.1 Jesuits - the Soldiers of God 7 2.2 Exile in England and America 10 2.3 Osservatorio del Collegio Romano 13 2.4 Eclipse at Desierto de Las Palmas 19 2.5 Understanding God’s Kingdom 24 2.6 End of his Time on Earth 32 3. Appendices 34 A. The Jesuits & Science 35 B. Secchi Classes 36 C. Glossary of Terms 40 4. End Piece 42 Family Pedigree: Father Pietro Angelo Secchi 43 Acknowledgements 43 Notes & Bibliography 43 Index 49 The Author 52 1 1. The ‘Catchers Tales’ Catchers of the Light Father Pietro Angelo Secchi ‘Servant of God’ The Forgotten Lives of the Men and Women who First Photographed the Heavens Their True Tales of Adventure, Adversity & Triumph Stefan Hughes1 1.1 Introduction The ‘Catchers Tales’, each feature a single life of one of the men and women who first photographed the heavens. Their lives are ones full of adventure, adversity and triumph - which would test the abilities of even the best author or screenwriter to recreate as a work of fiction. Sadly their names are largely unknown and all but forgotten - confined now to the closed pages of history.