Le Macerie Invisibili Rapporto 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ercolano, Naples
University of Bath PHD Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Bowkett, Chris Award date: 2017 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Christopher Bowkett A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Bath Department of Politics, Languages & International Studies September 2017 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis/portfolio rests with the author and copyright of any previously published materials included may rest with third parties. A copy of this thesis/portfolio has been supplied on condition that anyone who consults it understands that they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author or other copyright owners, as applicable. -

Regional Macroseismic Field of the 1980 Irpinia Earthquake
Regional macroseismic field of the 1980 Irpinia earthquake A. BOTTARI* - L. GIOVANI** - E. Lo GIUDICE0 - V. LONGO0 M. C. SPADEA** - M. VECCHI** Received on December 2Ist, 1981 RIASSUNTO E presentata un'analisi del campo macrosismico del terremoto irpino del 1980 che per magnitudo ed estensione dell'area interessata risulta il maggiore evento sismico verificatosi in Italia negli ultimi cinquanta anni. L'insieme dei dati rilevati mediante indagini dirette e/o a mezzo scheda macrosismica consente la definizione dell'intensità sismica in 1286 centri abitati di 13 regioni. Il campo regionale confrontato con i modelli di Blake (Y= 5.0), risulta compatibile con i seguenti parametri focali I0 = X" MSK ; <P0 = = 40.86 N ; = 15.25 E ; = 9.99 ± 0.5 MSK ; h,, = 15 Km. L'anisotropia del campo regionale è analizzata mediante la determinazione dell'attenuazione azimutale dell'intensità (a. z) i cui valori estremi risultano 2.0- IO"3 e 3.9 • IO"3, rispettivamente lungo le direzioni NNW e SW. e 3.9 • IO"3, rispettivamente lungo le direzioni NNW e SW. L'area mesosismica risulta caratterizzata principalmente da domini strutturali, rilevati con il metodo shadow, con direzione appenninica (NW-SE), antiappennini- ca e meridiana (N-S). * Istituto Geofisico, University of Messina. ** Istituto Internazionale di Geofisica, Rome. 0 Istituto Internazionale di Vulcanologia - CNR, Catania. 28 A. BOTTARI - L. GIOVANI - E. LO GIUDICE - V. LONGO - M. C. SPADEA - M. VECCHI Un modello per la sorgente sismica è stato elaborato secondo la metodologia di Shebalin. I relativi valori dei parametri risultano: lxl =14 Km ; Az =128° E lx = 56 Km ; » = 61° (dip SW) 2 lz = 13.5 Km ; SD =782 Km L'azimuth della sezione longitudinale della sorgente (128° E) risulta molto prossimo a quello di strike del piano di faglia proposto da vari autori nella soluzione del meccanismo focale; l'estensione longitudinale ed il relativo modesto sviluppo verticale sono considerati nel contesto del quadro geo-sismotettonico della regione irpina. -

Progetto CARG Per Il Servizio Geologico D’Italia - ISPRA: F
I S P R A Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Organo Cartografi co dello Stato (legge n°68 del 2.2.1960) NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 450 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI A cura di: T. S. Pescatore1†, F. Pinto1 Con contributi di: P. Galli2 (Sismicità e Strutture Sismogeniche) S. I. Giano3 (Geologia del Quaternario e Geomorfologia) R. Quarantiello1 (Geologia Applicata) M. Schiattarella3 (Tettonica e Morfotettonica) PROGETTORedazione scientifica: M.L. Putignano4 1 Dipartimento di Scienze per la Biologia, Geologia e l’Ambiente, Università degli Studi del Sannio - Benevento 2 Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - Roma 3 Dipartimento Scienze Geologiche, Università degli Studi della Basilicata - Potenza 4 Istituto di Geologia Ambientali e Geoingegneria - IGAG - CNR - RomaCARG CNR Ente realizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche NoteIllustrative F450_S.Angelo dei Lomabardi_17_01_2020_cc.indd 1 17/01/2020 16:20:53 Direttore del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: C. Campobasso Responsabile del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: F. Galluzzo Responsabile del Progetto CARG per il CNR: R. Polino (IGG), fino al 2009, P. Messina (IGAG) Gestione operativa del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: M.T. Lettieri per il Consiglo Nazionale delle Ricerche - CNR: P. Messina (IGAG) PER IL SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA - ISPRA: Revisione scientifica: R. Di Stefano (†), A. Fiorentino, F. Papasodaro, P. Perini Coordinamento cartografico: D. Tacchia (coord.), S. Grossi Revisione informatizzazione dei dati geologici: L. Battaglini, R. Carta, A. Fiorentino (ASC) Coordinamento editoriale: D. Tacchia (coord.), S. Grossi PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE: Funz. -

Recorded Motions of the 6 April 2009 Mw 6.3 L'aquila, Italy, Earthquake
Recorded Motions of the 6 April 2009 Mw 6.3 L’Aquila, Italy, Earthquake and Implications for Building Structural Damage: Overview a) b) c) Mehmet Çelebi, M.EERI, Paolo Bazzurro, M.EERI, Lauro Chiaraluce, Paolo Clemente,d) Luis Decanini,e) Adriano DeSortis,f) William Ellsworth,a) f) a) f) M.EERI, Antonella Gorini, Erol Kalkan, M.EERI, Sandro Marcucci, Guiliano Milana,c) Fabrizio Mollaioli,e) Marco Olivieri,c) Roberto Paolucci,g) Dario Rinaldis,d) Antonio Rovelli,c) Fabio Sabetta,f) and a) Christopher Stephens, M.EERI The normal-faulting earthquake of 6 April 2009 in the Abruzzo Region of central Italy caused heavy losses of life and substantial damage to centuries- old buildings of significant cultural importance and to modern reinforced- concrete-framed buildings with hollow masonry infill walls. Although structural deficiencies were significant and widespread, the study of the characteristics of strong motion data from the heavily affected area indicated that the short duration of strong shaking may have spared many more damaged buildings from collapsing. It is recognized that, with this caveat of short- duration shaking, the infill walls may have played a very important role in preventing further deterioration or collapse of many buildings. It is concluded that better new or retrofit construction practices that include reinforced- concrete shear walls may prove helpful in reducing risks in such seismic areas of Italy, other Mediterranean countries, and even in United States, where there are large inventories of deficient structures. ͓DOI: 10.1193/1.3450317͔ INTRODUCTION THE EARTHQUAKE: GENERAL INFORMATION A significant normal-faulting earthquake shook the Abruzzo Region of Central Italy on 6 April 2009 starting at 1:32:39 UTC (Figure 1). -

Areal Distribution of Ground Effects Induced by Strong Earthquakes in the Southern Apennines (Italy)
AREAL DISTRIBUTION OF GROUND EFFECTS INDUCED BY STRONG EARTHQUAKES IN THE SOUTHERN APENNINES (ITALY) S. PORFIDO1, E. ESPOSITO1,E.VITTORI2, G. TRANFAGLIA3, A.M. MICHETTI4, M. BLUMETTI5, L. FERRELI2, L. GUERRIERI2 and L. SERVA2 1Istituto di Ricerca Geomare Sud - C.N.R., Via A. Vespucci, 9, 80142, Napoli, Italy E-mail: porfi[email protected] 2ANPA – Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Via Vitaliano Brancati, 48, 00144, Rome, Italy 3Servizio Idrografico e Mareografico, Via Marchese Campodisola 21, 80133 Napoli, Italy 4Dipartimento di Scienze CC.FF.MM, Universitá dell’Insubria, Via Lucini, 3, 22100, Como, Italy 5Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Sismico, Via Curtatone, 3, 00185, Rome, Italy (Received 2 January 2002; Accepted 17 June 2002) Abstract. Moderate to strong crustal earthquakes are generally accompanied by a distinctive pattern of coseismic geological phenomena, ranging from surface faulting to ground cracks, landslides, liquefaction/compaction, which leave a permanent mark in the landscape. Therefore, the repetition of surface faulting earthquakes over a geologic time interval determines a characteristic morphology closely related to seismic potential. To support this statement, the areal distribution and dimensions of effects of recent historical earthquakes in the Southern Apennines are being investigated in detail. This paper presents results concerning the 26 July 1805 earthquake in the Molise region, (I =X MCS, M = 6.8), and the 23 November 1980 earthquake in the Campania and Basilicata regions (I =XMSK,Ms = 6.9). Landslide data are also compared with two other historical earthquakes in the same region with similar macroseismic intensity. The number of significant effects (either ground deformation or hydrological anomalies) versus their minimum distance from the causative fault have been statistically analyzed, finding characteristic relationships. -

The President During the So-Called Second Republic: from Veto Player to First in Command?
Selena Grimaldi University of Padova The President during the so-called Second Republic: from veto player to first in command? Abstract The role of the Head of State in parliamentary democracies is not taken into consideration by Lijphart, although it might become fundamental when representative institutions are unstable or unable to decide. With the Italian case in particular, the President can turn into both a powerful veto player for the government and a sort of deputy chairman. From Scalfaro to Napolitano all the presidents have had a great impact on the political scene, especially, when governments and parties have seemed to be particularly weak. So far, scholars have debated on systemic features having caused the enlargement of presidential powers, but there have apparently been few attempts to consider presidential involvement in the decision process as an aspect of the questionable change from one model of democracy to the other. Taking into account Lijphart's framework, the paper explains why the presidency can be considered as an institution in tension between the consensual and the majoritarian pole. 1 Introduction The variables chosen by Lijphart (1999) to differentiate a consensual democracy from a majoritarian one have been criticized by many scholars (Nagel 2000) especially because the reason for their selection is not clear. This defect is particularly true for "the federal-unitary dimension [... which] considers the instances in which bodies other than the government are involved in the decision process" (Blondel, Battegazzore 2003, 12). The role of the Head of State in parliamentary democracies, for instance, is not taken into consideration by Lijphart, although it might become fundamental when representative institutions are unstable or unable to decide. -

Earthquake-Induced Ground Failures in Italy from a Reviewed Database
Open Access Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 799–814, 2014 Natural Hazards www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/14/799/2014/ doi:10.5194/nhess-14-799-2014 and Earth System © Author(s) 2014. CC Attribution 3.0 License. Sciences Earthquake-induced ground failures in Italy from a reviewed database S. Martino1, A. Prestininzi1, and R. W. Romeo2 1Sapienza University of Rome, Department of Earth Sciences and Research Centre for Geological Risks (CERI), P.le A. Moro 5, 00185, Rome, Italy 2Department of Earth Sciences, Life and Environment, University of Urbino, Italy Correspondence to: S. Martino ([email protected]) Received: 30 March 2013 – Published in Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.: 17 May 2013 Revised: 16 February 2014 – Accepted: 24 February 2014 – Published: 10 April 2014 Abstract. A database (Italian acronym CEDIT) of 1 Introduction earthquake-induced ground failures in Italy is presented, and the related content is analysed. The catalogue collects data regarding landslides, liquefaction, ground cracks, surface The recent strong earthquakes in Sumatra (2004, Mw = 9.1), faulting and ground changes triggered by earthquakes of eastern Sichuan (China 2008, Mw = 7.9) and Tohoku¯ (Japan Mercalli epicentral intensity 8 or greater that occurred 2011, Mw = 9.0) have highlighted that earthquake-induced in the last millennium in Italy. As of January 2013, the ground effects (e.g. tsunamis, landslides and liquefaction) CEDIT database has been available online for public use can be responsible for major damage and losses, and rep- (http://www.ceri.uniroma1.it/cn/gis.jsp) and is presently resent a significant seismic-activity-related hazard (Bird and hosted by the website of the Research Centre for Geological Bommer, 2004). -

468 Marturano
Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata Vol. 48, n. 2, pp. 115-126; June 2007 The January 15, 1466 and November 23, 1980 Irpinia (Italy) earthquakes A. MARTURANO Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Vesuviano, Napoli, Italy (Received: March 24, 2006; accepted: January 25, 2007) ABSTRACT On the night between 14 and 15 January of 1466, an earthquake damaged towns close to those more recently destroyed by the 1980 Irpinia earthquake. It was felt in Naples, about 80 km from the epicentre, resulting in panic and slight damage. To obtain source parameters related to January 15, 1466, the observed macroseismic field of the November 23, 1980 earthquake was reproduced by synthetic peak strong acceleration. The results suggest that the whole of the 1466 faulting was again activated by the 1980 event and that the northern part remained non-activated. Quite possibly, the near southernmost source of the large earthquake of 1456 affected the occurrence of the 18 nearby event ten years later. Furthermore, the value of Mo=7.5 10 Nm obtained makes the medieval event of 1466 one of the most severe recorded in southern Italy. 1. Introduction: the January 15, 1466 event An earthquake occurred in 1466 on January 15 at about one o’clock (local time) at night. It caused slight damage, but considerable panic in Naples. The people left their homes en masse, sleeping in the open, in shelters and pavilions for many days, and participating in religious processions promptly organized by Archbishop Oliviero Carafa. King Ferrante had gone hunting in Apulia; when coming back, he painstakingly avoided the unsafe villages in the epicentral area. -

The Scientific Landscape of November 23Rd, 1980
geosciences Review The Scientific Landscape of November 23rd, 1980 Irpinia-Basilicata Earthquake: Taking Stock of (Almost) 40 Years of Studies Fabrizio Terenzio Gizzi * and Maria Rosaria Potenza Institute of Heritage Science, National (Italian) Research Council (ISPC-CNR), 00010 Rome, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 29 October 2020; Accepted: 23 November 2020; Published: 28 November 2020 Abstract: The November 23rd, 1980 Irpinia-Basilicata (Southern Italy) earthquake is one of the strongest earthquakes ever occurred in Italy. The earthquake was a natural laboratory for the scientific community,which was engaged highly and promptly in investigating the event, thus publishing a flood of papers in different research areas over time. Just these research outputs are the focus of the article, which examines, with a tailored methodological approach, the international and national (Italian) studies started and advanced since the occurrence of the earthquake. First, we built and analyzed statistically two bibliographic databanks regarding the earthquake studies: (a) the international version of IRpinia Bibliographic databASE (IR_BASE_ENG), selecting and standardizing the pertinent scientific documents extracted from Scopus, Web of Science, and other databases and (b) the national version of the database (IR_BASE_IT) using the Google Scholar search engine to search for the most relevant papers in Italian. Second, IR_BASE_ENG was analyzed in a bibliometric perspective through the data mining VOSviewer software (Waltman et al., 2010) that builds co-occurrence term maps useful in perspective of investigating the wide-ranging studies on the earthquake. Third, taking a cue from this network analysis, we recognized the main research topics and performed a minireview of the related international studies, integrating in it a quick reference to the literature in Italian. -

An Overview of Post-Earthquake Damage Assessment in Italy A
EERI INVITATIONAL WORKSHOP AN ACTION PLAN TO DEVELOP EARTHQUAKE DAMAGE AND LOSS DATA PROTOCOLS September 19th and 20th, 2002 Doubletree Hotel Pasadena, California AN OVERVIEW OF POST-EARTHQUAKE DAMAGE ASSESSMENT IN ITALY A. Goretti, G. Di Pasquale (National Seismic Survey, Department of Civil Protection, Italy) SUMMARY Since many years post-earthquake damage assessment has been in Italy one of the preliminary steps for the establishment of a proper reconstruction strategy. Although the main purpose of the damage assessment has always been the estimate of the direct economic loss, 1st level damage data and building type data have been collected extensively after each destructive and non destructive earthquake. This allows to perform statistical analysis on suffered damage and building type and to obtain correlation with seismic intensity, if the latter one is known. The paper describes old and recent Italian experiences in the field of damage assessment, highlighting resolved, but also not yet resolved problems, that have been encountered in assessing procedures, forms, tools, computerisation, validation, maintenance, and data dissemination. INTRODUCTION In Italy post-earthquake damage assessment has been performed since many centuries ago. After the 1570-1574 Ferrara Earthquake (IX MCS), the duke Estensi gave the architect Ligorio, belonging to the papal court, the responsability of the damage evaluation. His report concerned both public and private buildings and was so detailed that it has been possible to locate the mostly damaged buildings on a plan of the town. The report describes also many features of the local building techniques and includes a surprising list of vulnerability factors, as the “a sacco” masonry walls, the thrusting roofs, the offset floors. -
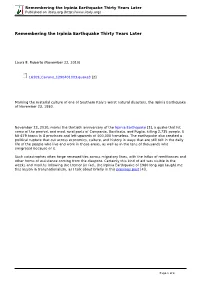
Remembering the Irpinia Earthquake Thirty Years Later Published on Iitaly.Org (
Remembering the Irpinia Earthquake Thirty Years Later Published on iItaly.org (http://www.iitaly.org) Remembering the Irpinia Earthquake Thirty Years Later Laura E. Ruberto (November 22, 2010) 16109_Cairano_1290401003.quake3 [2] Marking the material culture of one of Southern Italy’s worst natural disasters, the Irpinia Earthquake of November 23, 1980. November 23, 2010, marks the thirtieth anniversary of the Irpinia Earthquake [3], a quake that hit some of the poorest and most rural parts of Campania, Basilicata, and Puglia, killing 2,735 people. It hit 679 towns in 8 provinces and left upwards of 400,000 homeless. The earthquake also created a political rupture that cut across economics, culture, and history in ways that are still felt in the daily life of the people who live and work in those areas, as well as in the tens of thousands who emigrated because of it. Such catastrophes often forge renewed ties across migratory lines, with the influx of remittances and other forms of assistance coming from the diaspora. Certainly this kind of aid was visible in the weeks and months following the tremor (in fact, the Irpinia Earthquake of 1980 long ago taught me this lesson in transnationalism, as I talk about briefly in this previous post [4]). Page 1 of 6 Remembering the Irpinia Earthquake Thirty Years Later Published on iItaly.org (http://www.iitaly.org) An example of Italian American aid to earthquake victims. "The Irpinian residents of Erie (PA) help rebuild the town of Altavilla" (Il Progresso Italo-Americano, December 14, 1980) Such geopolitical crossings inform many aspects of megadisasters—human-made and natural alike. -

Insights Into Mechanical Properties of the 1980 Irpinia Fault System from the Analysis of a Seismic Sequence
geosciences Article Insights into Mechanical Properties of the 1980 Irpinia Fault System from the Analysis of a Seismic Sequence Gaetano Festa * , Guido Maria Adinolfi, Alessandro Caruso, Simona Colombelli, Grazia De Landro , Luca Elia , Antonio Emolo, Matteo Picozzi , Antonio Scala , Francesco Carotenuto, Sergio Gammaldi , Antonio Giovanni Iaccarino , Sahar Nazeri, Rosario Riccio, Guido Russo, Stefania Tarantino and Aldo Zollo Physics Department “Ettore Pancini”, University of Naples Federico II, 80126 Napoli, Italy; guidomaria.adinolfi@unina.it (G.M.A.); [email protected] (A.C.); [email protected] (S.C.); [email protected] (G.D.L.); [email protected] (L.E.); [email protected] (A.E.); [email protected] (M.P.); [email protected] (A.S.); [email protected] (F.C.); [email protected] (S.G.); [email protected] (A.G.I.); [email protected] (S.N.); [email protected] (R.R.); [email protected] (G.R.); [email protected] (S.T.); [email protected] (A.Z.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-081-675248 Abstract: Seismic sequences are a powerful tool to locally infer geometrical and mechanical properties of faults and fault systems. In this study, we provided detailed location and characterization of events of the 3–7 July 2020 Irpinia sequence (southern Italy) that occurred at the northern tip of the main segment that ruptured during the 1980 Irpinia earthquake. Using an autocorrelation technique, we detected more than 340 events within the sequence, with local magnitude ranging between −0.5 and 3.0. We thus provided double difference locations, source parameter estimation, and focal mechanisms determination for the largest quality events.