Le Gare Di Corsa Sulle Lunghe Distanze Nel Lazio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Italia / Italy
XIII IAAF World Championships Daegu (KOR) - 27 agosto-4 settembre Italia / Italy I componenti della staffetta 4x100 azzurra medaglia d’argento agli Europei 2010 di Barcellona The Italian 4x100 team, silver medallist at the 2010 European Championships of Brarelona La Delegazione The Delegation FIDAL La Delegazione / The Delegation Federazione Italiana Alberto Morini Capo Delegazione / Head of the Delegation di Atletica Leggera Franco Angelotti Consigliere Addetto / Council Member Italian Athletics Federation Francesco Uguagliati Direttore Tecnico / Technical Director Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma, Italia Vittorio Visini Assistente D.T. / Assistant to TD www.fidal.it Rita Bottiglieri Team Manager Francesco Cuccotti Team Manager Presidente /President Marco Sicari Addetto Stampa / Press Officer Franco Arese Pierluigi Fiorella Medico / Doctor Giuseppe Fischetto Medico / Doctor Consiglieri Antonio Abbruzzese Fisioterapista / Physio Council Members Maria M. Marello Fisioterapista / Physio Alberto Morini (Vice Presidente Vicario / Senior Vice President ) Filippo Di Mulo Tecnico / Coach Adriano Rossi (Vice Presidente / Giuseppe Mannella Tecnico / Coach Vice President ) Roberto Pericoli Tecnico / Coach Stefano Andreatta Fabio Pilori Tecnico / Coach Franco Angelotti Roberto Piscitelli Tecnico / Coach Marcello Bindi Nicola Silvaggi Tecnico / Coach Giovanni Caruso Angelo Zamperin Tecnico / Coach Alessandro Castelli Augusto D’agostino Michele Basile Tecnico Personale / Personal Coach Francesco De Feo Riccardo Ceccarini Tecnico Personale / Personal -

Salma Celeste Paralluelo (41.97 En 300M Vallas) Y Pablo Torrijos (17.09 Triple AL) Mejores Marcas Españolas De La Historia
----------------------------------------------- AATTLLEETTIISSMMOO EENN EESSPPAAAÑÑAAA ---------- 2020 [21] Julio/July (31.7.2020) - Real Federación Española de Atletismo Salma Celeste Paralluelo (41.97 en 300m vallas) y Pablo Torrijos (17.09 triple AL) Mejores marcas españolas de la historia 29.7 Castellón ‐ I REUNION NACIONAL ‐ COMUNITAT DE L´ESPORT Hombres. 100m. Final A (+2,0). 1. Sergio López 10.46 – 2. Alberto Calero 10.56 – 3. Gerard Sapena 10.72 – 1.500m. 1. Mariano García 3:41.93 – 2. Nassim Hassaous 3:42.19 – 3. Mohamed Lansi MAR 3:45.25 – 4. Juan Ignacio Grondona 3:45.52 – 5. Daid Bustios 3:46.39 – 6. Sebastián Martos 3:46.68 – 7. David Lorenzo 3:47.46 – 8. David Bascuñana 3:48.02 – 8. Enrique Herreros 3:48.82 – 10. Abderrahman El Khayami 3:52.51 – 3.000m. Final A.1. Fernando Carro 7:53.62 – 2. Jesús Gómez 7:54.46 – 3. Daniel Arce 7:55.82 – 4. José Ignacio Giménez 7:56.07 – 5. Roberto Alaiz 7:56.30 – 6. Kevin López 8:01.51 – 7. Andreu Blanes 8:07.72 – 8. Aaron Las Heras 9:09.44 – 110m vallas (+2,1). 1. Enrique Llopis 13.84 – 2. Kevin Sánchez 14.00 – 3. Víctor Orduña 14.45 – Altura. 1. Adrián Sobrino 2.06 – 2. Álvaro Martínez 2.03 – 3. Alexis Sastre 2.00 – Longitud. 1. Thierno Amadou Barry 7.45/‐0,3 – 2. Daniel Solís 7.43/+1,9 – 3. Jordi Cots 7.36/+1,6 – 4. Sergio Polo 7.32/+0,9 – Triple. 1. Pablo Torrijos 17.09/+1,6 (16.71/+1,6 – 16.96/+1,3 – x – x – 17.07/+1,9 – 17.09/+1,6) M.M.ESP aire libre ‐ 2. -

Record Storici
RECORD STORICI I primati Mondiali, Europei, Olimpici stabiliti dagli atleti italiani A scorrere le vecchie carte, si rintracciano numerose grandi prestazioni che gli atleti italiani hanno ottenuto nel Secolo XX. Prestazioni delle quali, per la gran parte, si è persa memoria. Quindi, appare opportuno riproporle in quella che potrebbe essere una delle voci di un nostro “ABBECEDARIO” di atletica, un testo di lettura per le prime classi dei dirigenti federali. Il primo record da ricordare, dei più nobili, è quello di Dorando Pietri a Londra 1908: un proto-primato nella Maratona (come avrebbe scritto Bruno Bonomelli …) cancellato alla pari della sua vittoria. Gli ultimi, già molto lontani nel tempo, sono quelli che Maurizio Damilano ha ottenuto sulla pista di Cuneo nell’autunno 1992. Fra mezzo, molti riscontri tecnici di notevole significato temporale e storico. Nelle tabelle che seguono si è tentato un primo elenco – in ordine cronologico – di tutti quei record Mondiali , Europei e Olimpici che hanno fatto la storia dell’atletica italiana, oltre ad una appendice per non tralasciare una serie di risultati che, per vari motivi, non hanno goduto del crisma dell’ufficialità. In chiave storica va ricordato che la federazione italiana è stata fondata a Milano il 21 ottobre 1906 e che la IAAF ha preso corpo a Berlino nell’ agosto 1913 , dopo che il 17 luglio 1912 i rappresentanti di 17 nazioni – riunitisi a Stoccolma durante i Giochi Olimpici (e tra i quali non figurava nessun italiano) – avevano stabilito di costituire una struttura internazionale che regolamentasse norme e primati dell’atletica leggera. Tra i primi atti della IAAF fu proprio la stesura di una prima lista di record mondiali che venne presentata nel 1914. -

1500 M/Miglio
www.sportolimpico.it 1500 METRI / MIGLIO – DONNE Tutte le prestazioni fino a 4’09”99 [143 + 7i] Aggiornamento: fine stagione 2020 Nota – Nessun risultato nella stagione 2020 prestazione ottenuta ai Giochi Olimpici prestazione ottenuta ai Campionati Mondiali prestazione ottenuta ai Campionati Europei Jr = nella categoria Junior (U-20) p = tempo al traguardo intermedio in una corsa sul Miglio a = cronometraggio automatico comunicato al decimo di secondo Al 31 Dic 2000 3’58”65 Gabriella Dorio (25) 25 Ago 82 4’02”65 Paola Pigni (27) 9 Set 72 4’03”82 Fabia Trabaldo (21) 7 Ago 93 4’03”88 Silvana Cruciata (28) 15 Lug 81 4’05”14 Agnese Possamai (31) 20 Ago 84 4’06”71 Margherita Gargano (27) 28 Set 79 4’08”54 Valentina Tauceri (26) 9 Giu 92 4’08”65 Roberta Brunet (31) 11 Set 96 4’09”32 Elisa Rea (40) 14 Lug 98 4’09”63 Serenella Sbrissa (29) 5 Giu 98 Al 31 Dic 2020 3’58”65 Gabriella DORIO (25) 27-6-57 2) Tirrenia, Int. 25 Ago 82 1. M.Puica (Rou) 3’57”82; ... 3. M.Geissler (Gdr) 4’17”01; 4. R.Gramola 4’18”63; … 3’59”02 Dorio (25) 3) Atene. ECh 11 Set 82 1. O.Dvirna (Urs) 3’57”80; 2. Z.Zaytseva (Urs) 3’58”82; … 4. M.Puica (Rou) 3’59”31; … 3’59”82 Dorio (23) 2) Roma, GG 5 Ago 80 1. T.Kazankina (Urs) 3’58”94; … 3. M.Decker (Usa) 4’03”15; 4. A.Bukis (Pol) 4’04”66; …. -

Todos Los Medallistas De Los Campeonatos De Europa
TODOS LOS MEDALLISTAS DE LOS CAMPEONATOS DE EUROPA HOMBRES 100 m ORO PLATA BRONCE Viento 1934 Christiaan Berger NED 10.6 Erich Borchmeyer GER 10.7 József Sir HUN 10.7 1938 Martinus Osendarp NED 10.5 Orazio Mariani ITA 10.6 Lennart Strandberg SWE 10.6 1946 Jack Archer GBR 10.6 Håkon Tranberg NOR 10.7 Carlo Monti ITA 10.8 1950 Étienne Bally FRA 10.7 Franco Leccese ITA 10.7 Vladimir Sukharev URS 10.7 0.7 1954 Heinz Fütterer FRG 10.5 René Bonino FRA 10.6 George Ellis GBR 10.7 1958 Armin Hary FRG 10.3 Manfred Germar FRG 10.4 Peter Radford GBR 10.4 1.5 1962 Claude Piquemal FRA 10.4 Jocelyn Delecour FRA 10.4 Peter Gamper FRG 10.4 -0.6 1966 Wieslaw Maniak POL 10.60 Roger Bambuck FRA 10.61 Claude Piquemal FRA 10.62 -0.6 1969 Valeriy Borzov URS 10.49 Alain Sarteur FRA 10.50 Philippe Clerc SUI 10.56 -2.7 1971 Valeriy Borzov URS 10.26 Gerhard Wucherer FRG 10.48 Vassilios Papageorgopoulos GRE 10.56 -1.3 1974 Valeriy Borzov URS 10.27 Pietro Mennea ITA 10.34 Klaus-Dieter Bieler FRG 10.35 -1.0 1978 Pietro Mennea ITA 10.27 Eugen Ray GDR 10.36 Vladimir Ignatenko URS 10.37 0.0 1982 Frank Emmelmann GDR 10. 21 Pierfrancesco Pavoni ITA 10. 25 Marian Woronin POL 10. 28 -080.8 1986 Linford Christie GBR 10.15 Steffen Bringmann GDR 10.20 Bruno Marie-Rose FRA 10.21 -0.1 1990 Linford Christie GBR 10.00w Daniel Sangouma FRA 10.04w John Regis GBR 10.07w 2.2 1994 Linford Christie GBR 10.14 Geir Moen NOR 10.20 Aleksandr Porkhomovskiy RUS 10.31 -0.5 1998 Darren Campbell GBR 10.04 Dwain Chambers GBR 10.10 Charalambos Papadias GRE 10.17 0.3 2002 Francis Obikwelu POR 10.06 -

CS La Mezza Di Treviso 12 15
Comunicato Stampa MEZZA DI TREVISO, NUMERO UNO PER MEUCCI Il campione europeo di maratona è l’atleta più atteso della seconda edizione dell’evento che domani, sulle strade del capoluogo della Marca, coinvolgerà circa 2.500 atleti. Oggi il fuoriclasse pisano ha visitato l’Expo al l’Hotel Maggior Consiglio: “Spero in un gara veloce, sarà un test fondamentale verso la maratona di New York” . Principale avversario , il keniano Benard Kiplangat Bett Treviso, 10 ottobre 2015 – Ore di vigilia per la Mezza di Treviso che domani, domenica 11 ottobre , alle 9.30, scatterà da Viale d’Alviano per andare a svilupparsi sui classici 21,097 chilometri di un percorso che, partendo del centro storico del capoluogo della Marca, andrà ad immergersi nella natura rigogliosa del Parco del Sile , per poi fare nuovamente ritorno in centro città. Tra ieri e oggi, i circa 2.500 iscritti alla Mezza di Treviso sono sfilati all’Expo dell’Hotel Maggior Consiglio , dov’è avvenuta la distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara e dove gli atleti hanno potuto visitare gli stand dei prossimi appuntamenti podistici (maratone e mezze maratone in primis) e di aziende legate al mondo dello sport e del benessere. All’Expo è passato anche l’atleta più atteso della gara di domani, il campione europeo di maratona, Daniele Meucci . “La forma c’è - ha detto il fuoriclasse pisano, che a Treviso sarà seguito in bicicletta dall’allenatore (e direttore tecnico della Nazionale) Massimo Magnani -. Se le condizioni metereologiche ci daranno una mano, sarà una gara veloce. Per me è un test fondamentale sulla strada della partecipazione alla maratona di New York, del 1° novembre: dal risultato di domani, saprò cosa posso attendermi dalla gara americana”. -

Primati E Migliori Prestazioni Italiane
PRIMATI E MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE (aggiornati al 29-4-2019) PRIMATI ITALIANI ASSOLUTI UOMINI 100m 9.99 Filippo Tortu Fiamme Gialle Madrid 22/06/2018 200m 19.72A Pietro Mennea Iveco Torino Città del Messico 12/09/1979 400m 45.12 Matteo Galvan Fiamme Gialle Rieti 25/06/2016 45.12 Matteo Galvan Fiamme Gialle Amsterdam 07/07/2016 800m 1:43.7m Marcello Fiasconaro CUS Torino Milano 27/06/1973 1:43.74 Andrea Longo Fiamme Oro Rieti 03/09/2000 1000m 2:15.76 Andrea Benvenuti Fiamme Azzurre Nuoro 12/09/1992 1500m 3:32.78 Gennaro Di Napoli Snam Gas M. Rieti 09/09/1990 1 miglio 3:51.96 Gennaro Di Napoli Snam Gas M. San Donato Milanese 30/05/1992 2000m 4:55.0m Gennaro Di Napoli Snam Gas M. Torino 26/05/1991 3000m 7:39.54 Gennaro Di Napoli Snam San Donato Formia 18/05/1996 5000m 13:05.59 Salvatore Antibo CUS Palermo Bologna 18/07/1990 10000m 27:16.50 Salvatore Antibo CUS Palermo Helsinki 29/06/1989 20000m 58:43.8m Franco Fava Fiamme Gialle Roma 09/04/1977 1 ora m 20.483 Giuseppe Gerbi CUS Torino Roma 17/04/1982 25000m 1h16:40.0m Giuseppe Gerbi CUS Torino Novi Ligure 10/04/1983 30000m 1h33:08.2m Massimo Magnani CUS Ferrara Bologna 11/04/1982 3000m st 8:08.57 Francesco Panetta P. Patria Osama Roma 05/09/1987 110m hs 13.28 Emanuele Abate Fiamme Oro Torino 08/06/2012 400m hs 47.54 Fabrizio Mori Fiamme Gialle Edmonton 10/08/2001 4x100m 38.17 R. -

I Vincitori I Campionati Europei Indoor
0685-0862_CAP08a_Manifestazioni Internazionali_1 - 2009 11/07/16 11:41 Pagina 824 ANNUARIO 2016 I campionati Europei indoor Le sedi GIOCHI EUROPEI 6. 1975 Katowice (pol) 16. 1985 Atene (gre) 26. 2000 Gand (bel) 1. 1966 Dortmund (frg) 8/9 marzo, Rondo, 160m 2/3 marzo, 25/27 febbraio, 27 marzo, Westfallenhalle, 160m 7. 1976 Monaco B. (frg) Peace and Friendship Stadium, 200m Flanders Indoor Hall, 200m 2. 1967 Praga (tch) 21/22 febbraio, Olympiahalle, 179m 17. 1986 Madrid (spa) 27. 2002 Vienna (aut) 11/12 marzo, Sportovní Hala Pkojf, 160m 8. 1977 San Sebastian (spa) 22/23 febbraio, Palacio de los Deportes, 164m 1/3 marzo, Ferry-Dusika-Halle, 200m 3. 1968 Madrid (spa) 12/13 marzo, Anoeta, 200m 18. 1987 Liévin (fra) 28. 2005 Madrid (spa) 9/10 marzo, 9. 1978 Milano (ita) 21/22 febbraio, Palais des Sports, 200m 4/6 marzo, Palacio de los Deportes, 200m 19. 1988 (ung) Palacio de los Deportes, 182m 11/12 marzo, Palazzo dello Sport, 200m Budapest 29. 2007 Birmingham (gbr) 5/6 marzo, Sportscárnok, 200m 4. 1969 Belgrado (jug) 10. 1979 Vienna (aut) 2/4 marzo, National Indoor Arena, 200m 20. 1989 (ola) 8/9 marzo, Veletrzna hala, 195m 24/25 febbraio, Den Haag 30. 2009 (ita) 17/18 febbraio, Houtrust, 200m Torino Ferry-Dusika-Halle, 200m 6/8 marzo, Oval, 200 m 21. 1990 Glasgow (gbr) CAMPIONATI EUROPEI 11. 1980 Sindelfingen (frg) 3/4 marzo, Kelvin Hall, 200m 31. 2011 Parigi-Bercy (fra) 1. 1970 (aut) 1/2 marzo, Glaspalast, 200m Vienna 22. 1992 Genova (ita) 4/6 marzo, 12. -
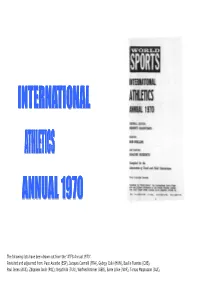
The Following Lists Have Been Drawn out from the "ATFS Annual 1970"
The following lists have been drawn out from the "ATFS Annual 1970". Revisited and adjourned from: Paco Ascorbe (ESP), Jacques Carmelli (FRA), György Csiki (HUN), Basilio Fuentes (CUB), Paul Jenes (AUS), Zbigniew Jonik (POL); Nejat Kök (TUR), Winfried Kramer (GER), Børre Lilloe (NOR), Tomas Magnusson (SUI), Ljubisa Gajic (SER), Richard Hymans (GBR), Gabriele Manfredini (ITA), Peter Matthews (GBR), Fletcher McEwen (AUS), Lionel Peters (GBR), Enzo Rivis (ITA), Milan Skočovský, (CZE), Tadeusz Wolejko (POL) Coordinator: Pino Mappa (ITA) Special thanks to Roberto Quercetani who made his library available for the purposes of this work. 1969 WORLD MEN LIST 100 YARDS (91.44 metres) John Carlos USA 05 Jun 45 193/85 9.1 0.1 (1) WCR Fresno 10 May Earl Harris USA 20 Jul 48 183/80 9.2 (1) Stillwater 22 Apr Mike Goodrich USA 17 May 48 175/70 9.2 1.4 (1)h Drake R Des Moines 25 Apr Carlos 9.2 1.0 (1) MSR Walnut 26 Apr Andy Hopkins USA 19 Oct 49 178/85 9.2 0.9 (1) Houston 30 May Robert Taylor USA 14 Sep 48 185/82 9.2 0.9 (2) Houston 30 May Taylor 9.2 (1) Houston 14 Jun Carlos 9.2 1.2 (1) NCAA Knoxville 20 Jun Lennox Miller JAM 08 Oct 46 183/79 9.2 1.2 (2) NCAA Knoxville 20 Jun Doug Hawken USA 31 Jan 49 183/77 9.2 0.7 (1) Sacramento 21 Jun Eddie Hart USA 24 Apr 49 178/70 9.2 0.7 (2) Sacramento 21 Jun Hopkins 9.2 0.7 (3) Sacramento 21 Jun Mike Fray JAM 23 Sep 47 189/88 A9.3 (1) El Paso 05 Apr Mel Gray USA 28 Sep 48 175/79 9.3 0.5 (1)r1 Kans R Lawrence 19 Apr Charlie Greene USA 21 Mar 45 173/69 9.3 nv (1)r2 Kans R Lawrence 19 Apr Gray 9.3 nv (2)r2 Kans R -

Primati E Migliori Prestazioni Italiane (Aggiornati Al 13-7-2018)
Primati e migliori prestazioni italiane (aggiornati al 13-7-2018) Primati italiani assoluti UOMINI 100m 9.99 Filippo Tortu (Fiamme Gialle) Madrid 22-6-18 200m 19.72A Pietro Mennea (Iveco Torino) Città del Messico 12-9-79 400m 45.12 Matteo Galvan (Fiamme Gialle) Rieti 25-6-16 45.12 Matteo Galvan (Fiamme Gialle) Amsterdam 7-7-16 800m 1:43.7m Marcello Fiasconaro (CUS Torino) Milano 27-6-73 1:43.74 Andrea Longo (Fiamme Oro) Rieti 3-9-00 1000m 2:15.76 Andrea Benvenuti (Fiamme Azzurre) Nuoro 12-9-92 1500m 3:32.78 Gennaro Di Napoli (Snam Gas M.) Rieti 9-9-90 1 miglio 3:51.96 Gennaro Di Napoli (Snam Gas M.) San Donato Milan. 30-5-92 2000m 4:55.0m Gennaro Di Napoli (Snam Gas M.) Torino 26-5-91 3000m 7:39.54 Gennaro Di Napoli (Snam San Donato) Formia 18-5-96 5000m 13:05.59 Salvatore Antibo (CUS Palermo) Bologna 18-7-90 10000m 27:16.50 Salvatore Antibo (CUS Palermo) Helsinki 29-6-89 20000m 58:43.8m Franco Fava (Fiamme Gialle) Roma 9-4-77 1 ora m 20.483 Giuseppe Gerbi (CUS Torino) Roma 17-4-82 25000m 1h16:40.0m Giuseppe Gerbi (CUS Torino) Novi Ligure 10-4-83 30000m 1h33:08.2m Massimo Magnani (CUS Ferrara) Bologna 11-4-82 3000m st 8:08.57 Francesco Panetta (P. Patria Osama) Roma 5-9-87 110m hs 13.28 Emanuele Abate (Fiamme Oro) Torino 8-6-12 400m hs 47.54 Fabrizio Mori (Fiamme Gialle) Edmonton 10-8-01 4x100m 38.17 Nazionale (R. -

N. 10 Di Novembre 2010 Di
Atletica UISP www.uisp.it on line Anno 1° - n. 10 - novembre 2010 Atletica UISP on line - Atletica UISP on line - Atleticaon line UISP Supplemento al n. 10 di novembre 2010 di Reg. Trib. n. 5321 del 6.2.2004 Direttore Responsabile: Ugo Bercigli Redazione: Fabio Fiaschi, Belinda Sorice, Donatella Vassallo, Luciano Facchini Grafica ed impaginazione: Andrea Grassi Sede via F. Bocchi 32 - 50126 Firenze - [email protected] Per contatti [email protected] Foto in copertina di RISK4SPORT dalla gara “Pionieri del Gran Sasso” All’ interno Editoriale: Non c’è più posto Storico riconoscimento 05 di Donatella Vassallo 19 per la Maratona di Roma Dalla Rassegna stampa UISP certificata IAAF Gold Label 06 Trapani: 14° Trofeo Sale e Saline Ottore di Capraia: I risultati del Campionato italiano su strada 32 è qui la festa! 10 di Denise Quintieri Migidio Bourifa: terzo titolo italiano di maratona di Cesare Monetti 22 Alimentazione, Il Kenya sbanca il mondiale di mezza maratona 38 meglio corretta 27 di Mattia Ganucci di Tiziano Marzotti Il ragazzo che catturò il vento a cura di Donatella Vassallo 36 Scarica i regolamenti “Oltre il muro”, quando lo sport supera le barriere 63 dell’attività UISP 42 a cura di Donatella Vassallo nazionale 2011 Sulle tracce di Filippide (490 a.C. - 2010) 48 di Filippo Cenci - Prima parte Da potenza in atto: indagine sull’involuzione dell’atletica italiana 58 di Adriano Masci ÓÇ>Ê <" Atletica UISP on line - Atletica UISP on line - PROVINCIA DI FIRENZE Editoriale ÓnÊ ÛiLÀiÊÓä£ä Non c’è più posto l punto non è il male, ma la nostra risposta ad esso. -

LE STATISTICHE DELLA MARATONA 1. Migliori Prestazioni Mondiali Maschili Sulla Maratona Tabella 1 2. Migliori Prestazioni Mondial
LE STATISTICHE DELLA MARATONA 1. Migliori prestazioni mondiali maschili sulla maratona TEMPO ATLETA NAZIONALITÀ LUOGO DATA 1) 2h03’38” Patrick Makau Musyoki KEN Berlino 25.09.2011 2) 2h03’42” Wilson Kipsang Kiprotich KEN Francoforte 30.10.2011 3) 2h03’59” Haile Gebrselassie ETH Berlino 28.09.2008 4) 2h04’15” Geoffrey Mutai KEN Berlino 30.09.2012 5) 2h04’16” Dennis Kimetto KEN Berlino 30.09.2012 6) 2h04’23” Ayele Abshero ETH Dubai 27.01.2012 7) 2h04’27” Duncan Kibet KEN Rotterdam 05.04.2009 7) 2h04’27” James Kwambai KEN Rotterdam 05.04.2009 8) 2h04’40” Emmanuel Mutai KEN Londra 17.04.2011 9) 2h04’44” Wilson Kipsang KEN Londra 22.04.2012 10) 2h04’48” Yemane Adhane ETH Rotterdam 15.04.2012 Tabella 1 2. Migliori prestazioni mondiali femminili sulla maratona TEMPO ATLETA NAZIONALITÀ LUOGO DATA 1) 2h15’25” Paula Radcliffe GBR Londra 13.04.2003 2) 2h18’20” Liliya Shobukhova RUS Chicago 09.10.2011 3) 2h18’37” Mary Keitany KEN Londra 22.04.2012 4) 2h18’47” Catherine Ndereba KEN Chicago 07.10.2001 1) 2h18’58” Tiki Gelana ETH Rotterdam 15.04.2012 6) 2h19’12” Mizuki Noguchi JAP Berlino 15.09.2005 7) 2h19’19” Irina Mikitenko GER Berlino 28.09.2008 8) 2h19’36’’ Deena Kastor USA Londra 23.04.2006 9) 2h19’39’’ Sun Yingjie CHN Pechino 19.10.2003 10) 2h19’50” Edna Kiplagat KEN Londra 22.04.2012 Tabella 2 3. Evoluzione della migliore prestazione mondiale maschile sulla maratona TEMPO ATLETA NAZIONALITÀ LUOGO DATA 2h55’18”4 Johnny Hayes USA Londra 24.07.1908 2h52’45”4 Robert Fowler USA Yonkers 01.01.1909 2h46’52”6 James Clark USA New York 12.02.1909 2h46’04”6