COME CAMBIARE LA TUA MENTE Prologo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
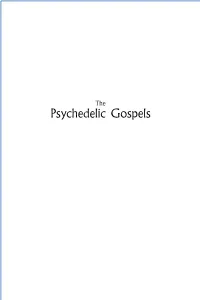
Psychedelic Gospels
The Psychedelic Gospels The Psychedelic Gospels The Secret History of Hallucinogens in Christianity Jerry B. Brown, Ph.D., and Julie M. Brown, M.A. Park Street Press Rochester, Vermont • Toronto, Canada Park Street Press One Park Street Rochester, Vermont 05767 www.ParkStPress.com Park Street Press is a division of Inner Traditions International Copyright © 2016 by Jerry B. Brown and Julie M. Brown All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Note to the Reader: The information provided in this book is for educational, historical, and cultural interest only and should not be construed in any way as advocacy for the use of hallucinogens. Neither the authors nor the publishers assume any responsibility for physical, psychological, legal, or any other consequences arising from these substances. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data [cip to come] Printed and bound in XXXXX 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Text design and layout by Priscilla Baker This book was typeset in Garamond Premier Pro with Albertus and Myriad Pro used as display typefaces All Bible quotations are from the King James Bible Online. A portion of proceeds from the sale of this book will support the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Founded in 1986, MAPS is a 501(c)(3) nonprofit research and educational organization that develops medical, legal, and cultural contexts for people to benefit from the careful uses of psychedelics and marijuana. -

Do Drugs Have Religious Import?
A-. ,'Smith,:L: H., Jesse, R., Grob, C., Agar, A., Walsh, R. The Oral History of Psychedelics ~esearch $project, \I: Do drugs . -- - - - x - - i:~svcholoev.44 (2), 120- 140,2003. Huston Smith ef al. 121 ... ~ .~ .. ~ - . -- .- .. .. ,- . - . .. ROBERT JESSE serves as the p~sidentof the Coun- DO DRUGS HAVE RELIGIOUS IMPORT? cil on Spiritual Practices, a collaboration among spir- A 40-YEAR RETROSPECTIVE itualguides,experta in the behavioral and biomedical sdences,andscholars ofreligion. CSPsponsors scien- tific research and encourages dialogue about J. approaches to primary religious experience and con- HUSMN SMITH is the Thomas Watson Professor ditions that helpchannel such experiences into favor- of Religion and Distinguished Adjunct Professor of able long-term outcomes. He led the drafting of CSPs Code of Ethics for Philosophy, Emeritus, Syracuse University. For 15 Spiritual Guides, intended to foster wholesomeness in practices intended years, he was a professor of philosophy at M.I.T., and or likely to be transfornative. An engineer by training, he formerly for a decade before that he taught at Washington Uni- worked in software development. versity in St. Louis. hlost recently, he has aerved as a visiting professor of religious studies, University of Califomia, Berkeley. Holder of 12 honorary degrees, GARY BRAVO graduated from Harvard University his 14 books include The World's Religio~,which has with a degree in biology and did his medical and psy- sold more than 2 ?4 million copies, and Why Religion chiatric training at the University of California, bfatfers, which won the Wilbur Award for the best book on religion pub Irvine, College of hledicine. -

A Social and Cultural History of the Federal Prohibition of Psilocybin
A SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF THE FEDERAL PROHIBITION OF PSILOCYBIN A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy by COLIN WARK Dr. John F. Galliher, Dissertation Supervisor AUGUST 2007 The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled A SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF THE FEDERAL PROHIBITION OF PSILOCYBIN presented by Colin Wark, a candidate for the degree of doctor of philosophy and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. Professor John F. Galliher Professor Wayne H. Brekhus Professor Jaber F. Gubrium Professor Victoria Johnson Professor Theodore Koditschek ACKNOWLEDGEMENTS The author would like to thank a group of people that includes J. Kenneth Benson, Wayne Brekhus, Deborah Cohen, John F. Galliher, Jay Gubrium, Victoria Johnson, Theodore Koditschek, Clarence Lo, Kyle Miller, Ibitola Pearce, Diane Rodgers, Paul Sturgis and Dieter Ullrich. ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................ ii NOTE ON TERMINOLOGY ............................................................................................ iv Chapter 1. INTRODUCTION…………………………………………………………………1 2. BIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE LIVES OF TIMOTHY LEARY AND RICHARDALPERT…………………………………………………….……….20 3. MASS MEDIA COVERAGE OF PSILOCYBIN AS WELL AS THE LIVES OF RICHARD ALPERT AND TIMOTHY -

Spirituality in the Laboratory: Negotiating the Politics of Knowledge in the Psychedelic Sciences
ABSTRACT Title of Document: SPIRITUALITY IN THE LABORATORY: NEGOTIATING THE POLITICS OF KNOWLEDGE IN THE PSYCHEDELIC SCIENCES. Michelle Dawn Corbin, Ph.D., 2010 Directed By: Associate Professor, Meyer Kestnbaum, Department of Sociology In this study I argue that psychedelic substances served as a doorway through which spirituality entered the scientific laboratory to an unprecedented degree given their traditionally demarcated relationship by making spirituality more amenable to scientific paradigms and accessible to scientific methodologies. I conduct a feminist discourse analysis of the politics of knowledge enacted in this unique intersection of spirituality and science in the psychedelic sciences. I draw on feminist theories of science and knowledge which conceptualize science as a dominant knowledge constituted through and productive of the intersecting and historically hierarchical systems of power of race, class, gender and nation. Using discourse analysis techniques, I analyze a documentary archive I created through a theoretically driven sampling of the psychedelic sciences of spirituality from the 1930’s to the present. In Chapter 2, I analyze how spirituality was brought forward and negotiated in these sciences. I argue that psychedelic scientists utilized a range of what I call tactics of legitimation to justify the scientific study of these peculiar substances and the spirituality with which they are associated vis-à-vis dominant scientific knowledges and I analyze the attendant epistemological costs of this assimilation. In Chapter 3, I analyze the efforts to integrate psychedelic substances and the spiritual experiences they induce into western therapeutic assumptions and practices. I argue that their efforts to scientifically determine the mysticality of mystical experiences and their pursuits of scientific liturgical authority over the administration of psychedelic sacraments resulted in the emergence of a would-be psychiatric clerical authority. -
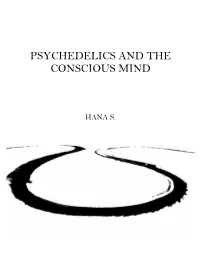
Psychedelics and the Conscious Mind
PSYCHEDELICS AND THE CONSCIOUS MIND HANA S. I researched psychedelics—not only the impact they have on an individual, but how psychedelic drugs influenced contemporary art from the 1960s to the present day. In the 1960s, there was a need to look outside of the dominant society and psychedelics allowed for a new thought process to expand consciousness. Inspired by my research, I built a chair to invite the participant to “tune in and drop out” (the counterculture-era phrase that Timothy Leary, an American psychologist, popularized). Most chairs sit upright, but I designed a chair that one must lean back into. When you lean into something, you are less focused on people and distractions surrounding you. Because you are more relaxed, you are more focused on yourself and the present moment. My chair forces the participant to expand their awareness of the surrounding environment. By sitting in my chair, the participant will be able to drop into a relaxed, altered consciousness. This state of mind might allow one to question authority and the norms that hold us from expressing alternative viewpoints. Hana S Can psychedelics expand our consciousness? Are there any medical uses to LSD and psilocybin? What are the effects of psychedelics on the individual and what are the effects of psychedelics on culture? My research explores drug culture from the 1960s to present day. Specifically, I chose to focus on the creation of LSD and its legal status to becoming this dangerous “forbidden fruit”. Recently, scientists have been exploring psychedelics more deeply for medicinal and therapeutic purposes. -

Psychedelics and Religious Insight: a Precedent in American Psycho-Spirituality from 1 William James to Timothy Leary
Psychedelics and Religious Insight: A Precedent in American Psycho-Spirituality from 1 William James to Timothy Leary Psychedelics and Religious Insight: A Precedent in American Psycho-Spirituality from 2 William James to Timothy Leary Psychedelics and Religious Insight: A Precedent in American Psycho-Spirituality from 3 William James to Timothy Leary ABSTRACT Psychedelics and Religious Insight: A Precedent in American Psycho- Spirituality from William James to Timothy Leary by Connor James Storck The primary purpose of this thesis is to stress that there is a relationship between the texts one reads and psychedelic experiences. Reading texts has an effect on set and setting with respect to psychedelic experiences. Further, texts read—by figures like Timothy Leary—in the afterglow of a psychedelic experience can influence later integration of said experiences into one’s worldview. This thesis tracks this through the influence of mind-altering substances in the works of both William James (1842-1910) and Timothy Leary (1920-1996) in order to display James’ influence on Leary. James’ impact of Leary intellectually is critical because recent scholarship and changes in cultural and societal perspectives have led to a Psychedelic Renaissance in many disciplines from the clinical-therapeutic to the religious-spiritual. The paper covers select and relevant historical information relating to periods of the Anesthetic Revolution and the Long Sixties. I show how James came to experiment with various mind-altering substances and the results of those experiments. For this reason, the thesis also interacts with Benjamin Paul Blood, a figure whose work guided James’ thought towards the use of mind-altering substances. -

View Numinus' Briefing Note to Health Canada Here
November 20, 2020 Patty Hajdu Honourable Minister of Health Health Canada Email: [email protected] Dear Minister Hajdu, On behalf of the Numinus Wellness Clinical Advisory Board*, please find enclosed a briefing note and appendices making recommendations for the revision of Health Canada’s Special Access Programme. We would appreciate the opportunity to have a follow up call with relevant Health Canada staff to review these recommendations if this would be of assistance. Sincerely, ____________________________ ____________________________ Evan Wood, MD, PhD, FRCPC Devon Christie, MD, CCFP, RTC Chief Medical Officer Medical Director *Gabor Maté, M.D.,C.M, Author & Retired Physician, Pam Kryskow, M.D., CCFP, Physician & Clinical Instructor, UBC, Zach Walsh, PhD, Professor, Psychology, UBC, Kate Browning RN, Administrator & Instructor, Holistic Health, Langara College, Dr. Jason Marr, BScH, COC, ND, Founder & Director of Evoke Integrative Medicine Ltd. cc: Pierre Sabourin, Assistant Deputy Minister Health Products and Food Branch, Health Canada Email: [email protected] Eric Costen, Associate Assistant Deputy Minister Controlled Substances and Cannabis Branch, Health Canada Email: [email protected] numinus.ca [email protected] TITLE: Revising Health Canada’s Special Access Program to Allow Pre-Approval Access to MDMA and Psilocybin PREPARED FOR: Patty Hajdu, Honourable Minister of Health DATE: November 20, 2020 ISSUE: There is a large and growing burden of mental illness affecting Canadians. In some cases, this is severe and can be life threatening for a range of reasons (e.g. opioid overdose, suicide). Existing treatments for severe mental illness are often ineffective and associated with unwanted side effects meaning new treatment modalities are urgently needed. -

The Psychedelic Renaissance
The Psychedelic Renaissance Reassessing the Role of Psychedelic Drugs in 21st Century Psychiatry and Society Dr. Ben Sessa MBBS BSc MRCPsych First published by Muswell Hill Press, London, 2012 © 2012 Ben Sessa Ben Sessa has asserted his right under the Copyright, Design and Patents Act 1988 to be identified as the author of this work. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior permission of Muswell Hill Press www.muswellhillpress.co.uk British Library Cataloguing in Publication Data Sessa, Ben. The psychedelic renaissance : reassessing the role of psychedelic drugs in 21st century psychiatry and society. 1. Hallucinogenic drugs-Therapeutic use. 2. Hallucinogenic drugs-History. I. Title 615.7'883-d c23 ISBN-13: 9781 908995001 Printed in Great Britain by Marston Book Services This book is dedicated to my children Huxley, Kitty and Jimi. May your beloved pineal glands continue to secrete endogenous mystical compounds forever more, giving rise to a lifetime of spontaneous spiritual experiences. Contents Fo rewords by Rick Doblin and David Nutt ... ........................................ .. ...... xiii Introduction.......................................................................................................... 1 Apocalypse, Now and Then ........................................ ..... ...................... .......... I What Can the Psychedelics Offer Us? .............. ..... ........ .. ....... .. ......... ....... ... 2 Defining Psychedelic Drugs .... ...................................................... -

Contradictory Impulses in the Psychedelic Sixties
Contradictory Impulses in the Psychedelic Sixties Joshua Canzona Georgetown University Responding to academic efforts to create a static typology to describe the psychedelic counterculture of the American 1960s, this paper emphasizes the contradictory impulses of the time. Through an investigation of varied 1960s experimentation with chemically induced mysticism, social activism, and innovative technology, we can gain a sense of the tensions within sixties counterculture and a better understanding of the passions that fueled it. It will be argued that one underlying and unifying theme is a consequentialist ethic willing to transgress every boundary in the pursuit of good vibes. The results, of course, were mixed. Introduction Seeking to understand any aspect of the 1960s counterculture presents a historiographical difficulty stemming from our lack of critical distance. In one sense the counterculture movement is a measurable event with clear enough chronological parameters to allow The New Dictionary of Cultural Literacy to define the term as ‘a protest movement by American youth that arose in the late 1960s and faded during the late 1970s’.1 The Historical Dictionary of the 1960s asserts that the broader American awareness of the counterculture participants themselves, the ‘hippies’, can be traced to a 1965 news article written on ‘a new group of young people who gathered in the Haight-Ashbury section of San Francisco and championed the virtues of peace, free love, recreational drug use, rock and roll, and absolute individual freedom to do your own thing’.2 While these chronological and initial geographic boundaries can be defined, it is also true that the memory and spirit of the sixties counterculture endures as an important influence in the broader American culture.3 The sixties counterculture is still alive, it is living history, and as a scholarly concern this is what makes it simultaneously challenging and vitally important. -
Entheogens, the Conscious Brain and Existential Reality Chris King Complementary Video: Entheogens, Culture and the Conscious Brain
Entheogens, the Conscious Brain and Existential Reality Chris King Complementary video: Entheogens, Culture and the Conscious Brain http://youtu.be/pY2MDqdv-No Abstract: The purpose of this article is to provide a ‘state of the art’ research overview of what is currently known about how entheogens, including the classic psychedelics, affect the brain and transform conscious experience through their altered receptor dynamics, and to explore their implications for understanding the conscious brain and its relationship to existential reality, and their potential utility in our cultural maturation and understanding of the place of sentient life in the universe. Contents 1. Cultural and Historical Introduction 2. The Enigma of Subjective Consciousness 3. Fathoming the Mind-Brain Relationship and Experiential Modalities 4. Doors of Perception: Classic Psychedelics and Serotonin Receptor Agonists 5. Doors of Dissociation: Ketamine and the NMDA Receptor Antagonists 6. Salvinorin-A and κ-Opioid Dissociatives 7. Cannabinoids 8. Entactogens 9. Doors of Delirium: Scopolamine and Muscarinic Acetyl-choline Antagonists 10. Safety Considerations of Psychedelic Use and Global Drug Policy 11. An Across-the-Spectrum Case Study 12. Why the Neurotransmitters: Cosmology and Evolution 13. Conclusion 14. References 1: Cultural and Historical Introduction Human societies have been actively using psychoactive substances since the earliest cultures emerged. In “The Alchemy of Culture” Richard Rudgley notes that European cave depictions, from the paleolithic on, abound with both herbivorous animals of the hunt and geometrical entopic patterns similar to the phosphenes seen under sensory withdrawal and under the effects of psychotropic herbs. By the time we find highly-decorated pottery ‘vase supports’ in Middle Neolithic France, we have evidence consistent with their ritual use as opium braziers. -
Desacralization, Spiritual Abuse and Magic Mushrooms
[FIR 14.2 (2019) 118–139] Fieldwork in Religion (print) ISSN 1743–0615 https://doi.org/10.1558/firn.40554 Fieldwork in Religion (online) ISSN 1743–0623 Anna Lutkajtis LOST SAINTS: DESACRALIZATION, SPIRITUAL ABUSE AND MAGIC MUSHROOMS Anna Lutkajtis is a postgraduate researcher at N413, Woolley A20 the University of Sydney, Australia. Her research University of Sydney focuses on mysticism, the dark night of the soul, NSW 2006 and the healing potential of altered states of Australia consciousness. [email protected] ABSTRACT Mushrooms containing psilocybin have been used in Indigenous healing ceremonies in Meso- america since at least the sixteenth century. However, the sacramental use of mushrooms was only discovered by Westerners in the early to mid-twentieth century. Most notably, the meet- ing between amateur mycologist Robert Gordon Wasson and Mazatec curandera María Sabina in 1955 resulted in the widespread popularization of ingesting “magic mushrooms” in the West. To Sabina and the Mazatec people, psilocybin mushrooms were sacred and only to be used for healing. However, Western “hippies” viewed mushrooms as psychedelic drugs which they con- sumed with little regard for cultural sensitivities, rendering the mushrooms desacralized. This arti- cle argues that the desacralization of psilocybin mushrooms constitutes a form of spiritual abuse that has had far-reaching and long-lasting consequences at individual, local and global levels. Fur- ther, acknowledging and understanding the desacralization of psilocybin mushrooms as spiritual abuse has important implications for restorative justice and the understanding of psilocybin as a sacred medicine. Keywords: psilocybin; magic mushrooms; R. Gordon Wasson; María Sabina; desacralization; spiritual abuse. -

Psychedelics and Psychedelic-Assisted Psychotherapy: Clinical Implications
REVIEWS AND OVERVIEWS Psychedelics and Psychedelic-Assisted Psychotherapy: Clinical Implications Collin M. Reiff, M.D., Elon E. Richman, M.D., Charles B. Nemeroff, M.D., Ph.D., Linda L. Carpenter, M.D., Alik S. Widge, M.D., Ph.D., Carolyn I. Rodriguez, M.D., Ph.D., Ned H. Kalin, M.D., William M. McDonald, M.D., and the Work Group on Biomarkers and Novel Treatments, a Division of the American Psychiatric Association Council of Research Objective: The authors provide an evidenced-based sum- Results: The most significant database exists for MDMA and mary of the literature on the clinical application of psyche- psilocybin, which have been designated by the U.S. Food and delic drugs in psychiatric disorders. Drug Administration (FDA) as “breakthrough therapies” for posttraumatic stress disorder (PTSD) and treatment-resistant Methods: Searches of PubMed and PsycINFO via Ovid depression, respectively. The research on LSD and ayahuasca were conducted for articles in English, in peer-reviewed is observational, but available evidence suggests that these journals, reporting on “psilocybin,”“lysergic acid diethylamide,” agents may have therapeutic effects in specific psychiatric “LSD,”“ayahuasca,”“3,4-methylenedioxymethamphetamine,” disorders. and “MDMA,” in human subjects, published between 2007 and July 1, 2019. A total of 1,603 articles were identified Conclusions: Randomized clinical trials support the efficacy and screened. Articles that did not contain the terms “clini- of MDMA in the treatment of PTSD and psilocybin in the cal trial,”“therapy,” or “imaging” in the title or abstract were treatment of depression and cancer-related anxiety. The filtered out. The 161 remaining articles were reviewed by research to support the use of LSD and ayahuasca in the two or more authors.