ROCCHETTA Già
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Miste Mc.Pdf
ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA REGIONE MARCHE Assam - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Elenco Regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - aggiornato al 31 dicembre 2008 - come previsto dal D. Lgs. 220/95. 3 . 3 - Produttori Provincia: MC Aziende miste Anno 2008 N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE Pr A Codice Fiscale Partita IVA 543 AGAMENNONI ALBERTO C.DA GESSARE 62020 BELFORTE DEL CHIENTI MC P 01340050432 544 AGRITURISMO LE QUATTRO STAGIONI SOCIETA' CONTRADA S. BARTOLOMEO, 7 62029 TOLENTINO MC P 01512040435 AGRICOLA S.S. 545 AGROFORESTALE LE COLLINE S.S. VIA COLLINA, 80 62020 SERRAPETRONA MC P 01463690436 546 ALIDORI GRAZIANO MARIO VIA SANTA MARIA, 70 62026 SAN GINESIO MC P 00274290436 547 AMICO LUCIA VIA B.GO TRENTO, 23 62021 APIRO MC P 01339020438 548 ANGELI MIRKO VIA CASE SPARSE CAPANNE, 2 62036 PIEVE TORINA MC P NGLMRK78A11B474J 01286450430 549 ANSOVINI LUCA C.DA MAREGNANO, 10 62020 CESSAPALOMBO MC P 01509140438 550 ANTENUCCI MAURO VIA VALLE MONTALTO, 54 62020 CESSAPALOMBO MC P 01456150430 551 APPIGNANESI JURI VIA GAGLIANVECCHIO, 39 62027 SAN SEVERINO MC P PPGJRU82S30I156F 01438410431 MARCHE 552 APPIGNANESI LEONIDA LOC. GAGLIANVECCHIO, 51/A 62027 SAN SEVERINO MC P PPGLND80E23I156C 01354470435 MARCHE 553 ARGIOLAS ANGELA CONTRADA MOELANO, 1 62020 SANT'ANGELO IN MC P 01837130440 PONTANO 554 ARGIOLAS PAOLINO C.DA ZAZZA, 32 62020 GUALDO MC P RGLPLN61T22L992D 01100270436 555 AZ. AGR. BENADDUCI LAURA EREDI C.DA SALCITO 62029 TOLENTINO MC P 01369300437 556 AZ. AGR. BOCCADIGABBIA DI ALESSANDRINI ELVIDIO C.DA CASTELLETTA, 56 62012 CIVITANOVA MARCHE MC P 01015450438 557 AZ. AGR. FORESTALE LATINI DI FIORELLA PICCIONI C.DA CERVARE, 13 62100 MACERATA MC P 01108920438 LATINI & C. -

COMUNE DI POLLENZA Provincia Di Macerata COPIA ______
COMUNE DI POLLENZA Provincia di Macerata COPIA ______________________________________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 25-06-12 Numero 15 Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 21:00, in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d’invito n. in data , si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. Nelle persone dei Signori: Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. MONTI LUIGI P PIGNANI FABRIZIO P RANZUGLIA MARCO P CERQUETELLA GIOVANNI P PRIMUCCI ANDREA P RICOTTA ALESSANDRA A RIBICHINI EDILIO P RICCIARDI SABRINA P ROMOLI MAURO P MANDOLESI LUCIANA A LEOPERDI VALENTINA P ROSINI NICOLA P MESCHINI MARCO P MACCARI ADRIANA P CERESANI FRANCESCO P TOMASSINI PIA FRANCESCA P MENICHELLI ANTONELLA P Assegnati 17 Presenti n. 15 In carica 17 Assenti n. 2 Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.ri : -Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario APPIGNANESI GIULIANA. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. - Nominati scrutatori i Signori: MESCHINI MARCO CERQUETELLA GIOVANNI ROSINI NICOLA IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: a. -

Marche Invita. Lo Spettacolo Dal Vivo Per La Rinascita Dal Sisma
Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma Marche inVita è il progetto coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo per la promozione di attività di spettacolo dal vivo da parte degli enti operanti nel cratere del sisma che ha colpito le Marche nel 2016. Direttamente interessate sono le realtà locali presenti nei tanti borghi del territorio, attraverso la realizzazione di attività ordinarie e di grandi eventi che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo. AbitiAMO le Marche A cura di: AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali In collaborazione con: Comuni di Amandola, Ascoli Piceno, Caldarola, Camerino, Castignano, Cerreto D’Esi, Cossignano, Esanatoglia, Fabriano, Falerone, Gagliole, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Rinaldo, Montegiorgio, Pollenza, San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Treia, Urbisaglia Periodo svolgimento attività: dicembre 2017 – maggio 2018 L’AMAT intende accompagnare e sostenere il percorso di ricostruzione di un futuro positivo per le comunità colpite nella consapevolezza del ruolo primario che la cultura può svolgere per favorire la coesione, rinnovare l’identità, migliorare la qualità della vita, promuovere la crescita personale. Si propone di costruire un percorso con le amministrazioni locali che non si limiti ad una mera proposta di spettacoli, ma faccia incontrare le comunità con gli artisti attraverso le residenze creative, occasioni privilegiate in quanto prevedono la presenza nei luoghi coinvolti di artisti del territorio regionale e la collaborazione con uno o più maestri della scena nazionale e internazionale che permetta di mantenere un dialogo fecondo con le realtà più significative al di là dei confini regionali. Inaugurazione del Teatro Filarmonici A cura di: Comune di Ascoli Piceno In collaborazione con: AMAT Periodo svolgimento attività: marzo 2018 È prevista l’organizzazione di un evento da realizzare in occasione della riapertura del Teatro Filarmonici, teatro storico cittadino che torna in attività dopo anni di chiusura per lavori di ristrutturazione. -

Comune Di Pollenza
COMUNE DI POLLENZA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO: 2020 – 2021 – 2022 INDICE GENERALE Premessa Pag. 3 1 Sezione strategica Pag. 4 2 Analisi di contesto Pag. 6 2.1.1 Popolazione Pag. 8 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 10 2.1.3 Economia insediata Pag. 12 2.1.4 Terr itorio Pag. 14 2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 15 2.1.6 Struttura operativa Pag. 19 2.2 Organismi gestionali Pag. 20 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 21 2.2.2 Societ à Partecipate Pag. 22 3 Accordi di pr ogramma Pag. 24 4 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 25 5 Funzioni su delega Pag. 26 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 27 6.2 Elenco opere pubbliche Pag. 30 6.2.1 Programma Bienna le degli acquisti di forniture e servizi Pag. 31 6.3 Fonti di finanziamento Pag. 32 6.4 Analisi delle risorse Pag. 34 6.4.8 Proventi dell ’ente Pag. 54 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 55 6.6 Quad ro ri assuntivo Pag. 59 7 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 60 8 Linee programmatiche di mandato Pag. 61 Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 63 9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 74 Quadr o generale degli impieghi per missione Pag. 75 Quadro generale degli impieghi per missione - cassa Pag. 78 Dettagli per missione Pag. 79 10 Sezione operativa Pag. 126 1 Dettagli per missione/programma Pag. 129 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. -

Anno Scolastico 2018-19 MARCHE AMBITO 0007
Anno Scolastico 2018-19 MARCHE AMBITO 0007 - AMBITO TERRITORIALE MC07 di MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto MCIC82700V "ENRICO FERMI" MCAA82700P "ENRICO FERMI" NORMALE VIA PACE 2 MACERATA MCAA82702R ROSA AGAZZI VIA VENTURA, 8 MACERATA MACERATA MACERATA MCAA82703T PADRE MATTEO RICCI VIA G. VERDI, 10 MACERATA MCAA82704V GIOVANNI CRISTIANO VIA ADIGE, 5 MACERATA ANDERSEN MCAA82705X VIA PACE VIA PACE,4 MACERATA MCAA827061 DON BOSCO VIA DE AMICIS, 4 MACERATA MCAA827072 HELVIA RECINA VIA DELL'ACQUEDOTTO, MACERATA 18 MCIC82800P "ENRICO MESTICA" MCAA82800E "ENRICO MESTICA" NORMALE VIALE DON BOSCO, 55 MACERATA MCAA82801G VIA DEI SIBILLINI VIALE DON BOSCO, 55 MACERATA MACERATA MACERATA MCAA82803N VIA CARDARELLI VIA CARDARELLI, 1 MACERATA MCAA82804P G.RODARI VIA PANFILO,42 MACERATA MCAA82805Q GOFFREDO MAMELI VIA MAMELI 43 MACERATA MCIC833006 "DANTE ALIGHIERI" MCAA833002 "DANTE ALIGHIERI" NORMALE VIA GIULIOZZI 10 MACERATA MCAA833013 INFANZIA VIA F.LLI CERVI VIA F.LLI CERVI 40 MACERATA MACERATA MACERATA MCAA833024 VIA SPALATO VIA SPALATO MACERATA MCIC817008 "VINCENZO MONTI" MCAA817004 "VINCENZO MONTI" NORMALE VIA N.BOLDORINI, -

Ambito Territoriale Sociale N.15
Ambito Territoriale Sociale n. 15 Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA COMITATO DEI SINDACI Deliberazione n° 32 del 17.12.2020 Oggetto: POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse II Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4.B - Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2 – Tipologia azione 9.1.C – Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali – Approvazione variazione composizione Gruppo di Progetto. L’anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre, tramite piattaforma on line Zoom, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: Cognome e nome Comune Qualifica Calamita Mariano Appignano Sindaco Sagretti Monica Corridonia Assessore delegato Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato Romoli Mauro Pollenza Sindaco Capponi Franco Treia Sindaco Presenti n° 6 Assenti n. 3: Comune di Macerata, Comune di Petriolo e Comune di Urbisaglia. Partecipa inoltre, senza diritto di voto: Luana Moretti, Assessore Servizi Sociali del Comune di Treia. Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Carla Scarponi. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di Vice Presidente, Mauro Romoli, Sindaco del Comune di Pollenza. I L C O M I T A T O D E I S I N D A C I COMUNE DI MACERATA Protocollo Interno N.7319/2021 del26-01-2021 Doc. Principale - CopiaDocumento Viste: - la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - la L.R. -

Organi Associativi
Organi associativi Presidente Provinciale : Cav. Renzo Leonori – San Severino M. Comitato di Presidenza : Leonori Renzo – Presidente; Mengoni Enzo – Vice Presidente Vicario; Mazzarella Giuseppe – Vice Presidente; Marchetti Mauro e Pepa Emanuele – Componenti. Giunta Esecutiva : Leonori Renzo – S. Severino M; Caterbetti Ivan – Acconciatori; Celaschi Guido - Anap (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati); Chiacchiera Claudio – Carrozzieri; Corradini Corrado - Macerata; Doria Eraldo – Civitanova Marche; Emiliozzi Giuseppe – Civitanova Marche; Fidani Katia - Gruppo Donne Impresa; Formentelli Michel – Camerino; Lampa Massimo – Gruppo Giovani Imprenditori; Latini Agnese - Macerata; Lucentini Alberto – Macerata; Marchetti Mauro – S. Severino M. Vigoni Lorena – Cingoli; Mazzarella Giuseppe – Calzaturieri; Mazzocchetti Fabio – Tolentino; Mengoni Enzo - Recanati; Pepa Emanuele – Autotrasportatori; Pieroni Andrea – Autoriparatori; Quacquarini Silvano - Presidente della Coop. Pierucci; Salvatori Mariano – Macerata; Severini Pacifico – Macerata; Stacchiotti Maurizio – Recanati. Consiglio Provinciale Acomordali Luca Tolentino Antinori Alessandro Civitanova Marche Avarucci Stefano Cingoli Balconcini Marcello Morrovalle Berdini Romina Corridonia Branchesi Massimo Appignano Brandi Massimiliano Esanatoglia Bravi Maurizio Appignano Bruschi Alessandro Sarnano Buglioli Basilio Fiuminata Calcabrini Giampaolo Recanati Capodoglio Pierpaolo Recanati Caporaletti Mariella Recanati Capponi Giuseppe Tolentino Carbone Vanessa Potenza Picena Castignani Andrea Montecosaro -

Allegato 1 - Elenco Degli Interventi Importo Num Id Programmato Id Reg Regione Prov
Allegato 1 - Elenco degli Interventi Importo Num id programmato Id Reg Regione Prov. Comune Intervento_nome Proprietario Soggetto Attuatore Ordinanza Ord per intervento di origine € 1 1 ABRUZZO PE Città Sant'Angelo Istituto superiore “B. Spaventa”- corpo ovest COMUNE PROVINCIA DI PESCARA 1.221.700,00 € 33 2 2 ABRUZZO PE PENNE ITC “G. Marconi” Piccola Succursale COMUNE PROVINCIA DI PESCARA 611.065,00 € 33 3 3 ABRUZZO TE CAMPLI Nuovo plesso scolastico "Niccola Palma" COMUNE COMUNE DI CAMPLI 1.687.500,00 € 33 4 4 ABRUZZO TE CAMPLI scuola elementare e media COMUNE COMUNE DI CAMPLI 1.916.415,00 € 33 Scuola elementare e media - scuola "A. Gasbarrini"+ Scuola dell'infanzia - 5 5 ABRUZZO TE CIVITELLA DEL TRONTO COMUNE COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO 1.307.625,00 € 33 scuola "A. Gasbarrini" 6 6 ABRUZZO TE CROGNALETO Complesso scolastico "Carlo Forti" COMUNE COMUNE DI CROGNALETO 1.417.500,00 € 33 7 7 ABRUZZO TE MONTORIO AL VOMANO Scuola dell'infanzia "Leognano" COMUNE COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 390.000,00 € 33 8 8 ABRUZZO TE MOSCIANO SANT'ANGELO Scuola infanzia e asilo nido "Santa Maria degli Angeli"-Paritaria COMUNE COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO 393.750,00 € 33 9 9 ABRUZZO TE ROCCA SANTA MARIA Scuola elementare COMUNE COMUNE DI ROCCA S. MARIA 450.000,00 € 33 10 10 ABRUZZO TE SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA Direzione didattica plesso vecchio - Scuola Primaria COMUNE COMUNE DI S. EGIDIO ALLA VIBRATA 1.800.630,00 € 33 11 11 ABRUZZO TE TERAMO scuola dell'infanzia ed elementare “San Giuseppe” COMUNE COMUNE DI TERAMO 4.114.773,00 € 33 12 12 ABRUZZO TE TERAMO Scuola dell'infanzia villa Ripa COMUNE COMUNE DI TERAMO 230.602,50 € 33 13 13 ABRUZZO TE TERAMO I T C E PER PROGRAMMATORI " B. -

TRATTE CONTRAM MOBILITA' DA a TARIFFA Via ABBADIA DI FIASTRA
TRATTE CONTRAM MOBILITA' DA A TARIFFA Via ABBADIA DI FIASTRA CAMERINO 8 ABBADIA DI FIASTRA CINGOLI 7 ABBADIA DI FIASTRA CIVITANOVA MARCHE 6 ABBADIA DI FIASTRA MACERATA 2 ABBADIA DI FIASTRA PASSO COLMURANO 2 ABBADIA DI FIASTRA S.GINESIO 5 ABBADIA DI FIASTRA SARNANO 6 ABBADIA DI FIASTRA TOLENTINO 3 ACQUACANINA BOLOGNOLA 1 ACQUACANINA CAMERINO 6 ACQUACANINA MACERATA 10 ACQUAPAGANA CAMERINO 6 ACQUOSI CAMERINO 3 ACQUOSI CASTELRAIMONDO 2 ACQUOSI FABRIANO 5 ACQUOSI MATELICA 1 AGOLLA CAMERINO 4 AGOLLA SAN SEVERINO 5 ALBACINA CAMERINO 6 ALBACINA CASTELRAIMONDO 4 ALBACINA CERRETO D'ESI 1 ALBACINA CUPRAMONTANA 5 ALBACINA ESANATOGLIA 4 ALBACINA FABRIANO 2 ALBACINA FIUMINATA 6 ALBACINA MATELICA 2 ALBACINA SAN SEVERINO 6 ALBACINA SERRA S.QUIRICO STAZ. 3 AMANDOLA ANCONA 14 AMANDOLA CAMERINO 9 AMANDOLA CAMERINO 10 TOLENTINO AMANDOLA COMUNANZA 2 AMANDOLA GABELLA NUOVA 3 AMANDOLA GUALDO 4 AMANDOLA LOC. S.CROCE BV S.GINESIO 4 AMANDOLA MACERATA 9 AMANDOLA PASSO RIPE 5 AMANDOLA PASSO S.GINESIO 6 AMANDOLA PERUGIA 17 AMANDOLA POLLENZA 10 AMANDOLA RUSTICI 1 AMANDOLA S.GINESIO 5 AMANDOLA S.GINESIO 6 MONTEFORTINO AMANDOLA San Venanzo - Monte San Martin 2 AMANDOLA SARNANO 2 AMANDOLA TOLENTINO 6 AMANDOLA VECCIOLA 3 ANCONA AMANDOLA 14 ANCONA CAMERINO 15 ANCONA CAMPOROTONDO 12 ANCONA CASTELRAIMONDO 13 ANCONA CINGOLI 11 ANCONA COMUNANZA 15 ANCONA CORRIDONIA 10 ANCONA ESANATOGLIA 14 ANCONA M.S. GIUSTO 11 ANCONA MACERATA 9 ANCONA MATELICA 13 ANCONA MOGLIANO 11 ANCONA MONTECASSIANO 7 ANCONA MONTEFANO 6 ANCONA MUCCIA 14 ANCONA OSIMO AUTOSTAZIONE 4 ANCONA PASSATEMPO 5 ANCONA -

Bando Premio Brunetta DEFINITIVO
Ambito Territoriale Sociale n. 15 Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA BANDO DI CONCORSO PER N. 1 PREMIO DI LAUREA “BRUNETTA FORMICA” Art. 1 – Oggetto Il Comitato dei Sindaci dell’ATS n. 15 (di seguito indicato come promotore) con delibera n. 14 del 11.07.2018 ha promosso l’istituzione di un Premio di Laurea per ricordare la figura della Dott.ssa Brunetta Formica, primo Coordinatore dell’ATS 15 e fautrice dell’attuale assetto operativo attraverso la promozione e l’implementazione della rete integrata di interventi e Servizi Sociali locali. Il premio, dell’importo di € 1.000,00, verrà assegnato ad una tesi di laurea magistrale in Servizio Sociale, avente le caratteristiche e i contenuti indicati nel presente bando. Art. 2 – Destinatari Il premio verrà assegnato a chi avrà conseguito nell’anno solare 2019 un titolo di laurea magistrale presso un Ateneo nella Regione Marche, nei corsi di laurea specialistica in Servizio Sociale. Quale prima annualità del premio, saranno ammessi al concorso anche coloro che hanno conseguito una laurea magistrale presso una delle Università delle Marche, nei corsi di laurea specialistica in Servizio Sociale, nel triennio precedente (laureati a partire dal 1 gennaio 2016). La tesi di laurea deve avere, quale argomento di discussione, temi caratterizzanti la competenza dell’Ambito Territoriale Sociale quali, ad esempio (il seguente elenco costituisce una mera elencazione esemplificativa NON ESAUSTIVA): programmazione di politiche sociali (es. studio valutativo sui Piani Sociali di Ambito, studio comparativo e analisi dei diversi Piani Sociali elaborati da uno stesso Ambito, studio comparativo di Piani Sociali elaborati da diversi territori, ecc.), progettazione sociale (es. -

Mama Box for Your Stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese Mama Box Marca Maceratese
A box of ideas MaMa Box for your stay Marca Maceratese in the Marca Maceratese MaMa Box Marca Maceratese A box of ideas for your stay in the Marca Maceratese Lago di Fiastra - photo by Federica Baldi 2 Index Guide to MaMa box ................................ 7 Thematic areas ................................ 8 Marca Maceratese Portal ...............................11 MaMa in blue .............................. 13 The sea ................................. 14 MaMa sea ................................. 20 Water parks ................................. 25 Thermal baths ................................. 26 MaMa’s tips ................................. 27 Web experiences ................................. 28 Gentle hills and ancient villages .............................. 31 The most beautiful villages of Italy ................................. 32 / i"À>}iy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{x -«iÃ>`Àiiy>}ð°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{n The ancient villages ................................. 54 Fortresses and towers ................................. 58 MaMa’s tidbits ................................. 64 MaMa’s tips ................................. 69 Web experiences ................................. 70 MaMa mia what a show! .............................. 73 Mountain, parks, sports and active nature .............................. 97 National Park of Sibillini Mountains ................................. 98 Centres of Environmental Education ................................100 Natural reserves ................................102 Lakes ................................104 -
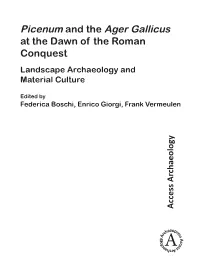
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest
Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest Landscape Archaeology and Material Culture Edited by Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen Access Archaeology aeopr ch es r s A A y c g c e o l s o s e A a r c Ah Archaeopress Publishing Ltd Summertown Pavilion 18-24 Middle Way Summertown Oxford OX2 7LG www.archaeopress.com ISBN 978-1-78969-699-8 ISBN 978-1-78969-700-1 (e-Pdf) © the individual authors and Archaeopress 2020 Cover: View of the Tronto Valley in the heart of the ancient Picenum. Drawing by Giorgio Giorgi. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Picenum and the Ager Gallicus at the Dawn of the Roman Conquest. Landscape Archaeology and Material Culture Federica Boschi, Enrico Giorgi, Frank Vermeulen (eds.) Contents Introduction - F. Boschi, E. Giorgi, F. Vermeulen I. P. Attema, Data integration and comparison in landscape archaeology: towards analysis beyond sites and valleys II. A. Gamberini, P. Cossentino, S. Morsiani, Romanization dynamics through the material culture analysis in the Ager Gallicus et Picenum III. O. Mei, L. Cariddi, Forum Sempronii and the Romanization of the Metauro Valley IV. F. Boschi, Methodological approaches to the study of the Cesano and Misa River Valleys (2010- 2020). New data: some thoughts and perspectives V.