La Sesia, Il Po E Il “Ponte Di Notingo”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Napoleonic Empire in Italy, 1796–1814
The Napoleonic Empire in Italy, 1796–1814 Also by Michael Broers THE POLITICS OF RELIGION IN NAPOLEONIC ITALY, 1800–1814 NAPOLEONIC IMPERIALISM AND THE SAVOYARD MONARCHY, 1773–1821 EUROPE UNDER NAPOLEON, 1799–1815 EUROPE AFTER NAPOLEON The Napoleonic Empire in Italy, 1796–1814 Cultural Imperialism in a European Context? Michael Broers Fellow of Lady Margaret Hall, Oxford © Michael Broers 2005 Softcover reprint of the hardcover 1st edition 2005 978-1-4039-0565-9 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The author has asserted his right to be identified as the author of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published 2005 by PALGRAVE MACMILLAN Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010 Companies and representatives throughout the world PALGRAVE MACMILLAN is the global academic imprint of the Palgrave Macmillan division of St. Martin’s Press, LLC and of Palgrave Macmillan Ltd. Macmillan® is a registered trademark in the United States, United Kingdom and other countries. Palgrave is a registered trademark in the European Union and other countries. -
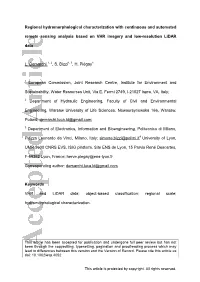
Regional Hydromorphological Characterization with Continuous and Automated Remote Sensing Analysis Based on VHR Imagery and Low-Resolution Lidar Data
Regional hydromorphological characterization with continuous and automated remote sensing analysis based on VHR imagery and low-resolution LiDAR data L. Demarchi 1, 2, S. Bizzi1, 3, H. Piégay4 1 European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Water Resources Unit, Via E. Fermi 2749, I-21027 Ispra, VA, Italy; 2 Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 166, Warsaw, Poland; [email protected]; 3 Department of Electronics, Information and Bioengineering, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, Milano, Italy; [email protected] University of Lyon, UMR 5600 CNRS EVS, ISIG platform, Site ENS de Lyon, 15 Parvis René Descartes, F-69362 Lyon, France; [email protected] Corresponding author: [email protected] Keywords VHR and LiDAR data; object-based classification; regional scale; hydromorphological characterization. This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process which may lead to differences between this version and the Version of Record. Please cite this article as doi: 10.1002/esp.4092 This article is protected by copyright. All rights reserved. Abstract Recent developments in Remote Sensing (RS) technologies lead the way in characterizing river morphology at regional scales and inferring potential channel responses to human pressures. In this paper, a unique regional database of continuous hydromorphological variables (HyMo DB) based on areal and topographic data has been generated from RS analysis. Key riverscape units with specific geomorphic meaning have been automatically mapped for 1700 km2 of river floodplains from simultaneous very-high-resolution (VHR) near-infrared aerial imagery and low-resolution LiDAR-derived products. -

Titolo Principale (Centro, Blu, Bold
Action 2.4 Evaluation of the current status of aggregates available for bituminous mixtures containing crumb rubber POLITECNICO DI TORINO Project partners Patrimonio s.r.l. With the contribution of Contents PART 1 - LOCALLY AVAILABLE STANDARD AGGREGATES ANALYSIS OF AVAILABLE DATA 3 Aggregates of the Piedmont Region 3 EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON AGGREGATES 7 Aggregates for mixtures containing scrap tyre rubber 7 CONCLUSIONS 8 PART 2 - INNOVATIVE/RECYCLED AGGREGATES 2 PART 1 – LOCALLY AVAILABLE STANDARD AGGREGATES The availability of aggregates for bituminous mixtures containing scrap tyre rubber was preliminarily assessed by examining the data provided by quarries distributed in northern Italy, with an emphasis placed upon those located in the Piemonte region. Based on the gathered data, useful aggregates for mixtures considered in the study were identified. They were subjected to characterization tests according to EN standards in the laboratories of “Innovative Road Materials” and of “Environmental Chemistry” of the Politecnico di Torino. ANALYSIS OF AVAILABLE DATA Aggregates of the Piedmont Region Available information of aggregates coming from quarries located in Piedmont was extracted from the Regional Quarry Plan, which contains data expressed in terms of: - lithological composition; - mineralogical composition; - resistance to fragmentation (Los Angeles test). Data were available on coarse (15/30 mm), intermediate (8/15 mm) and fine (0.2-0.3 mm) fractions and are synthesized in the following Tables 1-5. Table 1. Available sites and tests N. Location Formation Basin/Area L.A. Min. Petr. 1 Trecate (NO) Fluvio-glacial Sesia-Ticino sì sì sì 2 Turbigo (NO) Recent alluvional Ticino sì sì sì 3 Bellinzago (NO) Fluvio-glacial Sesia-Ticino sì sì sì 4 Agogno (NO) Fluvio-glacial Sesia-Ticino sì sì 5 Isola S. -

MAP Technical Reports Series No. 106 UNEP
MEDITERRANEAN ACTION PLAN MED POL UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS ASSESSMENT OF THE STATE OF EUTROPHICATION IN THE MEDITERRANEAN SEA EVALUATION DE L'ETAT DE L'EUTROPHISATION EN MER MEDITERRANEE by/par R.A. Vollenweider, A. Rinaldi, R. Viviani and E. Todini MAP Technical Reports Series No. 106 In cooperation with: En coopération avec: WHO/OMS UNEP Athens, 1996 Note: The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNEP, FAO or WHO concerning the legal status of any State, Territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of their frontiers or boundaries. This document was prepared by Professor R.A. Vollenweider, National Water Research Institute Burlington, Canada; Dr. A. Rinaldi, Laboratory "M.N. Daphne", Region of Emilia-Romagna, Italy; Professor R. Viviani of the University of Bologna; and Professor E. Todini of the University of Bologna. The overall technical responsibility was entrusted to FAO (Responsible Officer: G.P. Gabrielides). Note: Les appelations employées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du PNUE, de la FAO ou de l'OMS, aucune prise de position quant au statut juridique des Etats, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Le présent document a été préparé par M. le Professeur R.A. Vollenweider, National Water Research Institute Burlington (Canada), M. A. Rinaldi, Laboratoire "M.N. Daphne", Région Emilie- Romagne (Italie), M. -

Italy Nongeneric Names of Geographic Significance That Are Distinctive Designations of Specific Grape Wines Asti Spumante Barbar
Italy Nongeneric names of geographic significance that are distinctive designations of specific grape wines Asti Spumante Barbaresco Barbera d’Alba Barbera d’Asti Bardolino Barolo Brunello di Montalcino Dolcetto d’Alba Frascati Gattinara Lacryma Christi Nebbiolo d’Alba Orvieto Soave Valpolicella Vino Nobile de Montepulciano Names of wines with protected designations of origin Aglianico del Taburno Equivalent term: Taburno Aglianico del Vulture Albana di Romagna Albugnano Alcamo Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia Alezio Alghero Alta Langa Alto Adige followed by Terlano Equivalent term: Südtirol Terlaner Alto Adige followed by Meranese di collina Equivalent term: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner Alto Adige Equivalent term: dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler Alto Adige followed by Valle Isarco Equivalent term: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler Alto Adige followed by Valle Venosta Equivalent term: Südtirol Vinschgau Alto Adige followed by Santa Maddalena Equivalent term: Südtiroler St.Magdalener Alto Adige followed by Colli di Bolzano Equivalent term: Südtiroler Bozner Leiten Alto Adige or dell'Alto Adige whether or not followed by Burgraviato Equivalent term: dell'Alto Adige Südtirol or Südtiroler Buggrafler Alto Adige or dell'Alto Adige whether or not followed by Bressanone Equivalent term: dell'Alto Adige Südtirol or Südtiroler Brixner Ansonica Costa dell'Argentario Aprilia Arborea Arcole Assisi Asti preceded by 'Moscato di ' Atina Aversa Bagnoli di Sopra Equivalent term: Bagnoli Barbera del Monferrato -

Assessment of River Po Sediment Quality by Micropollutant Analysis Marina Camussoa,*, Silvana Galassib, Davide Vignatia
Water Research 36 (2002) 2491–2504 Assessment of river Po sediment quality by micropollutant analysis Marina Camussoa,*, Silvana Galassib, Davide Vignatia a Water Research Institute, C.N.R., Via della Mornera 25, 20047 Brugherio, Milan, Italy b University of Insubria, Via Valleggio 11, 22100 Como, Italy Received 2 January 2001; accepted 19 October 2001 Abstract Trace metals, PCB congeners and DDT homologues were determined in composite sediment samples collected from 10 representative sites along the river Po in two separate seasons. The aim was to identify the most anthropogenically impacted areas for future monitoring programmes and to aid development of Italian sediment quality criteria. The surface samples were collected during low flow conditions. Trace metal concentrations were assayed by electrothermal (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb), flame (Fe, Mn, Zn) or hydride generation (As) atomic absorption spectrometry after microwave assisted acid digestion. Hg was determined on solid samples by automated analyser. Organic microcontaminants were determined by gas-chromatography with 63Ni electron capture detector after Soxhlet extraction. Concentrations of trace metals, total PCB and DDT homologues showed two distinct peaks at the sites immediately downstream of Turin and Milan, respectively, and in each case decreased progressively further downstream. Principal component analysis identified three major factors (from a multi-dimensional space of 35 variables) which explained 85–90% of the total observed variance. The first and second factors corresponded to anthropogenic inputs and geological factors on sediment quality; the third included seasonal processes of minor importance. Sediment quality assessment identified Cd, Cu, Hg, Pb, Zn and organic microcontaminants as posing the most serious threats to river sediment quality. -

Memorie Della Accademia Delle Scienze Di Torino
Memorie della Accademia delle Scienze di Torino Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali Serie V, Volume 41 ACCADEMIA DELLE S CIENZE DI T ORINO 2017 Edito con il contributo dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG, unità di Torino) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 2017 ACCADEMIA DELLE S CIENZE DI T ORINO Via Accademia delle Scienze, 6 10123 Torino, Italia Uffi ci : Via Maria Vittoria, 3 10123 Torino, Italia Tel. +39-011-562.00.47; Fax +39-011-53.26.19 Tutte le memorie che appaiono nelle «Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino» sono disponibili in rete ad accesso aperto e sono valutate da referees anonimi attraverso un sistema di peer review . I lavori pubblicati sono classifi cati in base al seguente elenco di materie: Biologia animale e dell’uomo, Biologia vegetale, Chimica, Fisica, Geoscienze, Matematica, Scienza dell’informazione, Scienza dell’ingegneria, Scienze dell’ambiente, Scienze e ingegneria dei materiali, Storia delle scienze. L’Accademia vende direttamente le proprie pubblicazioni. Per acquistare fascicoli scrivere a: * [email protected] Per contattare la redazione rivolgersi a * [email protected] I lettori che desiderino informarsi sulle pubblicazioni e sull’insieme delle iniziative dell’Accademia delle Scienze di Torino possono consultare il sito www.accademiadellescienze.it ISSN: 1120-1630 ISBN: 978-88-99471-14-9 Acc. Sc. Torino Memorie Sc. Fis. 41 (2017), 3-143, 1 tab., 16 fi gg. GEOSCIENZE Geological Map of Piemonte Region at 1:250,000 scale Explanatory Notes Memoria di F!"#$%$& P$!'! *, L B*, R.& C!1'&'$** , A ’A.#$**,*, G F*, A I*, P M*, S T!++&'- *, G M.& * e M M*** presentata dal Socio corrispondente F!"#$%$& P$!'! nell’adunanza del 10 maggio 2017 e approvata nell’adunanza del 13 dicembre 2017 Abstract. -

Agreement Between the United States of America and the European Community on Trade in Wine
AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON TRADE IN WINE USA/CE/en 1 The UNITED STATES OF AMERICA, hereafter "the United States", and • The EUROPEAN COMMUNITY, hereafter "the Community", hereafter referred to jointly as "the Parties", RECOGNIZING that the Parties desire to establish closer links in the wine sector, DETERMINED to foster the development of trade in wine within the framework of increased mutual understanding, RESOLVED to provide a harmonious environment for addressing wine trade issues between the Parties, HAVE AGREED AS FOLLOWS: USA/CE/en 2 • TITLE I INITIAL PROVISIONS ARTICLE 1 Objectives The objectives of this Agreement are: (a) to facilitate trade in wine between the Parties and to improve cooperation in the development and enhance the transparency of regulations affecting such trade; (b) to lay the foundation, as the first phase, for broad agreement on trade in wine between the Parties; and (c) to provide a framework for continued negotiations in the wine sector. USA/CE/en 3 ARTICLE 2 • Definitions For the purposes of this Agreement: (a) "wine-making practice" means a process, treatment, technique or material used to produce wine; (b) "COLA" means a Certificate of Label Approval or a Certificate of Exemption from Label Approval that results from an approved Application for and Certification/Exemption of Label/Bottle Approval, as required under U.S. federal laws and regulations and issued by the U.S. Government that includes a set of all labels approved to be firmly affixed to a bottle of wine; (c) "originating" when used in conjunction with the name of one of the Parties in respect of wine imported into the territory of the other Party means the wine has been produced in accordance with either Party's laws, regulations and requirements from grapes wholly obtained in the territory of the Party concerned; (d) "WTO Agreement" means the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, done on 15 April 1994. -

PIEMONTE WHITE WATER Pesda a PESDA MINI GUIDE Press
ORTHERN Italy’s one of Europe’s best creeking destinations. With bedrock rapids, a predictable (though brief) season and plenty of gradient, more and more creek boaters are making the long haul over from Britain to paddle in Piemonte. PIEMONTE WHITE WATER Pesda A PESDA MINI GUIDE Press 08 10 09 06 14 07 01 04 05 03 02 11 13 12 15 17 16 LEVEL GAUGE - a rough idea of the optimal water levels required in the region, for quick comparison. FULL FACER - a run of a rocky or precarious nature, best to come equipped with full-on gear. GORGE - the run commits you to gorge sections that may make escape difficult or impossible. Chiusella. Photo: Dan Yates DAGGER - seldom run with rapids subject to periodic change - proceed with due caution. Piemonte White Water - Mini Guide 3 Piemonte’s rivers tend to be steep and committing. The author Peter Cornes (right) first visited Italy If your group aren’t used to tackling grade 5, often four years ago. This is in remote gorges, Piemonte isn’t for you. You’d his collection of river be better advised to head out to Slovenia, France notes, including rivers he’s paddled and those or Austria during the summer – it’s warmer still on his wish list and there’s a wider range of paddling. If you’re still determined to come to Italy, I’d strongly nb. recommend an instructional course with Gene17. gene17kayaking.com (cover) - Sermenzina, May 2004, Photos: Pete Wood (right) - Campertogno, viewed from the scenic and popular campsite. -

Sesia Valgrande Geopark
SESIA - VAL GRANDE GEOPARK Annex 6 List and detailed description of existing geosites Existing geological sites I= international value; N= national value; R= regional value 1. CHURCH OF ALBO (I): One of the main units of the Ivrea-Verbano Zone 2. CANDOGLIA (I): quarries of the pink marble of the Cathedral of Milano 3. PREMOSELLO (I): contact between continental mantle and lower continental crust 4. FINERO (I): one of the most studied mafic - ultramafic body of the world 5. BED OF THE SAN BERNARDINO RIVER (N): Scisti dei Laghi, an important Italian metamorphic unit 6. CADORNA ROAD: PIAN D’ARLA – OSPEDALETTO (I): the Leptynite – Amphibolite Group is very widespread in the European Hercynian belts 7. PONTE NIVIA (I): the Leptynite – Amphibolite Group is very widespread in the European Hercynian belts 8. CADORNA ROAD: P. FOLUNGO - MT. BAVARIONE (I): this is a complete section of the Strona-Ceneri Zone, a unit that has been investigated by many European scientists 9. PONTE CASLETTO (I): Cenerigneisses are a good example of metasediments with very complex evolution 10. SPOCCIA – ORASSO (I): the relations between the CMB line and the mafic Intrusion; the Appinite suite may be compared with similar rocks in Scotland. 11. ROAD PONTE SPOCCIA – SPOCCIA (I): the relations between the CMB line and the mafic Intrusion; the Appinite suite may be compared with similar rocks in Scotland. 12. POGALLO VALLEY (I): the Pogallo line 13. CASTLE OF VOGOGNA (I): mylonites of the Insubric (Canavese) line 14. PREMOSELLO – VOGOGNA (I): “fossil earthquakes 15. SCOPETTA - old bridge over the Sesia river (I): Mylonite of the Insubric Line. -

The Tectonometamorphic Evolution of the Sesia–Dent Blanche Nappes (Internal Western Alps): Review and Synthesis
Swiss J Geosci DOI 10.1007/s00015-014-0172-x The tectonometamorphic evolution of the Sesia–Dent Blanche nappes (internal Western Alps): review and synthesis Paola Manzotti • Michel Balle`vre • Michele Zucali • Martin Robyr • Martin Engi Received: 29 May 2014 / Accepted: 6 October 2014 Ó Swiss Geological Society 2014 Abstract This study reviews and synthesizes the present zone, indicating that the Sesia–Dent Blanche nappes rep- knowledge on the Sesia–Dent Blanche nappes, the highest resent a stack of several individual nappes. During the tectonic elements in the Western Alps (Switzerland and subsequent subduction of the Piemonte–Liguria Ocean Italy), which comprise pieces of pre-Alpine basement and large-scale folding of the nappe stack (including the Roi- Mesozoic cover. All of the available data are integrated in a san-Cignana Shear Zone) took place under greenschist crustal-scale kinematic model with the aim to reconstruct facies conditions, which indicates partial exhumation of the the Alpine tectono-metamorphic evolution of the Sesia– Dent Blanche Tectonic System. The entrance of the Bri- Dent Blanche nappes. Although major uncertainties remain anc¸onnais micro-continent within the subduction zone led in the pre-Alpine geometry, the basement and cover to a drastic change in the deformation pattern of the Alpine sequences of the Sesia–Dent Blanche nappes are seen as belt, with rapid exhumation of the eclogite-facies ophiolite- part of a thinned continental crust derived from the Adriatic bearing units and thrust propagation towards the foreland. margin. The earliest stages of the Alpine evolution are Slab breakoff probably was responsible for allowing partial interpreted as recording late Cretaceous subduction of the melting in the mantle and Oligocene intrusions into the Adria-derived Sesia–Dent Blanche nappes below the most internal parts of the Sesia–Dent Blanche nappes. -

Rapporti Biogeografici Tra Alpi Marittime E Alpi Orientali
©Ostalpin-Dinarischen Pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft, download www.zobodat.at Mitt. ostalp. -din. pflanzensoz. Arbeitsgem. Camerino, 1969 9 91-105 i RAPPORTI BIOGEOGRAFICI TRA ALPI MARITTIME E ALPI ORIENTALI G iu s e p p e B ono (Varallo Sesia) Puó forse sembrare temerario ed anche eccessivo tentare un accostamento tra le Alpi Marittime e le Alpi Orientali. Li Alpi Marittime non sono che una piccolissima porzione della ca- tena alpina. Tuttavia il progredire delle ricerche ha portato a constatare nella vegetazione di questa regione una profonda ori- ginalitá nel quadro dell'arco alpino occidentale e chiare affinitá con le Alpi Orientali. Di conseguenza O ze n d a (1966) suggeriva, come suggestiva ipotesi di lavoro, una interpretazione delle Alpi Marittime, nel loro tratto detto delle Alpi Liguri, come di « un fragment d'Alpes orientales accolé aux Alpes occidentales ». Questa affermazione è certo forte e, almeno alio stato at- tuale deMe conoscenze, prematura. Tuttavia le Alpi Marittime presentano caratteristiche di affinitá e legami con le Alpi Orien ta]], che conviene sottolineare pur senza esagerarne l'importanza e i! significato. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E LITOLOGICHE Sono da porre in risalto le seguenti particolarita: II contatto con il Mediterráneo e la presenza di grandi bar riere montagnose (appena una trentina di Km separano il mas sier io deil'Argentera-Mercantour con numeróse cime che supe- rano i 3000 m dal Mediterráneo) pone le Alpi Marittime come zona di tensione tra il dominio fitoclimatico mediterráneo e quello medioeuropeo. La posizione periférica rispetto alia catena alpina partico- 92 ©Ostalpin-Dinarischen Pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft, download www.zobodat.at larmente delle Alpi Liguri che dísegnaiio uno spuntone allungato ad est del Col di Tenda con direzione ovest-est.