Luigi Dallapiccola E Fernando Previtali
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
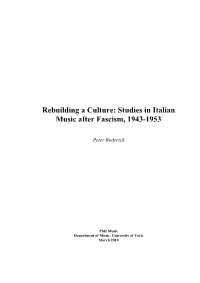
Thesis Submission
Rebuilding a Culture: Studies in Italian Music after Fascism, 1943-1953 Peter Roderick PhD Music Department of Music, University of York March 2010 Abstract The devastation enacted on the Italian nation by Mussolini’s ventennio and the Second World War had cultural as well as political effects. Combined with the fading careers of the leading generazione dell’ottanta composers (Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero and Ildebrando Pizzetti), it led to a historical moment of perceived crisis and artistic vulnerability within Italian contemporary music. Yet by 1953, dodecaphony had swept the artistic establishment, musical theatre was beginning a renaissance, Italian composers featured prominently at the Darmstadt Ferienkurse , Milan was a pioneering frontier for electronic composition, and contemporary music journals and concerts had become major cultural loci. What happened to effect these monumental stylistic and historical transitions? In addressing this question, this thesis provides a series of studies on music and the politics of musical culture in this ten-year period. It charts Italy’s musical journey from the cultural destruction of the post-war period to its role in the early fifties within the meteoric international rise of the avant-garde artist as institutionally and governmentally-endorsed superman. Integrating stylistic and aesthetic analysis within a historicist framework, its chapters deal with topics such as the collective memory of fascism, internationalism, anti- fascist reaction, the appropriation of serialist aesthetics, the nature of Italian modernism in the ‘aftermath’, the Italian realist/formalist debates, the contradictory politics of musical ‘commitment’, and the growth of a ‘new-music’ culture. In demonstrating how the conflict of the Second World War and its diverse aftermath precipitated a pluralistic and increasingly avant-garde musical society in Italy, this study offers new insights into the transition between pre- and post-war modernist aesthetics and brings musicological focus onto an important but little-studied era. -

Il Quarto Padre Della Dodecafonia
Mario Ruffini, Il quarto padre della dodecafonia, in: «Caffè Michelangiolo», Rivista di discussione e cultura, Accademia degli Incamminati, IX, 2 (maggio- agosto 2004), Firenze, Pagliai Polistampa, 2004, Copertina, Frontespizio, Retrofrontespizio, pp. 4-12 In occasione del primo centenario della nascita di Luigi Dallapiccola (1904-2004), Caffè Michelangiolo ha chiesto a Mario Ruffini uno scritto commemorativo sul compositore e un bilancio delle celebrazioni Nel primo centenario della nascita di Luigi Dallapiccola (1904-2004) uno scritto commemorativo e alcune considerazioni IL QUARTO PADRE DELLA DODECAFONIA di Mario Ruffini Quando in tutto il mondo un personaggio viene ricordato in occasione del centenario della nascita, vuol dire che la sua opera è ormai un valore riconosciuto e condiviso della coscienza collettiva. Questo è il dato forse più rilevante delle celebrazioni dedicate alla figura di Luigi Dallapiccola. È utile pertanto ricordare le opere più significative del grande compositore e sottolineare gli aspetti peculiari del suo dettato etico e estetico. Due sono i capolavori che maggiormente caratterizzano Luigi Dallapiccola: la Trilogia, che percorre il primo periodo come una biografia (Canti di prigionia; Il Prigioniero; Canti di liberazione) e l’Ulisse che segna l’arrivo di tutto il percorso. Negli scritti giovanili Dallapiccola ricorda il periodo di internamento a Graz, quando l’assidua frequentazione del Teatro dell’Opera lo portò a una profonda conoscenza delle opere di Richard Wagner, di cui il quattordicenne istriano dichiara -

In Ricordo Di LUIGI DALLAPICCOLA
In ricordo di LUIGI DALLAPICCOLA Numero speciale del « Notiziario " delle Edizioni Suvini Zerboni - Milano Spedizione in abbonamento postale - gruppo IV In ricordo di LUIGI DALLAPICCOLA EDIZIONI SUVINI ZERBONI - MILANO Si sa che ai tempi della giovinezza di Dallapiccola, nei vasti strati incolti del conformismo musicale italiano (e conservatoriale in ispecie), intellet tualismo - anzi cerebralismo - valeva come corollario di cultura, come etichetta-marchio, come l'« uncino » da appendervi il non-conformista. Che poi un Dallapiccola, colto-intellettualista-cerebrale, abbia in parte assunto quell'uncino e Io abbia rivoltato in arma rispondeva al gioco. Ora il Maestro, che pure non ha fatto a tempo a conoscere la vera vec chiaia, è vissuto abbastanza da vedere cancellarsi quell'etichetta e da can cellarla lui stesso. Cosi il grado di << amicizia » con Luigi Dallapiccola lo si poteva misurare dal progressivo sfogliarsi - nell'incontro - della sua corazza « intellettua listica »: quindi dalla possibilità - sorprendente da principio - di verifì• carne l'esiguità e infine l'estraneità sostanziale al suo essere, alla sua per sona, alla qualità stessa della sua vera cultura: rigorosa ma emotiva e fantastica se mai altra. Senza averlo mai sentito scendere nella futilità, l'ho però sentito parteci pare del quotidiano- suo e altrui- con vivacità e, nel caso, con apprensione. Ma anche a restar fuori dal quotidiano, anche al livello della sua cultura di compositore, c'è da dire come egli ti desse di continuo la possibilità di smantellare la scolasticità di quei temi obbligati che sul suo conto sono sempre corsi, per chi avesse a scrivere o a parlare di lui: l'umanesimo di L.D.; la religiosità di L.D.; cronaca e storia in L.D. -

Luca Sala: Gli Anni Quaranta Di Luigi Dallapiccola Tra Ricostruzione Ed Espressione E La Genesi Di »Rencesvals
Luca Sala: Gli anni Quaranta di Luigi Dallapiccola tra ricostruzione ed espressione e la genesi di »Rencesvals. Note di carteggio inedito Schriftenreihe Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 50 (2013) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative- Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Gli anni Quaranta di Luigi Dallapiccola tra ricostruzione ed espressione e la genesi di »Rencesvals« Note di carteggio inedito Luca Sala »Ricordatemi al caro Petrobelli«1 Che Dallapiccola rappresentasse »il punto più importante del Festival«2 internazio- nale di musica contemporanea del 1939 ce lo rivela Goffredo Petrassi in una lettera inedita a Mario Corti dell’11 novembre 1938, in merito alla possibilità di includere il non ancor terminato Volo di notte – e già peraltro formalmente richiesto »per la prima rappresentazione […] nel teatro di Brunswick«3 – all’interno della rassegna settembrina di Venezia. A questa missiva Petrassi acclude anche la richiesta formale al Ministero della Cultura Popolare, firmata da lui e da Corti in qualità di funzionari rispettivamente del Teatro La Fenice e della Biennale: Il Comitato del Festival Internazionale, dovendo svolgere il lavoro preparatorio per l’organizzazione del VII° Festival che avrà luogo a Venezia nel Settembre XVII°, chiede a Codesto On. -

University of Cincinnati
UNIVERSITY OF CINCINNATI Date: 26 December 2007 I, Shu-Ting Yang, hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: Doctor of Musical Arts in: Piano Performance It is entitled: Salute to Bach: Modern Treatments of Bach-Inspired Elements in Luigi Dallapiccola’s Quaderno Musicale di Annalibera and Heitor Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras No. 4 This work and its defense approved by: Chair: __Jeongwon_Joe,_Ph.D.__________ __Eugene_Pridonoff,_M.M._______ __Elizabeth_Pridonoff,_M.M.____ Salute to Bach: Modern Treatments of Bach-Inspired Elements in Luigi Dallapiccola’s Quaderno Musicale di Annalibera and Heitor Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras No. 4 A doctoral document submitted to the Division of Graduate Studies and Research of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS in the Keyboard Division of the College-Conservatory of Music by Shu-Ting Yang 16 November 2007 B.M., National Taiwan Normal University, 1999 M.M., Indiana University, 2002 P.D., Indiana University, 2003 Project Advisor: Jeongwon Joe, Ph.D. Abstract Being two of a few Bach-inspired masterpieces in the twentieth-century keyboard repertoires, Luigi Dallapiccola’s Quaderno Musicale di Annalibera and Heitor Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras No. 4 contain the application of modern treatments on long lasting traditional subjects: the Baroque music style and the B-A-C-H motif. In this document, I discuss both composers’ multi-style blend (neo-Baroque/Serialism for Dallapiccola and neo-Baroque/Nationalism for Villa-Lobos) side by side through a close examination of their biographical background and stages of evolution, followed by a theoretical analysis of these two representative works. -

Il Prigoniero Van Luigi Dallapiccola
© 2009 Mathilde Mayer : Il prigoniero van Luigi Dallapiccola Il prigoniero van Luigi Dallapiccola door Harry Mayer Tijdens het komende Holland-Festival zal de opera Il prigioniero (De gevangene) van Luigi Dallapiccola worden opgevoerd. Deze in de jaren 1944 tot 1948 ontstane één- acter herinnert, wat het tekstgegeven betreft, aan een enige jaren ouder werk van dezelfde toondichter: de Canti de prigionia (liederen uit de gevangenschap). Beide composities werden gecreëerd vanuit een diepe humane bewogenheid over het lot van ter dood veroordeelde gevangenen. De Canti di prigionia waren laatste gebeden van Maria Stuart, van de Romeinse geleerde en magistraat Boëthius en van Gerolamo Savonarola. In Il prigioniero is het een uit Vlaanderen afkomstig, niet met name genoemd slachtoffer van de hertog van Alva. De sfeer van het ene zowel als van het andere werk is tragisch, desolaat en in sommige momenten van een beklemmende dramatiek. Doch terwijl de Canti nog uitlopen op een berustend geloof in de overwinning van de geest, eindigt Il prigioniero in de somberst denkbare desillusie en wanhoop. Dallapiccola verdeelde zijn drama in een proloog, twee koorintermezzi en vier tonelen. In de proloog horen wij de klacht van de moeder van de gevangene op één der twaalftoonsreeksen, waaruit de componist het rijk gelede klankenweefsel heeft opgebouwd. Heel eigenaardig is het dat in Dallapiccola’s dodecafoniek de reeksen méér zijn dan alleen maar grondstoffen voor melodieën en harmonieën. Iedere reeks is bij deze componist verbonden met een bepaalde uitdrukkingswaarde; in dit opzicht kan men haar betekenis enigszins vergelijken met die van een grondthema uit een muziekdrama van Wagner. Trouwens, ook het gebruik van meer dan één reeks in een zelfde werk is wel heel afwijkend van de normale praktijken der Oostenrijkse twaalftoonsmeesters, die hele opera’s op slechts één reeks componeerden. -

Dallapiccola
MUSICA ITALIANA SUPER AUDIO CD DALLAPICCOLA IL PRIGIONIERO Danish National Concert Choir Anna Maria Chiuri mezzo-soprano Danish National Symphony Orchestra Stephan Rügamer tenor Michael Nagy baritone Gianandrea Noseda Luigi Dallapiccola, around thetimeofcomposing‘Ilprigioniero’ Dallapiccola,around Luigi Boosey & Hawkes Collection / ArenaPAL Luigi Dallapiccola (1904 – 1975) Il prigioniero (1944 – 48)* 43:10 A Prologue and One Act Libretto by Luigi Dallapiccola after ‘La Torture par l’espérance’ by Count Villiers de L’Isle-Adam (1838 – 1889) and ‘La Légende d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak’ by Charles De Coster (1827 – 1879) Time: Second Half of the Sixteenth Century Prologo 1 La madre: ‘Ti rivedrò, mio figlio!’ – 6:16 2 [Primo Intermezzo Corale] – 1:18 Atto Unico Scena Prima 3 Il prigioniero: ‘Ero solo. Tutt’era buio’ – 5:51 Scena Seconda 4 Il prigioniero: ‘Solo. Son solo un’altra volta’ – 13:28 3 Scena Terza 5 Il prigioniero: ‘Signore, aiutami a camminare’ – 1:14 6 [Ricercare primo, super ‘Signore, aiutami a camminare’] – 1:56 7 [Ricercare secondo, super ‘Fratello’] – 3:18 8 [Ricercare terzo, super ‘Roelandt’] – 3:18 9 [Secondo Intermezzo Corale] – 1:26 Scena Quarta (ultima) 10 Il prigioniero: ‘Alleluja!’ 5:02 Prima Serie dei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane (1933) 9:09 (First Series of the Choruses of Michelangelo Buonarroti the Younger) for Mixed Voices, without Accompaniment A mio padre e a mia madre 11 a Il Coro delle Malmaritate. Moderatamente mosso – Molto meno – Tranquillo – 4:34 12 b Il Coro dei Malammogliati. Vigoroso -

Luigi Dallapiccola's Liriche Greche : an Analysis for Performance
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The qnality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 LUIGI DALLAPICCOLA'S LIRICHE GRECHE: AN ANALYSIS FOR PERFORMANCE by Elizabeth Woodall James-Gallagher A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts Greensboro 1994 Approved by Dissertation Advisor DMI Number: 9520535 Copyright 1994 by James-Gallagher, Elizabeth Woodall All rights reserved. -

Fascist Disenchantment and the Music of Goffredo Petrassi
FASCIST DISENCHANTMENT AND THE MUSIC OF GOFFREDO PETRASSI ALESSIA ANGELA ELDA MACALUSO A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN MUSIC YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO April 2017 © Alessia Angela Elda Macaluso, 2017 ii ABSTRACT Goffredo Petrassi (1904-2003) was one of many Italian composers who navigated the period of Italian Fascism from the height of its following to its demise. He celebrated the early years of the regime through music, and benefitted from prestigious official appointments. From this, he was able to shape and implement cultural policy, and enforced some of the regime’s coercive laws upon the musical world. After the alliance between Fascist Italy and Nazi Germany in 1939, particularly when Italy entered the Second World War, he used music to express his disillusionment. Petrassi is regarded as one of the most significant composers of his generation, yet few writings in English address the Fascist era itself in terms of music, much less the development of Petrassi’s compositional style within its socio-political framework. This dissertation contends that political events influenced Petrassi’s aesthetic journey, and that his initial support of and eventual opposition to the regime found expression in his works. Petrassi believed that art was always a spiritual autobiography (“autobiografia spirituale”). Hence, the methodology uses primary sources, musical analysis, and comparisons with composers such as Luigi Dallapiccola (1904-1975) to authenticate that Petrassi’s unique sound was a product of musical influences adapted to the shifting politics of Fascism. -

Dallapiccola Luigi
DALLAPICCOLA LUIGI Compositore e pianista italiano (Pisino, Istria, 3 II 1904 – Firenze 19 II 1975) Iniziati gli studi musicali a Pisino, durante la prima guerra mondiale seguiva il padre, internato a Graz. Ritornato nel 1918 nella città natale, quindi a Trieste continuò gli studi di musica, che terminò con E. Consolo (pianoforte) e con V. Frazzi (composizione) al conservatorio di Firenze, dove si era stabilito nel 1922. Nel 1930 costituì col violinista S. Materassi un duo per la diffusione della musica contemporanea. Insegnante di pianoforte complementare dal 1934 al 1967 al conservatorio di Firenze, dal 1945 al 1947 è stato critico musicale del "Mondo" di Firenze. Nel 1946 ha trattato a Londra la riammissione dell'Italia alla Società internazionale di musica contemporanea e, ottenutala, divenuto segretario della sezione italiana 1 della società stessa dal 1946 al 1949 vivacemente si è adoperato per il reinserimento della musica italiana nell'area internazionale. Nel 1949 era entrato in contatto epistolare con Schonberg, nel 1952 aveva incontrato per la prima volta a New York Thomas Man. Nel 1951 e nel 1952 ha tenuto corsi di composizione al Berkshire Music Center di Tanglewood (USA), Nel 1956 è stato nominato professore di composizione al Queen's College di New York, nel 1962 ha insegnato per un semestre all'University of California di Berkeley. Membro delle maggiori accademie d’Europa (Santa Cecilia di Roma, 1939-1972; Bayerische Akademie der Kunste di Monaco di Baviera, 1953; Akademie der Kunste di Berlino e Reale accademia delle arti di Stoccolma, 1958; Istituto di Francia, 1968; Royal Academy of music di Londra, 1969), nel 1964 è stato nominato membro corrispondente della Accademia nacional de bellas artes de la Argentina e dell'American Academy of Arts nonché del National institute of Arts and Letters di New York, e nel 1967 Doctor of Music honoris causa della Michigan University. -

Nonlinear Time Dallapiccola Diss Final
ON THE POETICS OF NONLINEAR TIME: DALLAPICCOLA’S CANTI DI LIBERAZIONE A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY by Sabrina R. Clarke Diploma Date May 2016 Examining Committee Members: Cynthia Folio, Advisory Chair, Music Studies (Theory) Maurice Wright, Music Studies (Composition) Michael Klein, Music Studies (Theory) Brian Alegant, External Member, Oberlin Conservatory ! © Copyright 2016 by Sabrina Clarke All Rights Reserved ii ! ABSTRACT The final piece of Dallapiccola’s “protest triptych” responding to Mussolinian fascism, Canti di Liberazione (1955) shows Dallapiccola’s abiding interest in author James Joyce’s work through its literary-inspired “simultaneity” and compositional strategies that suggest mixed temporalities (diverse temporal modes). This connection has significant implications on both the temporal and narrative forces at play within the work. Incorporating the work of philosophers such as Bergson and Adorno, I situate nonlinearity within the context of twentieth-century cultural life. Following Kern, I discuss the juxtaposition of distinct temporalities (simultaneity) in work such as Joyce’s Ulysses, which Dallapiccola adored, in addition to providing an overview of simultaneity in music. Next, I draw from Kramer and Reiner in examining the manifestations of linearity and nonlinearity in music. I explain how intertextuality has nonlinear implications and invites hermeneutic interpretation. Following Brown, I identify different types of symbolism and quotation in the work. Motivic elements such as the BACH cryptogram, musical references to Canti di Prigionia and Il Prigioniero, and structural symbolism such as palindromic gestures, are all crucial components of Liberazione’s unique temporal nexus. -

The Many Souls of Dallapiccola's "Ulysses"
D e M u s i c a XIV· Nuove Pagine 3 · 2008 The Many Souls of Dallapiccola's "Ulysses" A m a l i a C o l l i s a n i In 1959 Luigi Dallapiccola began working on his Ulysses. At that time opera - the genre which had combined music and drama from the seventeenth to the nineteenth century - was “finished, dead and buried”,1 but its ghost continued to haunt every composer who wished to write for the theatre. Dallapiccola had already composed a number of dramas set to music, but he had never dared to go beyond one act, even in the definitions printed on the scores. Moreover, at the time of the composition of Volo di notte(1937-8), which is set in the airport office of a shipping company, he had distanced himself from myth, a remarkable fact in the light of his intention to compose an opera, originally one of those genres most deeply permeated with myth and mythology: But why - he had written - continue indefinitely to celebrate the Argonauts, for example, to whom we have felt akin only through a work of art, and who have made us vibrate only with mediated emotion, when someone like Lindberg has caused us to throb with direct elemental emotion? Let us therefore give the form of art to our own experience, which is personal and, therefore, more sincere.2 His subsequent work for the theatre, however, displayed a different conception of aesthetic “sincerity”, or, perhaps, it merely showed that he no longer felt the need to declare the topicality of his own work.