Francesco Beccaruzzi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
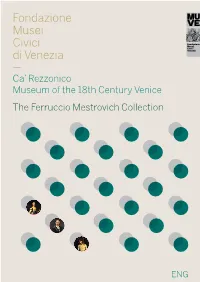
Ca' Rezzonico
Fondazione Musei Civici di Venezia — Ca’ Rezzonico Museum of the 18th Century Venice The Ferruccio Mestrovich Collection ENG da ballo MEZZANINE BROWNING / THE FERRUCCIO MESTROVICH COLLECTION Canal Grande The Collection The collection contains a nucleus his assets were confiscated by of sixteen paintings, all of high the Yugoslav government and never quality. returned. There are two major works by His son Audace worked for many Iacopo Tintoretto, an altar-piece of years in Venice as a lawyer. striking intensity and an austere His youngest son, Ferruccio, portrait. Particularly noteworthy a passionate scholar of early is a glowing and intimate “Sacra Veneto painting, is the donor of Conversazione” by Bonifacio de’ this collection: the attributions of Pitati; in addition, there are other the paintings are the result of his works by Benedetto Diana, Lelio research and studies; indeed, his Orsi, Jacopo Amigoni, Francesco suggestions and indications have Guardi and Alessandro Longhi, two assisted several scholars on many “soprarchi” (paintings above an occasions in the publication of his arch) by Benedetto Carpaccio, son paintings and other collections. and follower of Vittore and a small panel by Cima da Conegliano. The Mestrovichs belong to an ancient Dalmatian family originally from Zara and have lived in Venice since 1945. The head of the family, Aldo (1885-1969) was persecuted during the Austrian rule for his Ca’ Rezzonico, The Ferruccio Mestrovich Collection Italian patriotism; > 1 1. Benedetto Diana section of the polyptych frieze in the ITINERARY AND (Venice, 1460 ca. – 1525) San Francesco convent church in WORKS OF ART Christ Benedictory Miglionico, near Matera, taken there (oil on wood, 60 x 52,5 cm) at the end of the 16th century after being purchased in Venice by Don It’s a very interesting work of art Marcantonio Mizzoni. -
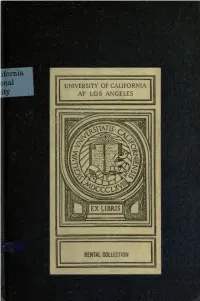
The Venetian Painters of the Renaissance : with an Index to Their
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES RENTAL COLLECTION By Bernhard Berenson The Venetian Painters of the Renaissance. With a Frontispiece. Third Edition. Revised and enlarged. Crown 8vo, gilt top The Florentine Painters of the Renaissance. With a Frontispiece. Third revised and enlarged edition. Crown 8vo. The Central Italian Painters of the Renais- sance. With a Frontispiece. Second revised and enlarged edition. Crown 8vo. The North Italian Painters of the Renaissance. With Frontispiece. Crown 8vo. G. P. PUTNAM'S SONS Ne-w "YorK London PAINTERS TI ANCE Shepherd with Pipe, from the Painting by Giorgione, at Hampton Court. G. \ ONS tlbe Knickerbocker |>re0 THE VENETIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE WITH AN INDEX TO THEIR WORKS BERNHARD BERENSON " AUTHOR OF FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE," " " CENTRAL ITALIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE THIRD EDITION G. P. PUTNAM'S SONS NEW YORK AND LONDON Gbe "Knickerbocker press COPYRIGHT, 1894 BY G. P. PUTNAM'S SONS Entered at Stationers' Hall, London, BY G. P. PUTNAM'S SONS Made in the United States of America Art Library NOTE TO THIRD EDITION. VjJ ij TN this edition changes have been made in 3 the numbering of the Venice and Vienna <: Galleries, as well as of some minor collections, 55 to correspond to recent rehanging. Many other alterations have been required by the breaking up of private collections. In several r- instances it has been impossible to trace ^ pictures to their new homes, and of such the more important remain under the names of ^ their former owners. To the lists of painters have been added Beccaruzzi, Caprioli, Polidoro Lanzani, Rocco Marconi, Andrea Schiavone, 1 and Girolamo da Treviso, artists important ' O to be but of merit so i enough missed, unequal j ^> - <o that only their more interesting works are here given. -

A CITY to BE VISITED Guide to the Museums of the City of Vittorio Veneto
A CITY TO BE VISITED Guide to the museums of the City of Vittorio Veneto Città di Vittorio Veneto City of Vittorio Veneto www.vittorioveneto.gov.it www.turismovittorioveneto.gov.it CITY OF VITTORIO VENETO Ideally situated between Venice and Cortina, surrounded by hills (most of which are planted with grapes for the production of the famous Prosecco DOCG wine) and crossed by the Meschio river, along which several forms of craftsmanship and industries have developed over the years, Vittorio Veneto can be considered as the main city of the Treviso Prealps. Founded in 1866 by the union of the two former municipalities of Serravalle and Ceneda, it was named “Vittorio” after the first king of Italy, Vittorio Emanuele II, and officially became “Vittorio Veneto” in 1923. The city is particularly renowned for being the place where the final stages of the Great War were fought and received the Gold Medal for its efforts in the Italian resistance movement during World War II. It also houses works by some of the greatest Italian artists, such as Sansovino (1486-1570) and Titian (1490 ca. -1576). Vittorio Veneto was the birthplace of Lorenzo Da Ponte (1749 - 1838), best known for his collaboration with Mozart, for whom he wrote the trilogy composed by The Marriage of Figaro, Don Giovanni and Così fan tutte. Its ancient bishopric seat was also the seat of the episcopate of Albino Luciani (1912-1978), later Pope John Paul I. THE CITY’S This simple brochure, which is deliberately concise in content and reduced in size, cannot therefore adequately express this MUSEUMS wealth and variety, but it is intended to offer a practical tool that can stimulate curiosity and interest in visiting the city’s museums. -

Alla Scoperta Della Città Discovering the Town
IT EN Valdobbiadene. Alla scoperta della città Discovering the town CITTÀ DI VALDOBBIADENE 1 IAT Valdobbiadene Tourist Information Office Piazza Marconi, 1 - Valdobbiadene - TV Tel. +39 0423 976975 - [email protected] www.valdobbiadene.com 2 Piazza Marconi, vista del campanile e del Duomo di Santa Maria Assunta Piazza Marconi, view of the bell tower and the Cathedral of Santa Maria Assunta 3 Abate G. Follador, Meridiana del campanile Abbot G. Follador, Sundial on the bell tower VALDOBBIADENE Itinerario in centro Un suggestivo percorso che propone siti reli- La sua fondazione risale al XII secolo ma giosi e non, alla scoperta di interessanti per- l’attuale edificio, in stile neoclassico, è il ri- sonaggi legati all’antica Duplavilis, l’attuale sultato di un’importante ristrutturazione set- Valdobbiadene. tecentesca. Un cammino che conduce ad angoli ancora Di lato svetta l’imponente campanile proget- sospesi nel tempo, racchiusi tra terra, acqua e tato dall’architetto Francesco Maria Preti di cielo, attraversando luoghi contraddistinti da Castelfranco Veneto la cui costruzione iniziò piccoli e grandi tesori d’arte. nel 1743 e terminò solo nel 1810 con la realiz- L’itinerario inizia in Piazza Marconi con la zazione della singolare cuspide a bulbo. visita al Duomo dedicato a Santa Maria As- Il campanile è decorato dalla meridiana sunta che conserva al suo interno preziose dell’abate Giovanni Follador, che nel 1862 opere d’arte realizzate da artisti del calibro di ideò e calcolò quest’orologio solare a “tem- Francesco Beccaruzzi, Paris Bordon e Palma po medio”, cioè riferito al meridiano centrale il Giovane. d’Europa. 4 VALDOBBIADENE Tour of the town centre This spellbinding tour leads visitors through works of art by such illustrious names as sacred and spiritual sites and introduces them Francesco Beccaruzi, Paris Bordon and Pal- to interesting figures from the ancient town of ma il Giovane. -

Archeologia E Storia Dell'arte
Allma Mater Studiiorum – Uniiversiità dii Bollogna DOTTORATO DI RICERCA IN Archeologia e Storia dell’Arte Ciclo XXVII Settore Concorsuale di afferenza: 10 B/1-STORIA DELL’ARTE Settore Scientifico disciplinare: L-ART/02-STORIA DELL’ARTE MODERNA TITOLO TESI “IL LIBRO DI SPESE DIVERSE DI LORENZO LOTTO. ANALISI E COMMENTO” Presentata da: FRANCESCO DE CAROLIS Coordinatore Dottorato Relatore PROF. GUGLIELMO PESCATORE PROF. ssa SONIA CAVICCHIOLI Esame finale anno 2015 INDICE INTRODUZIONE p. 3 COMMENTO p. 90 BIBLIOGRAFIA p. 175 Anni 1542. A NATIVITATE. Libro di spese diverse 1542 p. 208 INTRODUZIONE Premessa L’analisi e il commento di una fonte, specie se si tratta di materiale di prima mano, sono attività di studio tanto necessarie alla comprensione del mondo in cui agisce un artista che una loro giustificazione può apparire superflua. Lo studio del Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto, oggetto di questo lavoro di ricerca, potrebbe tuttavia risultare ridondante se si considerano le tre edizioni del testo già edite rispettivamente da Adolfo Venturi, Pietro Zampetti e Floriano Grimaldi, ma le ragioni per cui si è ritenuto opportuno sottoporre il testo ad una nuova disamina derivano dalla consapevolezza delle caratteristiche peculiari dello stesso e si intersecano con riflessioni di carattere più ampio. Innanzitutto è bene ricordare che il Libro è una fonte strutturata in forma di rubrica1, nella quale le note, trascritte in ordine alfabetico, fanno riferimento al bilancio patrimoniale dell’artista. Esse dunque riguardano commissioni, spese per il sostentamento personale e dei suoi allievi, tasse e regalie per parenti e amici. Circa poi il genere di questa fonte, più volte gli studi hanno ricordato come si tratti di un libro di conti, e del fatto che il pittore faccia uso di un rudimentale sistema a partita doppia, con i debiti (il dare) segnati sulla carta di sinistra e i crediti (l’avere) su quella di destra, ma mai ne hanno inteso il valore più autentico. -

A Cura Di Giandomenico Romanelli Conegliano, Palazzo
A cura di Giandomenico Romanelli Conegliano, Palazzo Sarcinelli, 7 marzo - 28 giugno 2015 Dopo la grande mostra del 1963 a Palazzo Ducale a Venezia, il felice ritorno dell’ultimo sorprendente Carpaccio e la scoperta del figlio Benedetto a Palazzo Sarcinelli a Conegliano. La mostra promossa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie, secondo appuntamento del ciclo progettato da Giandomenico Romanelli, a Palazzo Sarcinelli, vuole indagare e illustrare gli ultimi dieci anni dell’attività di Vittore Carpaccio (dal 1515 al 1525 ca.) considerato il più grande narratore, ‘teatralizzatore’ e vedutista ante- litteram nella pittura veneziana, anni che sono segnati da un’ importante svolta nella sua poetica. In mostra capolavori di grandissima qualità e originalità, dipinti celebri da ritrovare come il San Giorgio che lotta con il drago di San Giorgio Maggiore, la Pala di Pirano, il Polittico da Pozzale del Cadore, o la particolarissima Entrata del podestà Contarini a Capodistria che, nella prospettiva adottata, consente allo spettatore un insolito e realistico sguardo sulla città; opere da riscoprire come le clamorose Portelle d’organo dal Duomo di Capodistria o il Trittico di Santa Fosca ricomposto da Zagabria, Venezia e Bergamo in occasione della mostra; e ancora dipinti da scoprire, di fatto mai visti, come la novità assoluta del Padre eterno tra i cherubini da Sirtori, (Lecco). Più di cinquanta opere tra dipinti, pale d’altare, disegni, documenti, stampe. Carpaccio era stato l’interprete (con Gentile Bellini, Basaiti e altri colleghi) di un gusto e di una sensibilità che nascevano e rispondevano alle esigenze di auto- rappresentazione e auto-celebrazione del considerevole ceto dei professionisti, mercanti, artigiani, pubblici funzionari e le Scuole (grandi e piccole) erano il luogo in cui tale ceto trovava la sua esplicitazione più compiuta e fortunata.