Tombe Preistoriche Nel Salento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae
CURRICULUM VITA E MINERVA FABIO INFORMAZIONI PERSONALI Nome MINERVA FABIO Codice Fiscale MNR FBA 75B04 D883I Nazionalità Italiana Luogo e Data di nascita GALLIPOLI IL 4 FEBBRAIO 1975 ESPERIENZA LAVORATIVA SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE • Date (da – a) anno 2001 • Nome e indirizzo del Amministrazione Comunale di Parabita (Le) datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici • Tipo di impiego - Progetto Progetto preliminare per il recupero e valorizzazione storico- naturalistica della gravina denominata “Cirlicì”, posta tra le contrade “Tufare” e “Masseria Nuova” misura 2.2 dei POR della Regione Puglia 2000-2006; • Principali mansioni e Progettista responsabilità Importo Lavori €. 1.000.000 • Date (da – a) anno 2003 • Nome e indirizzo del Amministrazione Comunale di Seclì (Le) datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici • Tipo di impiego - Progetto Progetto Definitivo e Direzione Lavori per la caratterizzazione della Ex Discarica “Macchia Rossa”, Comune di Secli’, di cui alla Delibera di G. C. n°61 del 06/03/2003 per l’incarico e Delibera di G. C. n°67 del 17/03/2003 per l’approvazione, approvato e finanziato dalla regione Puglia in fase di esecuzione; • Principali mansioni e Progettazione – Direzione dei Lavori – Sicurezza responsabilità Importo Lavori €. 103.000,00 • Date (da – a) anno 2004 Pagina 1 - Curriculum vitae di MINERVA FABIO • Nome e indirizzo del Amministrazione Comunale di Melpignano (Le) datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici • Tipo di impiego - Progetto Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori per la caratterizzazione della Ex Discarica “Murichella”, Comune di Melpignano, di cui alla Determina del responsabile del servizi n.12 del 29/01/2004; • Principali mansioni e Progettazione e Direzione dei Lavori responsabilità Importo Lavori €. -

Comune Di Alezio (Provincia Di Lecce
COMUNE DI ALEZIO (PROVINCIA DI LECCE) GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NOR- MATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA SAN PANCRAZIO ”. Importo progetto €. 585'000,00 - CUP : D36D14000210001 - CIG : 623878583E 1° VERBALE DI GARA del 08.06.2015 PREMESSO : ° che con determinazione n. 111 R.G. e n. 53 R.S. del 29.04.2015 si procedeva all’indizione dell'appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 401'287,50, di cui €. 391'500,00 per lavori a base d'asta e costo del personale ed €. 9'787,50 per oneri per la sicurezza, oltre ad €. 10'823,80 per la progettazione esecutiva (appalto integrato), me- diante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma trentasette, e art. 55, quinto comma, del D.L.vo n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso formulato sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, let. b), del su ci- tato D.L.vo n. 163/2006, e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i dispo- sti dell'art. 86 del su richiamato D.L.vo n. 163/2006; ° che con la medesima determinazione si approvava il bando di gara nel quale, tra l’altro, si stabiliva per le ore 15:00 del giorno 08.06.2015 l’inizio delle relative procedure; ° che entro i termini stabiliti e cioè entro le ore 11,00 del giorno 08.06.2015 sono pervenuti n. 82 plichi sigillati, da parte delle seguenti ditte e numerati come segue: 1) Prot. -

Agenzie S.T.P. Di Terra D'otranto - S.P.A
Agenzie S.T.P. di Terra d'Otranto - S.p.A. - Lecce Ragione Sociale Indirizzo Comune ACQUARICA DEL CAPO - EMPORIO DEL TABACCO DI SALVATORE CASSIANO CORSO DANTE, 99/B Acquarica del Capo ALESSANO - CARTOLIBRERIA DIEMME DI AMICO DAVIDE PIAZZA DON TONINO BELLO, 4 - ALESSANO Alessano ALESSANO - CIARDO GIANLUIGI - RIV. TAB PIAZZA DON TONINO BELLO, 34 - ALESSANO Alessano ALESSANO - RIZZO MARIA FIORA - RIV. TAB. via rimembranze, 32 - ALESSANO Alessano ALEZIO - AMICO MARIA GRAZIA - EDICOLA & LIBRERIA VIA MARIANA ALBINA, 27 - ALEZIO Alezio ALEZIO - TABACCHERIA N? 2 BRAY ROSA VIA ROMA, 232 - ALEZIO Alezio ALLISTE - L'INCHIOSTRO DI RAINO' MILENA VIA G. GARIBALDI, 11 - ALLISTE Alliste ANDRANO - RIZZO "EDICOLA & CARTOLERIA" VIA XXV LUGLIO - ANDRANO Andrano ANDRANO - TABACCHI ACCOGLI LUIGI VIA NAPOLI 48 Andrano ARADEO - EDICART POINT DI MIGHALI ANDREA ANTONIO VIA TORINO, 102 - ARADEO Aradeo ARADEO - NOVAKARTO 2 DI BOVE COSIMA VIA MATTEOTTI, 64 - ARADEO Aradeo ARNESANO - MASTERMIND DI CENTONZE FRANCESCO VIA DELLA LIBERTA', 14 - ARNESANO Arnesano ARNESANO - QUARTA ANTONIO - RIV. TAB. VIA MONSIGNOR RAFFAELE PERRONE - ARNESANO Arnesano ARNESANO-PALLARA MARIA GRAZIA TAB-MEME' VIA INDENNITATE, 2 Arnesano AVETRANA - NIGRO ALESSANDRO - RIV. TAB. VIA ROMA, 16 - AVETRANA Avetrana AVETRANA - NIGRO DANIELE VIA A. DE GASPERI - AVETRANA Avetrana BARBARANO - TABACCHI RIZZELLO DI RIZZELLO MICHELE VIA DI MEZZO, 1/3 Morciano di Leuca BOTRUGNO - EDICART DI FRACASSO FRANCESCA VIA VITTORIO EMANUELE, 52 Botrugno BOTRUGNO - GARBO CARTOLERIA FEDELE FRANCO VIA GARIBALDI, 14 - BOTRUGNO Botrugno BOTRUGNO - PUNTO GIOCO - F.LLI GUGLIELMO SNC VIA ROMA, 70 Botrugno CAMERA DI COMMERCIO VIALE GALLIPOLI Lecce CAMPI SAL. - PALAZZO ANTONIO - EDICOLA PIAZZA LIBERTA', 23 - CAMPI SALENTINA Campi Salentina CARMIANO - BRUNO MARIA EMANUELA TAB. -

Curriculum SEGRETARIO 11 06 2020.Pdf
MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DARIO VERDESCA Indirizzo VIA MENOTTI, 14 - 73045 LEVERANO (LE) Telefono Leverano 0832/923412 Telefono Porto Cesareo 0833/858100 E-mail [email protected] - [email protected] pec [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 26/01/1980 Codice Fiscale VRDDRA80A26F842L ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ABILITAZIONI Marzo 2019 – Marzo 2020 School of Management -Università LUM JEAN MONNET di Bari. Frequenza e conseguimento del titolo di Master Universitario di II° livello in “Public and Innovation Management – Smart City (MASIC) – 60 crediti formativi universitari- . SSAI (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno), ora SNA, di Roma. Gennaio — Luglio 2015. Partecipazione e conseguimento dell'idoneita al Corso di Specializzazione di cui all'art.14, comma 1, DPR 465/97 denominato "Spe.S edizione 2014" per il conseguimento dell' idoneità alla qualifica di Segretario Generale. 26/10/2009 al 16/10/2010 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale — SSPAL — di Roma. Corso di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'esercizio della professione di Segretario comunale e provinciale e relativa iscrizione all'Albo, discutendo una tesina finale sperimentale su "La lottizzazione: l'esperienza del Comune di Veglie". 07/07/05 Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza. Laurea in Giurisprudenza (durata del corso quadriennale) conseguita nell'anno accademico 2005/2006. Votazione 97/110. Indirizzo del corso di studi: classico Tesi di laurea in Diritto Amministrativo. Titolo: "La Dirigenza Pubblica". Dottore in Giurisprudenza Anno scolastico 1998/1999 Liceo Scientifico Statale "C. -

Masserie E Dimore Storiche Nel Salento Tour
Masserie e Dimore storiche nel Salento Tour Accomodation: Masseria Chicco Rizzo - Palazzo Castriota. Tenuta Masseria ChiccoRizzo is located in the center of “Grecia Salentina” an area with still a strong presence of an ancient past. The Masseria was born in 1700 as a "post office" for the change of horses linked to the old routes, which connected the Roman Traiana-Calabra roads to Sallentina. Once through the door of the estate, the charm of the past introduces you in an unforgettable experience: the deafening noise of everyday life turns into silence and ... everything regains the right time! Tenuta Masseria ChiccoRizzo (Sternatia) 2 Palazzo Castriota is a historic residence of high value, an ancient palace built between the end of the 1700s and the early 1800s, by Luigi Castriota and his wife, who, in love with rural lifestyle, decided to renew this palace immersed in the Apulian countryside, decorating the large hall with rural life scenes. The property also has a spa suite with chromotherapy ideal for a romantic getaway in total relaxation. Dimora Storica Palazzo Castriota (Alezio) “Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in ” (Robert Frost) 3 Tour Proposal: “Salento, history, culture and beautiful landscape” Salento: Sternatìa - Alezio 4 nights/ 5 days (with 1 night extension option) April - October 2020 Experience Legenda: - Nature Active Experience (April - June / September - October) - Local Authentic Experience Culture (April - June / September - October) - Sea lovers (July - August) Day 01. Arrival. Tenuta Masseria ChiccoRizzo (Sternatìa) Pick up from the airport with private car or 9-seater van with driver. -
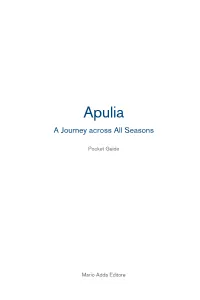
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Agenzie S.T.P. Di Terra D'otranto - S.P.A
Agenzie S.T.P. di Terra d'Otranto - S.p.A. - Lecce Ragione Sociale Indirizzo Comune ACQUARICA DEL CAPO - EMPORIO DEL TABACCO DI SALVATORE CASSIANO CORSO DANTE, 99/B Acquarica del Capo ALESSANO - CARTOLIBRERIA DIEMME DI AMICO DAVIDE PIAZZA DON TONINO BELLO, 4 - ALESSANO Alessano ALESSANO - CIARDO GIANLUIGI - RIV. TAB PIAZZA DON TONINO BELLO, 34 - ALESSANO Alessano ALESSANO - RIZZO MARIA FIORA - RIV. TAB. via rimembranze, 32 - ALESSANO Alessano ALEZIO - AMICO MARIA GRAZIA - EDICOLA & LIBRERIA VIA MARIANA ALBINA, 27 - ALEZIO Alezio ALEZIO - TABACCHERIA N? 2 BRAY ROSA VIA ROMA, 232 - ALEZIO Alezio ALLISTE - L'INCHIOSTRO DI RAINO' MILENA VIA G. GARIBALDI, 11 - ALLISTE Alliste ANDRANO - RIZZO "EDICOLA & CARTOLERIA" VIA XXV LUGLIO - ANDRANO Andrano ANDRANO - TABACCHI ACCOGLI LUIGI VIA NAPOLI 48 Andrano ARADEO - EDICART POINT DI MIGHALI ANDREA ANTONIO VIA TORINO, 102 - ARADEO Aradeo ARADEO - NOVAKARTO 2 DI BOVE COSIMA VIA MATTEOTTI, 64 - ARADEO Aradeo ARNESANO - MASTERMIND DI CENTONZE FRANCESCO VIA DELLA LIBERTA', 14 - ARNESANO Arnesano ARNESANO - QUARTA ANTONIO - RIV. TAB. VIA MONSIGNOR RAFFAELE PERRONE - ARNESANO Arnesano ARNESANO-PALLARA MARIA GRAZIA TAB-MEME' VIA INDENNITATE, 2 Arnesano AVETRANA - NIGRO ALESSANDRO - RIV. TAB. VIA ROMA, 16 - AVETRANA Avetrana AVETRANA - NIGRO DANIELE VIA A. DE GASPERI - AVETRANA Avetrana BARBARANO - TABACCHI RIZZELLO DI RIZZELLO MICHELE VIA DI MEZZO, 1/3 Morciano di Leuca BOTRUGNO - EDICART DI FRACASSO FRANCESCA VIA VITTORIO EMANUELE, 52 Botrugno BOTRUGNO - GARBO CARTOLERIA FEDELE FRANCO VIA GARIBALDI, 14 - BOTRUGNO Botrugno BOTRUGNO - PUNTO GIOCO - F.LLI GUGLIELMO SNC VIA ROMA, 70 Botrugno CAMERA DI COMMERCIO VIALE GALLIPOLI Lecce CAMPI SAL. - PALAZZO ANTONIO - EDICOLA PIAZZA LIBERTA', 23 - CAMPI SALENTINA Campi Salentina CARMIANO - BRUNO MARIA EMANUELA TAB. -

Lecce Nord - Elenco Piscine Autorizzate Al 31.12.2018
LECCE NORD - ELENCO PISCINE AUTORIZZATE AL 31.12.2018 DENOMINAZIONE SEDE CITTA' CATEGORIA GRUPPO TIPOLOGIA UTILIZZAZIONE SWEET PARADISE VIA PIGAFETTA 53 S.CATALDO LECCE A A-1 1 ICOS SPORTING CLUB VIA LUIGI EINAUDI 12 LECCE A A-2 2 TENUTA MONACELLI S.S.SQUINZANO-CASALABATE LECCE A A-2 1 R.T.A. PUNTA GROSSA -A PROV.LE x TARANTO KM.7 PORTO CESAREO A A-2 1 AEMME VIA DI USSANO 55 LECCE A A-2 2 BLU SALENTO VILLAGE VIA LEUCA - S.ISIDORO NARDO' A A-2 1 TENUTA CARADONNA S.S.101 LECCE-GALLIPOLI KM.8 LEQUILE A A-2 1 LIDO YORK S.CATALDO LECCE A A-2 1 I GIARDINI DI ATENA VIA MONTENEGRO MERINE LIZZANELLO A A-2 1 CLUB AZZURRO VIA COLLE AZZURRO PORTO CESAREO A A-2 1 CENTRO SPORTIVO PARADISE PROV.LE CARMIANO COPERTINO ARNESANO A A-1 2 AGRICOLA SAN GIOVANNI VIA PER AVETRANA-C.DA SAN GIOVANNI SALICE SALENTINO A A-2 1 ICOS SPORTING CLUB VIA TEVERE 14 SAN CESARIO DI LECCE A A-2 2 BELLARIA NUOTO PROV.TREPUZZI CASALABATE TREPUZZI A A-1 2 ARTHOTELE PARK C.BENESSERE VIA DE CHIRICO 1 LECCE A A-2 2 ARTHOTEL E PARK ALBERGO VIA DE CHIRICO 1 LECCE A A-2 1 AQUAPOOL SRL VIA A. PICCHI CALIMERA A A-1 2 CAMPEGGIO SENTINELLA VIA DEGLI EUCALIPTUS-TORRE DELL'ORSO MELENDUGNO A A-2 1 R.T.A. PUNTA GROSSA -B PROV.LE x TARANTO KM.7 PORTO CESAREO A A-2 1 CONDOMINIO BONCORE VILLAGGIO BONCORE NARDO' B B-1 1 R.T.A OASI SALENTO LUNGOM.MATTEOTTI ANG.V.PASCOLI MELENDUGNO A A-2 1 HILTON GARDEN INN VIA COSIMO DE GIORGI 62 LECCE A A-2 1 HOTEL LA BRUNESE C.DA SENTINELLA-TORRE DELL'ORSO MELENDUGNO A A-2 1 SAIRON CLUB SRL PROV.LE per MELENDUGNO-T.DELL'ORSO MELENDUGNO A A-2 1 SANGIORGIO RESORT & SPA PROV.LE NOHA COLLEPASSO CUTROFIANO A A-2 1 COSTA D'ORIENTE RESIDENCE VIA MICENE-TORRE SARACENA MELENDUGNO A A-2 1 HOTEL RESIDENCE PORTO SELVAGGIO C.DA SCIOGLI-TORRE INSERRAGLIO NARDO' A A-2 1 BARONE DI MARE TORRE SARACENA-TORRE DELL'ORSO MELENDUGNO A A-2 1 TENUTA SANTICUTI LITOR. -

Alezio Dintorni
Alezio Dintorni Localita vicine a Alezio Salento: mare vicino a Alezio Il Salento corrisponde alla parte sud della Puglia ed è generalmente conosciuta come il “Tacco d’Italia”. Il Salento sorge tra il Mar Adriatico e il Mar Ionio, ed è delimitato a nord dalla cosiddetta soglia messapica, una depressione del terreno che lo separa dalle Murge. La zona era conosciuta e abitata già all’epoca dei greci, che la chiamavano Messapia, dal popolo dei Messapi che l’abitava. Nei secoli successivi tutto il territorio salentino fu colpito da dure lotte per il suo possesso e nell’VIII secolo d.C. fu inglobato nei domini dei bizantini, che chiamarono la zona Terra d’Otranto. Oggi il Salento è uno dei distretti turistici più importanti del sud Italia, grazie alla bellezza del suo mare, alla bontà della sua cucina ed alla ricchezza di tradizioni popolari e culturali. Località posizionate sulla mappa A Gallipoli B Matino C Parabita D Sannicola E Tuglie Altre località Acquarica del Capo Alessano Alliste Andrano Aradeo Arnesano Avetrana Bagnolo del Salento Botrugno Brindisi Calimera Campi Salentina Cannole Caprarica di Lecce Carmiano Carosino Carovigno Carpignano Salentino Casarano Castri di Lecce Castrignano de' Greci Castro Cavallino Ceglie Messapica Cellino San Marco Collepasso Copertino Corigliano d'Otranto Corsano Cursi Cutrofiano Diso Erchie Faggiano Fragagnano Francavilla Fontana Gagliano del Capo Galatina Galatone Giuggianello Giurdignano Grottaglie Guagnano Latiano Lecce Leporano Lequile Leverano Lizzanello Lizzano Maglie Manduria Martano Martignano -

Allegato I Alla Parte Seconda Del D.Lgs
Comune di Gallipoli Piano Comunale delle Coste Premessa Autorità procedente e Autorità competente Elenco dei soggetti competenti in materiale ambientale 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 7 1.1 Normativa europea e nazionale di riferimento 1.2 Normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica 1.3 Normativa regionale in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale 2. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ PROCEDURALI 10 2.1 Finalità della verifica di assoggettabilità a VAS del PCC 2.2 Descrizione della procedura e della metodologia 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBITO DI INFLUENZA DEL PCC 12 3.1 Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico 3.1.1 Piani sovraordinati regionali 3.1.2 Piani sovraordinati di livello provinciale: PTCP 3.1.3 Piani sovraordinati locali: Piano Territoriale del Parco 3.1.4 Pianificazione Urbanistica: previsioni in ambito costiero del PRG di Gallipoli 3.2 Ambito di influenza del PCC e criteri adottati per delimitare l’ambito di studio 3.3 Criteri di sostenibilità ambientale 4. INQUADRAMENTO DEL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E TERRITORIALE 29 4.1 La figura territoriale del PPTR: le Serre Joniche 4.1.1 Struttura e componenti territoriali: fattori di rischio e vulnerabilità ambientale 4.2 La piana di Alezio 4.2.1 Descrizione strutturale 5. LA FASCIA COSTIERA DI GALLIPOLI: ANALISI DI CONTESTO 34 5.1 Sistema delle componenti paesaggistiche e ambientali del paesaggio costiero 5.2 Componenti geomorfologiche 5.2.1 Caratteri fisiografici della costa: morfotipi costieri 5.2.2 Ambienti dunali 5.3 Componenti idrologiche 5.3.1 Sistema idrografico: corsi d’acqua e reti di bonifica 5.3.2 Ambienti umidi retrodunali 5.4 Componenti botanico vegetazionali 5.4.1 Caratteri ecosistemici 5.4.2 Sistema spiaggia-duna-macchia/pineta-aree umide retrodunali 5.4.3 Habitat terrestri A. -

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI PROVINCIA DI LECCE Comuni Di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie
Copia AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI PROVINCIA DI LECCE Comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie DETERMINA n. 51 del 22 febbraio 2018 Oggetto: Punti di accesso e Rete dei servizi gratuiti di supporto tecnico/informativo ai cittadini interessati al sostegno economico REI (Reddito di Inclusione) e ReO (Reddito di Dignità) - Presa d'atto delle convenzioni sottoscritte dall'Ambito con CAF e Patronati - Modalità di rendicontazione della spesa. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIA O Premes o che: - in qualità di Responsabile dell'Umcio di Piano, titolare di P.O., lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; - salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione. rispetto all'adozione del presente atto. Dato atto che il Consiglio Comunale: con deliberazione n. 13 del 31 marzo 20 17, esecutiva ai sensi di legge. ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017-2019; con deliberazione n. 14 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge. ha approvato il bilancio di previsione finanziario 20 17-20 19, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011; con deliberazione n. 32 del 31 luglio 2017. esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs n. -

Proposal for a Thematic Itinerary on Geomorphological Sites Along the Western Coast of the Salento Peninsula, Southern Italy
Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 18(1), 2005 - Volume Speciale, 115-123 PROPOSAL FOR A THEMATIC ITINERARY ON GEOMORPHOLOGICAL SITES ALONG THE WESTERN COAST OF THE SALENTO PENINSULA, SOUTHERN ITALY Giovanni Palmentola1 & Maurizio Lazzari2 1Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Geologia e Geofisica, Via Orabona 4, Bari [email protected] 2C.N.R.- I.B.A.M., Sezione di Lagopesole, Via Federico II, 85020 Lagopesole (PZ) [email protected] ABSTRACT: G. Palmentola & M. Lazzari, Proposal for a thematic itinerary on geomorphological sites along the western coast of the Salento peninsula, southern Italy. (IT ISNN 0394-3356, 2005). Researches carried out on the Quaternary coastline modifications along the western Salento Peninsula of Apulia, permitted to survey a succession of well-preserved geomorphological sites. These sites testify the events which interested the studied coastal sector during the Quaternary time from mid-late Pleistocene (MIS 9?) to Holocene (MIS 1). The coastal sector of great landscape value, along which geomorphosites are exposed, is wide some kilometres from Gallipoli town toward north as far as the Punta d’Alto Lido promon- tory (locally known as the “broken mountain”). In particular, a series of landforms is exposed there, shaped by the sea and by sessile organisms which live along the sea cliffs, as well as by aeolian accumulation and deflation landforms. The variety of well-preserved and easy accessible landforms and their concentration in a not wide coastal sector constitute a good opportunity for both didactic and popularization of the processes which characterize the coastal dynamics, as well as the relative diagnostic elements.