Gabriella Tassinari
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Philipp Von Stosch (1691–1757) and the Study of Engraved Gems Paweł Gołyzniaḱ *
Antiquity 2021 page 1 of 9 https://doi.org/10.15184/aqy.2021.112 Project Gallery From antiquarianism to proto-archaeology: Philipp von Stosch (1691–1757) and the study of engraved gems Paweł Gołyzniaḱ * * Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Poland (✉ [email protected]) Examination of Philipp von Stosch’s documentation of engraved gems, discovered in previously unknown archival sources in the Princes Czartoryski Museum in Krakow and other public and private collections, considerably advances our understanding of the move from antiquarianism to proto-archaeology in the eighteenth century. Keywords: antiquarianism, proto-archaeology, archiving, engraved gems, history of archaeology, Philipp von Stosch Introduction Philipp von Stosch (1691–1757) (Figure 1) is regarded as one of the most instrumental figures in eighteenth-century antiquarianism (Hansson 2014). While previous research has focused on his life and role as a collector (Lewis 1967; Zazoff & Zazoff 1983:3–67), the production of his outstanding book on gems (signed by ancient masters and published in 1724 (Heringa 1976; Zazoff & Zazoff 1983:24–50; Whiteley 1999)) and his collection of engraved gems published by Winckelmann in 1760 (Borbein et al. 2019), his other con- tributions to academia have been overlooked. This article considers his skill in building and managing collections and, perhaps most importantly, his collaboration with numerous artists who produced drawings apparently intended as illustrations for his virtually unrecognised scholarly projects. The Stosch Project An extensive collection of unpublished drawings of engraved gems discovered in the Princes Czartoryski Museum in Krakow provided an opportunity to explore Stosch’s scholarly activ- ities. The drawings record small objects made of precious stones used in antiquity as seals, amulets or as personal adornments. -
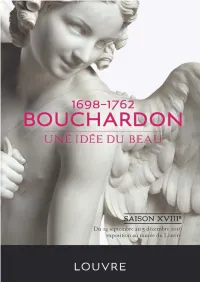
DP Louvre Edme Bouchardon.Pub
Dossier de presse Exposition Du 14 septembre au 5 décembre 2016 Hall Napoléon Bouchardon (1698-1762) Une idée du beau Contact presse Coralie James [email protected] Tél. 01 40 20 54 44 1 Sommaire Communiqué de presse page 3 Préface page 5 par Jean–Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre et Timothy Potts, directeur du J. Paul Getty Museum Parcours de l’exposition page 7 Regards sur quelques œuvres page 12 Autour de l’exposition page 16 Publications, manifestations à l’auditorium du Louvre, visites-conférences, atelier, guide multimédia... Visuels disponibles pour la presse page 19 Lettres du mécène page 24 La liste complète des œuvres exposées est disponible sur demande : [email protected] 2 Bouchardon (1698-1762) Une idée du beau Communiqué de presse Le musée du Louvre et le J. Paul Getty Museum de Los Angeles Exposition rendent hommage à Edme Bouchardon, sculpteur et dessinateur 14 septembre - 5 décembre de renom, qui fut considéré dès son époque comme « le plus 2016 grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son siècle » (Cochin). Cité dans l’Encyclopédie comme le continuateur de Puget et de Girardon, Bouchardon fut perçu par ses contemporains comme le promoteur du renouveau dans les arts. Alors que de nombreuses études ont favorisé une nouvelle approche du néo-classicisme, cette première exposition monographique d’envergure permet d’appréhender l’esthétique du sculpteur, parfait équilibre entre la référence antique et la fidélité à la nature. Fils d’architecte sculpteur, Edme Bouchardon se forma à l’Académie royale de peinture et de sculpture à Paris avant de faire un fécond séjour à l’Académie de France à Rome (1723-1732), couronné par des projets soumis au pape et par son élection à l’Académie de Saint-Luc. -

Etruscan News 19
Volume 19 Winter 2017 Vulci - A year of excavation New treasures from the Necropolis of Poggio Mengarelli by Carlo Casi InnovativeInnovative TechnologiesTechnologies The inheritance of power: reveal the inscription King’s sceptres and the on the Stele di Vicchio infant princes of Spoleto, by P. Gregory Warden by P. Gregory Warden Umbria The Stele di Vicchio is beginning to by Joachim Weidig and Nicola Bruni reveal its secrets. Now securely identi- fied as a sacred text, it is the third 700 BC: Spoleto was the center of longest after the Liber Linteus and the Top, the “Tomba della Truccatrice,” her cosmetics still in jars at left. an Umbrian kingdom, as suggested by Capua Tile, and the earliest of the three, Bottom, a warrior’s iron and bronze short spear with a coiled handle. the new finds from the Orientalizing securely dated to the end of the 6th cen- necropolis of Piazza d’Armi that was tury BCE. It is also the only one of the It all started in January 2016 when even the heavy stone cap of the chamber partially excavated between 2008 and three with a precise archaeological con- the guards of the park, during the usual cover. The robbers were probably dis- 2011 by the Soprintendenza text, since it was placed in the founda- inspections, noticed a new hole made by turbed during their work by the frequent Archeologia dell’Umbria. The finds tions of the late Archaic temple at the grave robbers the night before. nightly rounds of the armed park guards, were processed and analysed by a team sanctuary of Poggio Colla (Vicchio di Strangely the clandestine excavation but they did have time to violate two of German and Italian researchers that Mugello, Firenze). -

The Second Glance. All Forms of Love
All Forms ART OF ANTIQUITY AND of Love ENLIGHTENED COLLECTING Path 3 – Male homosexual collectors are the focus of the third path 1 2 François Duquesnoy (1597–1643) Edmé Bouchardon (1698–1762) Antinous Belvedere, first half of the 17th c. Baron Phlipp von Stosch, 1727 Bronze, 31,5 x 13,5 x 9 cm Marble, 85 x 65 x 34 cm Inv. Nr. 1/94 Inv. Nr. M 204, Property of the Kaiser Friedrich Museumsverein © Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst © Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin / Jörg P. Anders and Antje Voigt der Staatlichen Museen zu Berlin / Jörg P. Anders Unlike in the Christian societies of of both an intellectual and sexual of the temples that were dedicated the Middle Ages and the early mod- nature. The publicly celebrated love to the emperor. In addition, he had ern period, which judged homosex- of the Roman emperor Hadrian (76– Antinous’ image reproduced hun- uality as unnatural, in antiquity same- 138 AD) for the young Antinous dreds of times, whether chiselled in sex love (between men) met with (ca. 110–130 AD) is legendary: after stone, cast in bronze, or minted on greater tolerance and sometimes the latter drowned under tragic coins. In later centuries these images even approval. This was especially circumstances during a boating of Antinous were in high demand true for friendships between young excursion on the Nile, Hadrian had among collectors and lovers of fine men and older mentors, which were his lover venerated as a god in several art, particularly in the 18th century, 19 THE SECOND GLANCE PATH 3 ART OF ANTIQUITY AND ENLIGHTENED COLLECTING when the excavations of the ancient homoerotic friendship. -

Press Release
NEWS FROM THE GETTY news.getty.edu | [email protected] DATE: January 6, 2016 MEDIA CONTACT FOR IMMEDIATE RELEASE Amy Hood Getty Communications (310) 440-6427 [email protected] J. PAUL GETTY MUSEUM PRESENTS FIRST MAJOR EXHIBITION ON RENOWNED 18TH-CENTURY ARTIST EDME BOUCHARDON Exhibition includes more than 30 sculptures and 100 drawings and prints by the famed Royal artist and is the first major museum examination of his work BOUCHARDON: ROYAL ARTIST OF THE ENLIGHTENMENT on view at the J. Paul Getty Museum, Getty Center, Los Angeles January 10 – April 2, 2017 Special Installation of Bouchardon’s masterwork The Sleeping Faun now on view in the Getty Museum’s Entrance Hall Los Angeles – One of the most imaginative and celebrated artists of the eighteenth century, Edme Bouchardon (French, 1698-1762) was both an exceptionally accomplished sculptor and astonishingly talented draftsman. A new exhibition on view at the Getty Museum from January 10 through April 2, 2017 – Bouchardon: Royal Artist of the Enlightenment – will present the first comprehensive survey devoted to this extraordinarily important, but not well-known artist. Organized in partnership with the Musée du Louvre in Paris, the exhibition was on view there from September 12 to December 5, 2016. At the Getty the show will include more than 150 works, including sculptures, drawings, prints, and medals designed by Bouchardon. In advance of the opening date, one of Bouchardon’s masterworks, The Sleeping Faun, has been installed in the Getty Museum’s Entrance Hall where it will be on view through the run of the exhibition. “Bouchardon’s astounding skill in carving marble and his brilliantly realized drawings, marveled at in his own time, remain just as captivating today,” says Timothy Potts, director The Sleeping Faun, 1726–30, Edme Bouchardon, French, 1698–1762 Marble H: 184 X W: 142.5 X D: of the J. -
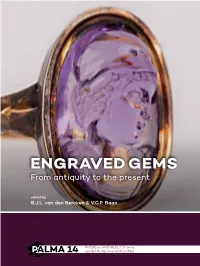
Engraved Gems
& Baan (eds) & Baan Bercken den Van ENGRAVED GEMS Many are no larger than a fingertip. They are engraved with symbols, magic spells and images of gods, animals and emperors. These stones were used for various purposes. The earliest ones served as seals for making impressions in soft materials. Later engraved gems were worn or carried as personal ornaments – usually rings, but sometimes talismans or amulets. The exquisite engraved designs were thought to imbue the gems with special powers. For example, the gods and rituals depicted on cylinder seals from Mesopotamia were thought to protect property and to lend force to agreements marked with the seals. This edited volume discusses some of the finest and most exceptional GEMS ENGRAVED precious and semi-precious stones from the collection of the Dutch National Museum of Antiquities – more than 5.800 engraved gems from the ancient Near East, Egypt, the classical world, renaissance and 17th- 20th centuries – and other special collections throughout Europe. Meet the people behind engraved gems: gem engravers, the people that used the gems, the people that re-used them and above all the gem collectors. This is the first major publication on engraved gems in the collection of the National Museum of Antiquities in Leiden since 1978. ENGRAVED GEMS From antiquity to the present edited by B.J.L. van den Bercken & V.C.P. Baan 14 ISBNSidestone 978-90-8890-505-6 Press Sidestone ISBN: 978-90-8890-505-6 PAPERS ON ARCHAEOLOGY OF THE LEIDEN MUSEUM OF ANTIQUITIES 9 789088 905056 PALMA 14 This is an Open Access publication. -

Fameux Amateur Baron Philipp Von Stosch and the Unknown Provenance of Lost Old Masters' Drawings from the Collection of Count
Fameux amateur A P Baron Philipp von Stosch FAMEUX AMATEUR BARON PHILIPP VON STOSCH AND THE UNKNOWN PROVENANCE OF LOST OLD MASTERS’ DRAWINGS FROM THE COLLECTION OF COUNT STANISŁAW KOSTKA POTOCKI Although a rich literature exists that is dedicated to activities of the collector Stanisław Kostka Potocki, the history of the shaping of his collection of drawings has not yet been analyzed, and in specif- ic the origins of individual copies that entered his collection remain unstudied.1 Relations between the count’s collection and that of Baron Philipp von Stosch remain even less known to this day.2 The lat- Polish Libraries 2018 Vol. 6 1 Very general information on this subject can be found in the work by Zygmunt Batows- ki Zbiór graficzny w Uniwersytecie Warszawskim, Warsaw 1928, p. 42. Even in exhibition catalogues, it is rare to mention where individual drawings originate from, for exam- ple: Le siècle français : francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich, eds. Iwona Danielewicz and Justyna Guze, Warsaw 2009, p. 421, item 125. 2 To date, this has been mentioned only once, by Elżbieta Skierkowska, who, however, provided inaccurate information (see: Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku, Warsaw 1980, pp. 103, 110). Currently, we have been able to refine and correct data on the origin of some of these drawings, which will be discussed later in this article. 115 est archival research carried out at the National Library of Poland in Warsaw’s department of engravings and drawings, followed by work on the catalogue of the graphic-art collection of the Wilanów Library, have shown that twenty-six valuable drawings, originally belonging to Philipp von Stosch’s collection, were among purchases made by Potocki, including works by Raphael, Michelangelo, Correggio, Par- Baron Philipp von Stosch migianino, Annibale and Lodovico Carracci and Rubens. -

Cat Talogu E 58
Grosvenor Prints 19 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JN Tel: 020 7836 1979 Fax: 020 7379 6695 E-mail: [email protected] www.grosvenorprints.com Dealers in Antique Prints & Books Catalogue 58 Item 50: Edward Julius Detmold The Captive All items listed are illustrated on our web site: www.grosvenorprints.com Registered in England No. 1305630 Registered Office: 2, Castle Business Villlage, Station Roaad, Hampton, Middlesex. TW12 2BX. Rainbrook Ltd. Directors: N.C. Talbot. T.D.M. Rayment. C.E. Elliis. E&OE VAT No. 217 6907 49 1. [Woman holding a bird and cherries] After Adam Buck (1759 - 1833), draughtsman and Sunt Oculi Scopuli, quos parat illa Venus specialist in watercolours. E. Back a H. sc. Jeremias Wolff excud . Aug. Vind. Stock: 40031 Engraving, platemark 300 x 190mm (11¾ x 7½") very large margins. £160 6. [Adrian von Seumenicht] Hadrianus, a One of a series of engravings by Augsburg printmaker Minsicht, Germanus, Com: Pal: Phil: Et Med: Jeremias Wolff after Elias Bäck (1679-1747), also of D: P.L. Caes: Nec Non Diver: S.R. Prin. Consil Augsburg. Et Arch: Stock: 40173 D. Diricksen Hamburg sculpt [in image] [n.d., c.1685.] Rare engraving, sheet 175 x 130mm (7 x 5"). Trimmed 2. [Sleeping woman] ____praestat si talia and glued to album sheet. £160 somnus, Blandimenta vigil quae dare posse Adrien von Seumenicht (1588-1638), alchemist best putas? known for his work 'Aureum Saeculum Redivivum' E. Back a H. sc. Jeremias Wolff excud . Aug. Vind. (The Golden Age Restored). In an oval frame Engraving, platemark 300 x 190mm (11¾ x 7½") very surrounded by alchemical and mathematical large margins. -

Bild Und Schrift Auf ‚Magischen' Artefakten
Bild und Schrift auf ‚magischen‘ Artefakten Materiale Textkulturen Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 933 Herausgegeben von Ludger Lieb Wissenschaftlicher Beirat: Jan Christina Gertz, Markus Hilgert, Hanna Liss, Bernd Schneidmüller, Melanie Trede und Christian Witschel Band 19 Bild und Schrift auf ‚magischen‘ Artefakten Herausgegeben von Sarah Kiyanrad, Christoffer Theis und Laura Willer ISBN 978-3-11-060162-6 e-ISBN (PDF) 978-3-11-060433-7 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-060492-4 ISSN 2198-6932 Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International Licence. Weitere Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2018941194 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2018 Kiyanrad et al., publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Dieses Buch ist als Open-Access-Publikation verfügbar über www.degruyter.com. Einbandabbildung: P. Heid. Inv. Kopt. 679 © Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg, Foto: Elke Fuchs Satz: Sonderforschungsbereich 933 (Jessica Dreschert), Heidelberg Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Vorwort Der vorliegende Band beinhaltet Beiträge, die auf einem interdisziplinären Workshop des Sonderforschungsbereichs 933 Materiale Textkulturen – Materialität und Präsenz des Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften an der Ruprecht-Karls-Uni- versität Heidelberg am 19. Juli 2013 am Ägyptologischen Institut vorgestellt wurden. Ausgerichtet wurde der Workshop mit dem Titel „Methodische Reflexionen zum Spannungsverhältnis zwischen magischem Text und Bild“ von den MitarbeiterInnen des Teilprojekts A03 „Materialität und Präsenz magischer Zeichen zwischen Antike und Mittelalter“ Sarah Kiyanrad, Christoffer Theis und Laura Willer. -

Pegasus Berliner Beiträge Zum Nachleben Der Antike Heft 8 · 2006
pegasus Berliner Beiträge zum Nachleben der Antike Heft 8 · 2006 Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Humboldt-Universität zu Berlin www.census.de /pegasus.htm Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Humboldt-Universität zu Berlin Herausgeber: Horst Bredekamp, Arnold Nesselrath Redaktion: Charlotte Schreiter, Anne Leicht, Frederike Steinhoff Kunstgeschichtliches Seminar Unter den Linden 6 10099 Berlin © 2006 Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Layout und Satz: Jürgen Brinckmann, Berlin Druck: Gulde Druck GmbH, Tübingen ISSN 1436-3461 the codex stosch: surveys of ancient buildings by giovanni battista da sangallo ian campbell and arnold nesselrath preamble* In March 2005, the Edinburgh auction house, Lyon and Turnbull, consulted the authors about an album of drawings of ancient Roman buildings. Within days, it was established that, in the eighteenth century, the drawings had be- longed to Philipp von Stosch and were thought to be Raphael’s lost reconstruc- tion of ancient Rome, but that, in fact, the draughtsman was Giovanni Battista da Sangallo. One of the present authors prepared a descriptive catalogue for the sale of the album, given the name the »Codex Stosch«, in July 2005. The present article goes beyond that catalogue and tries to answer outstanding questions about the dating of the drawings, their purpose, and their relation- ship, if any, with Raphael and other draughtsmen of his period. We begin with a short description of the volume, which was acquired by the RIBA British Archi tectural Library in May 2006.1 description The vellum binding, which certainly dates after 1706, and probably from around 1760, on the evidence of the endpapers,2 contains 23 folios, all roughly 278 × 210 mm in size, of which only folio 3, 4 and 17 are single sheets, the rest making up ten bifolia. -

Avvertenze Al Catalogo
Avvertenze al catalogo: Le diciture delle biblioteche sono state abbreviate secondo le seguenti norme: Pd BU : Padova Biblioteca Universitaria Ts BC: Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis Ve BMC: Venezia, Biblioteca del Museo Correr Ve BM: Venezia, Biblioteca Marciana Ve FGC: Venezia, Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini Vi BCB: Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana Tra parentesi quadre si sono indicate le misure delle incisioni, le iscrizioni e le indicazioni di responsabilità. Catalogo Il Seicento N. cat.: 1 Autore: Panvinio Onofrio (Verona 1530-Palermo 1568) Titolo: ONVPHRII/ PANVINII/ VERONENSIS,/ DE LVDIS CIRCENCIBVS, LIBRI II./ DE TRIUMPHIS, LIBER VNVS./ Quibus vniversa ferè/ ROMANORVM VETERVM/ SACRA RITVSQ. DECLARANTVR,/ ac Figuris Aeneis Illustrantur./ AD SERENISSIMVM/ FRANCISCVM MARIAM/ Secundum Vrbini Ducem Sextum./ Cum rerum memorabilium Indice copiosissimo./ VENETIIS, Apud Ioannem Baptistam Ciottum/ Senesem. M.DC. Superiorum permissu.// Formato: 37 x 25 cm Volume: 1 vol. Luogo di pubblicazione: Venezia Editore o stampatore: Giovanni Battista Ciotti Anno di pubblicazione: 1600 Dedica: Descrizione: Per la descrizione delle incisioni del frontespizio (fig. 1a) e delle tavole, cfr. la scheda dell’edizione veneziana del 1642 (cat. 11). Note: L’apparato iconografico è realizzato da Onofrio Panvinio e da Étienne Dupérac, ma compaiono anche copie e rifacimenti da disegni di Pirro Ligorio. Nel testo sono inserite calcografie raffiguranti rilievi, piante, vedute a volo d’uccello del Circo Massimo, del Circo Variano di Roma e dell’Ippodromo di Costantinopoli, e di altri edifici in cui, nell’antichità, si svolgevano degli spettacoli come teatri e anfiteatri. Oltre alla numerosa serie di architetture, nelle tavole piegate e inserite all’interno del testo, sono riprodotti anche reperti archeologici come fronti di sarcofagi e rovesci di monete raffiguranti le gare, le cerimonie e i riti che si svolgevano in questi luoghi. -
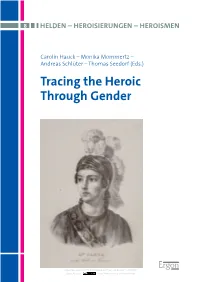
Tracing the Heroic Through Gender Tracing the Heroic Tracing Through Gender Through
8 8 HELDEN – HEROISIERUNGEN – HEROISMEN Carolin Hauck – Monika Mommertz – Andreas Schlüter – Thomas Seedorf (Eds.) Tracing the Heroic Through Gender Tracing the Heroic Tracing Through Gender Through BAND 8 Carolin Hauck – Monika Mommertz – Hauck – Monika Carolin SeedorfThomas (Eds.) – Schlüter Andreas ISBN 978-3-95650-402-0 https://doi.org/10.5771/9783956504037, am 29.09.2021, 20:09:05 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Tracing the Heroic Through Gender Edited by Carolin Hauck – Monika Mommertz – Andreas Schlüter – Thomas Seedorf https://doi.org/10.5771/9783956504037, am 29.09.2021, 20:09:05 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb HELDEN – HEROISIERUNGEN – HEROISMEN Herausgegeben von Ronald G. Asch, Barbara Korte, Ralf von den Hoff im Auftrag des DFG-Sonderforschungsbereichs 948 an der Universität Freiburg Band 8 ERGON VERLAG https://doi.org/10.5771/9783956504037, am 29.09.2021, 20:09:05 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Tracing the Heroic Through Gender Edited by Carolin Hauck – Monika Mommertz – Andreas Schlüter – Thomas Seedorf ERGON VERLAG https://doi.org/10.5771/9783956504037, am 29.09.2021, 20:09:05 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft Cover: Mezzo Soprano Giuditta Pasta (1798–1865) in the title role of Gioachino Rossini’s opera Tancredi (1822), Lithograph by Cäcilie Brand, n.d. © Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: Portr. II 4023 (A 15982) Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Ergon – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.