Camillo Togni, Un'intervista a Cura Di Marcella Mandanici
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Rai Studio Di Fonologia (1954–83)
ELECTRONIC MUSIC HISTORY THROUGH THE EVERYDAY: THE RAI STUDIO DI FONOLOGIA (1954–83) Joanna Evelyn Helms A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music. Chapel Hill 2020 Approved by: Andrea F. Bohlman Mark Evan Bonds Tim Carter Mark Katz Lee Weisert © 2020 Joanna Evelyn Helms ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Joanna Evelyn Helms: Electronic Music History through the Everyday: The RAI Studio di Fonologia (1954–83) (Under the direction of Andrea F. Bohlman) My dissertation analyzes cultural production at the Studio di Fonologia (SdF), an electronic music studio operated by Italian state media network Radiotelevisione Italiana (RAI) in Milan from 1955 to 1983. At the SdF, composers produced music and sound effects for radio dramas, television documentaries, stage and film operas, and musical works for concert audiences. Much research on the SdF centers on the art-music outputs of a select group of internationally prestigious Italian composers (namely Luciano Berio, Bruno Maderna, and Luigi Nono), offering limited windows into the social life, technological everyday, and collaborative discourse that characterized the institution during its nearly three decades of continuous operation. This preference reflects a larger trend within postwar electronic music histories to emphasize the production of a core group of intellectuals—mostly art-music composers—at a few key sites such as Paris, Cologne, and New York. Through close archival reading, I reconstruct the social conditions of work in the SdF, as well as ways in which changes in its output over time reflected changes in institutional priorities at RAI. -

Maestro D'arte E Di Vita
G IADA V IVIANI Maestro d’arte e di vita. Modelli e percorsi della riflessione teorica di Camillo Togni su Arnold Schönberg roverbiale è la strenua ricerca d’ordine condotta per tutta la vita da Camillo Togni, impostagli, secondo le sue stesse ricostruzioni a posteriori, dalla ferrea disciplina cui Pdall’età di tredici anni si era dovuto sottoporre per riuscire a convivere con il «bleicher Geselle» («pallido compagno») del diabete, ossia con il memento mori che, a partire dalla diagnosi dei medici, avrebbe pungolato la sua intera attività artistica e intellettuale. 1 In alcune dichiarazioni rilasciate tra gli anni ’80 e ’90, il compositore fa infatti coincidere con l’inizio della malattia – o meglio, della cura – la propria svolta decisiva verso quell’ideale di impegno e rigore che ne permeerà tanto l’esistenza quanto l’espressione arti- stica, incarnandosi sul piano della scrittura musicale in un’adesione assoluta, seppur mai acritica, al metodo della composizione seriale: Una disciplina ferrea richiesta dalla mia sopravvivenza di giorno in giorno e l’assiduità con cui perseguivo la cura insulinica l’ho applicata alla serie. Mi ero forgiato un metodo. Questo biograficamente è vero, perché io ho cominciato a studiare sul serio, anche a scuola, proprio allora. Il modo di curarmi mi ha insegnato una certa disciplina.2 Al di là dell’interesse aneddotico di simili affermazioni, costituisce un dato essen- ziale per l’esegesi togniana la sua personale concezione del «metodo compositivo dodecafo- nico» come «l’unico ausilio […] per un musicista dei nostri tempi per mettere in ordine le proprie idee», la quale, formulata già nel 1951 in una lettera indirizzata al compositore svedese Bengt Hambraeus,3 ha rappresentato per tutta la sua vita una costante cruciale del pensiero del compositore. -
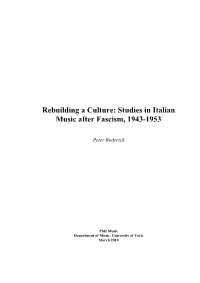
Thesis Submission
Rebuilding a Culture: Studies in Italian Music after Fascism, 1943-1953 Peter Roderick PhD Music Department of Music, University of York March 2010 Abstract The devastation enacted on the Italian nation by Mussolini’s ventennio and the Second World War had cultural as well as political effects. Combined with the fading careers of the leading generazione dell’ottanta composers (Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero and Ildebrando Pizzetti), it led to a historical moment of perceived crisis and artistic vulnerability within Italian contemporary music. Yet by 1953, dodecaphony had swept the artistic establishment, musical theatre was beginning a renaissance, Italian composers featured prominently at the Darmstadt Ferienkurse , Milan was a pioneering frontier for electronic composition, and contemporary music journals and concerts had become major cultural loci. What happened to effect these monumental stylistic and historical transitions? In addressing this question, this thesis provides a series of studies on music and the politics of musical culture in this ten-year period. It charts Italy’s musical journey from the cultural destruction of the post-war period to its role in the early fifties within the meteoric international rise of the avant-garde artist as institutionally and governmentally-endorsed superman. Integrating stylistic and aesthetic analysis within a historicist framework, its chapters deal with topics such as the collective memory of fascism, internationalism, anti- fascist reaction, the appropriation of serialist aesthetics, the nature of Italian modernism in the ‘aftermath’, the Italian realist/formalist debates, the contradictory politics of musical ‘commitment’, and the growth of a ‘new-music’ culture. In demonstrating how the conflict of the Second World War and its diverse aftermath precipitated a pluralistic and increasingly avant-garde musical society in Italy, this study offers new insights into the transition between pre- and post-war modernist aesthetics and brings musicological focus onto an important but little-studied era. -

Ferienkurse Für Internationale Neue Musik, 25.8.-29.9. 1946
Ferienkurse für internationale neue Musik, 25.8.-29.9. 1946 Seminare der Fachgruppen: Dirigieren Carl Mathieu Lange Komposition Wolfgang Fortner (Hauptkurs) Hermann Heiß (Zusatzkurs) Kammermusik Fritz Straub (Hauptkurs) Kurt Redel (Zusatzkurs) Klavier Georg Kuhlmann (auch Zusatzkurs Kammermusik) Gesang Elisabeth Delseit Henny Wolff (Zusatzkurs) Violine Günter Kehr Opernregie Bruno Heyn Walter Jockisch Musikkritik Fred Hamel Gemeinsame Veranstaltungen und Vorträge: Den zweiten Teil dieser Übersicht bilden die Veranstaltungen der „Internationalen zeitgenössischen Musiktage“ (22.9.-29.9.), die zum Abschluß der Ferienkurse von der Stadt Darmstadt in Verbindung mit dem Landestheater Darmstadt, der „Neuen Darmstädter Sezession“ und dem Süddeutschen Rundfunk, Radio Frankfurt, durchgeführt wurden. Datum Veranstaltungstitel und Programm Interpreten Ort u. Zeit So., 25.8. Erste Schloßhof-Serenade Kst., 11.00 Ansprache: Bürgermeister Julius Reiber Conrad Beck Serenade für Flöte, Klarinette und Streichorchester des Landes- Streichorchester (1935) theaters Darmstadt, Ltg.: Carl Wolfgang Fortner Konzert für Streichorchester Mathieu Lange (1933) Solisten: Kurt Redel (Fl.), Michael Mayer (Klar.) Kst., 16.00 Erstes Schloß-Konzert mit neuer Kammermusik Ansprachen: Kultusminister F. Schramm, Oberbürger- meister Ludwig Metzger Lehrkräfte der Ferienkurse: Paul Hindemith Sonate für Klavier vierhändig Heinz Schröter, Georg Kuhl- (1938) mann (Kl.) Datum Veranstaltungstitel und Programm Interpreten Ort u. Zeit Hermann Heiß Sonate für Flöte und Klavier Kurt Redel (Fl.), Hermann Heiß (1944-45) (Kl.) Heinz Schröter Altdeutsches Liederspiel , II. Teil, Elisabeth Delseit (Sopr.), Heinz op. 4 Nr. 4-6 (1936-37) Schröter (Kl.) Wolfgang Fortner Sonatina für Klavier (1934) Georg Kuhlmann (Kl.) Igor Strawinsky Duo concertant für Violine und Günter Kehr (Vl.), Heinz Schrö- Klavier (1931-32) ter (Kl.) Mo., 26.8. Komponisten-Selbstporträts I: Helmut Degen Kst., 16.00 Kst., 19.00 Einführung zum Klavierabend Georg Kuhlmann Di., 27.8. -

AMS/SMT Indianapolis 2010: Abstracts
AMS_2010_full.pdf 1 9/11/2010 5:08:41 PM ASHGATE New Music Titles from Ashgate Publishing… Adrian Willaert and the Theory Music, Sound, and Silence of Interval Affect in Buffy the Vampire Slayer The Musica nova Madrigals and the Edited by Paul Attinello, Janet K. Halfyard Novel Theories of Zarlino and Vicentino and Vanessa Knights Timothy R. McKinney Ashgate Popular and Folk Music Series Includes 69 music examples Includes 20 b&w illustrations Aug 2010. 336 pgs. Hbk. 978-0-7546-6509-0 Feb 2010. 304 pgs. Pbk. 978-0-7546-6042-2 Changing the System: The Musical Ear: The Music of Christian Wolff Oral Tradition in the USA Edited by Stephen Chase and Philip Thomas Anne Dhu McLucas Includes 1 b&w illustration and 49 musical examples SEMPRE Studies in The Psychology of Music Aug 2010. 284 pgs. Hbk. 978-0-7546-6680-6 Includes 1 b&w illustration, 2 music examples and a CD Mar 2010. 218 pgs. Hbk. 978-0-7546-6396-6 Shostakovich in Dialogue Form, Imagery and Ideas in Quartets 1–7 Music and the Modern Judith Kuhn Condition: Investigating Includes 32 b&w illustrations and 99 musical examples Feb 2010. 314 pgs. Hbk. 978-0-7546-6406-2 the Boundaries Ljubica Ilic Harrison Birtwistle: Oct 2010. 140 pgs. Hbk. 978-1-4094-0761-4 C The Mask of Orpheus New Perspectives M Jonathan Cross Landmarks in Music Since 1950 on Marc-Antoine Charpentier Includes 10 b&w illustrations and 12 music examples Edited by Shirley Thompson Y Dec 2009. 196 pgs. Hbk. 978-0-7546-5383-7 Includes 2 color and 20 b&w illustrations and 37 music examples Apr 2010. -

Routledge Handbook to Luigi Nono and Musical Thought Confronting
This article was downloaded by: 10.3.98.104 On: 27 Sep 2021 Access details: subscription number Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: 5 Howick Place, London SW1P 1WG, UK Routledge Handbook to Luigi Nono and Musical Thought Jonathan Impett Confronting Modernism Publication details https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780429485732-4 Jonathan Impett Published online on: 19 Oct 2018 How to cite :- Jonathan Impett. 19 Oct 2018, Confronting Modernism from: Routledge Handbook to Luigi Nono and Musical Thought Routledge Accessed on: 27 Sep 2021 https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780429485732-4 PLEASE SCROLL DOWN FOR DOCUMENT Full terms and conditions of use: https://www.routledgehandbooks.com/legal-notices/terms This Document PDF may be used for research, teaching and private study purposes. Any substantial or systematic reproductions, re-distribution, re-selling, loan or sub-licensing, systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. The publisher does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The publisher shall not be liable for an loss, actions, claims, proceedings, demand or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material. 3 CONFRONTING MODERNISM Darmstadt The emergence of a language Tall, long, infinitely slim, he carried on his straight narrow shoulders a head likewise all length, which irresistibly made one think of that of some painting, still primitive, of the pre-renaissance, perhaps one of the familiar saints. -

Symposium & Übersicht 15. April.Indd
Folkwang Universität der Künste Fr_15. April 2011 | 10.00 bis 17.00 Uhr Kammermusiksaal 1971 - 2011: 40 Jahre elektroakustische Musik an Folkwang _Symposium zur elektroakustischen Musik in Deutschland und Europa Redaktion: Kommunikation & Medien, Folkwang Universität der Künste Folkwang Universität der Künste | Klemensborn 39 | D-45239 Essen | Tel. +49 (0) 201.49 03-0 | www.folkwang-uni.de Freitag, 15. April 2011 10:00 bis 17:00 Uhr (Kammermusiksaal), Eintritt frei 10:00 Uhr Begrüßung durch den Prorektor Prof. Michael Niesemann 10:15 Uhr Priv.-Doz. Dr. Stefan Drees (Essen / Rostock): Elektroakustische Musik an Folkwang: Tendenzen – Entwicklungen – Fragestellungen 11:00 Uhr Kaffeepause 11:30 Uhr Gottfried Michael Koenig: Zur Revision von »Projekt 2« 12:15 Uhr Prof. Dr. Elena Ungeheuer (Würzburg): Elektromusikalische Gestalten, Figuren und Skulpturen und ihre Gesten 13:00 Uhr Mittagspause 14:30 Uhr »Was machen die da eigentlich?« Prof. Dirk Reith (Essen) und Prof. Thomas Neuhaus (Essen) im Gespräch über die Elektronische Musik an Folkwang. Gesprächsleitung: Stefan Drees 15:30 Uhr Folkmar Hein (Berlin): Elektronische Musik ist kein Geigenunterricht, oder: Die Virulenz des »E« in der Musik 16:15 Uhr Prof. Dr. Christoph von Blumröder (Köln): Historische Praktiken elektroakustischer Klangprojektion 17:00 Uhr Ende Freitag, 15. April 2011 19:30 Uhr (Neue Aula): 40 Jahre elektroakustische Musik an Folkwang: Werke von Lehrenden und Alumni des ICEM Eintritt 5 Euro/3 Euro (ermäßigt) Anschließend Empfang im Foyer der Neuen Aula Samstag, 16. April 2011 10:00 bis 12:30 Uhr (Kammermusiksaal), Eintritt frei »Wo steht die elektroakustische Musik heute?« Roundtable mit Leitern von Studios und anderen Institutionen. Teilnehmer: Andre Bartetzki, Michael Beil, Frank Böhme, Achim Bornhöft, Ludger Brümmer, Orm Fin- nendahl, Thomas Neuhaus, Dirk Reith und Kilian Schwoon. -

Franco Margola (1908-1992)
FRANCO MARGOLA (1908-1992) “La semplicità ritrovata” Tavola rotonda e concerti dedicati alla figura del compositore 14 dicembre 2012 – Casa della Musica, Parma ore 10.30 –Tavola rotonda: ”Intorno a Franco Margola” ore 20.30 – Concerto: ”Franco Margola e la sua scuola” 15 dicembre 2012 –Auditorium del Carmine, Parma ore 10.30 – Lezione Concerto: ” Franco Margola e i suoi contemporanei” ore 20.30 – Concerto: ”La musica da camera di Franco Margola” 16 dicembre 2012 –Auditorium Paganini, Parma Ore 18 – Concerto per solisti e orchestra CASA DELLA MUSICA Venerdì 14 dicembre 2012 - ore 10 -17 Intorno a Franco Margola Ore 10 Saluti Prof. Marco Capra Presidente della Casa della Musica Prof. Avv. Andrea Mora Presidente del Conservatorio di Parma M° Roberto Cappello Direttore del Conservatorio di Parma Esecuzione brano Diploma Composizione (1955) [**] Emma Parmigiani, violino Pierpaolo Maurizzi, pianoforte Ore 10.30 Intorno a Franco Margola Moderatore M° Andrea Talmelli M° Andrea Talmelli Il musicista Franco Margola e il suo insegnamento M° Azio Corghi Parma 1976-78: il mio ‘dopo-Margola’ nella sua classe di composizione Prof. Ottavio De Carli Caratteri salienti della figura di Margola come uomo e come musicista Dott.ssa Raffaella Nardella Il carteggio con Ildebrando Pizzetti presso il Conservatorio di Parma Prof Gian Paolo Minardi I rapporti con A. Benedetti Michelangeli e Camillo Togni M° Michele Ballarini Intorno alla discografia di Margola In collaborazione con la Casa della Musica CASA DELLA MUSICA Venerdì 14 dicembre 2012 - ore 20,30 Franco -

Tradición Y Modernidad En La Música Serial De Bruno Maderna (1920-1973) Una Aproximación a Su Producción De Los Años Cincuenta Daniel Moro Vallina
Tradición y modernidad en la música serial de Bruno Maderna (1920-1973) Una aproximación a su producción de los años cincuenta Tradition and Modernity in the Serial Music of Bruno Maderna (1920-1973) An overview about his works in the 1950s Daniel Moro Vallina El autor del presente artículo es beneficiario de una ayuda del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) concedida en 2010 por el Ministerio de Educación español. Asimismo, pertenece al Proyecto de Investigación Música y cultura en España en el siglo XX. Discursos sonoros y diálogos con Latinoamérica (HAR2012-33414), coordinado por la Universidad de Oviedo. Tradición y modernidad en la música serial de Bruno Maderna (1920-1973) Una aproximación a su producción de los años cincuenta Daniel Moro Vallina Proponemos un acercamiento a la We propose an approach to the figura del compositor veneciano Bruno Venetian composer Bruno Maderna, Maderna, uno de los mayores one of the leading figures of European exponentes de la vanguardia avant-garde, along with Pierre Boulez, centroeuropea junto con Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen and Luigi Nono. Karlheinz Stockhausen y Luigi Nono. Although the methods of composing Aunque los métodos compositivos que Maderna developed during the 1950s Maderna desarrolló durante la década share a structuralist approach of de 1950 comparten el enfoque integral serialism, his link to musical estructuralista propio del serialismo tradition, both academic and popular, integral, su vínculo con la tradición and the importance he gave to the musical –tanto culta como popular– y la communicative factor of music shift him importancia que concedía al factor away from the aesthetic abstraction comunicativo de la música lo alejan de and ultra-determinism that were la abstracción y el ultra-determinismo characteristic of the cultural climate at que caracterizó el clima cultural de the Darmstadt seminars. -

Front Matter
Cambridge University Press 978-1-107-03329-0 - New Music at Darmstadt: Nono, Stockhausen, Cage, and Boulez Martin Iddon Frontmatter More information New Music at Darmstadt New Music at Darmstadt explores the rise and fall of the so-called ‘Darmstadt School’, through a wealth of primary sources and analytical commentary. Martin Iddon’s book examines the creation of the Darmstadt New Music Courses and the slow development and subsequent collapse of the idea of the Darmstadt School, showing how participants in the West German new music scene, including Herbert Eimert and a range of journalistic commentators, created an image of a coherent entity, despite the very diverse range of compositional practices on display at the courses. The book also explores the collapse of the seeming collegiality of the Darmstadt composers, which crystallised around the arrival there in 1958 of the most famous, and notorious, of all post-war composers, John Cage, an event that, Carl Dahlhaus opined, ‘swept across the European avant-garde like a natural disaster’. MARTIN IDDON is Associate Professor of Music at the University of Leeds. He previously lectured at University College Cork and Lancaster University, and studied composition and musicology at the universities of Durham and Cambridge. His musicological research largely focusses on post-war music in Germany and the United States of America, and has been published in numerous leading journals, including Musical Quarterly, twentieth-century music,andContemporary Music Review.His music has been performed in Europe, North America, and Australasia, and has been featured on BBC Radio 3, Radio New Zealand, and the Österreichischer Rundfunk. -

By Camillo Togni*
Character and Form by Way of Integral Serialism: An Analysis of Fantasia concertante (1957) by Camillo Togni* Christoph Neidhöfer McGill University, Montreal From its early adoption of twelve-tone technique in the 1940s until the mid 1950s the music of Camillo Togni (1922–1993) maintained a strong stylistic a!nity with the sound world of the Second Viennese School, particularly with the works of Schoenberg. As was typical for the music of many composers of Togni’s generation, the continuous expansion in the 1950s of serial technique into various dimensions beyond pitch led to a gradual severing of stylistic ties with the Viennese composers. Whereas works such as Togni’s Sonata for "ute and piano from 1953 and the Sonata for violin and piano from 1954–1955, both of which subject pitch and rhythm to serial treatment, still largely use phrase structures modelled on classical formal function the way we #nd them in the music of the Schoenberg school, Togni markedly cuts back on this kind of thematicism in his music from the second half of the decade. $e single-movement concerto for "ute and string orchestra Fantasia concertante, composed in 1956–1957, is a prime example for this shift in his style. $e work no longer presents recurring melodic ‘themes’. Its textures no longer project clearly distinguishable superimposed ‘lines’ as was the case in much of Togni’s earlier music. Furthermore, we hardly ever hear a recognisable metric 47 ARCHIVAL NOTES Sources and Research from the Institute of Music, No. 3 (2018) © Fondazione Giorgio Cini, Venezia ISSN 2499-832X CHRISTOPH NEIDHÖFER pulse in this 9½-minute piece, and its musical characters generally no longer fall into the kinds of ‘topics’ familiar from earlier twelve-tone expressionism. -

The SCI Newsletter Society of Composers, Inc
I The SCI Newsletter Society of Composers, Inc. P.O.Box 296 OLD CHELSEA STATION NEW YORK, NY 10113-0296 ACA Laurel Leaf Award VOLUME 22 NUMBER 4 APRIL 1992 University Of Alabama Hosts 26th Annual SCI Conference by GERALD WARFIELD Enormous thanks are due Marvin MARGARET BROUWER Johnson for his industry and skill in put HAROLD SCIDFFMAN MARVIN JOHNSON, Associate ting together a conference of this size and JOHN WHITE Professor of Music at the University of complexity. His staff, from performers to STEPHEN GRYC Alabama, was host for the Society's 26th the drivers of the vans, did an exceptional PHILIP CARLSEN Annual Conference. Marvin coordinated and cheerful job. Dennis Monk, Director JAMES R. GREESON the considerable resources of the music of the School of Music, is to be congratu ALEJANDRO TKACZEVSKI department, which included the Sym lated on having such capable resources to HARVEY J. STOKES phony, the Wind Ensemble, the Chorus, mount such an excellent conference. The BYRONK. YASUI the Contemporary Music Ensemble, and only downside to a conference like this, GREG STEINKE many faculty and students.... Also perform observed one attendee, is that it's a very WILLIAM PENN ing were the Quapaw String Quartet, the tough act to follow. EUGENIO MANUAL RODRIGUES Cadek Trio and the Contemporary En KURT KAZUO KUNIYASU Two items of business deserve men sembles from the University of Georgia MAX LIFCHITZ tion. General Manager GERALD WAR and the University of Illinois. The final ELIZABETH VERCOE FIELD reported that for the second year concert was given by the Alabama Sym MARSHALL BIALOSKY in a row, SCI operated in the black - good phony Orchestra conducted by Paul Poliv NORMAN WESTON news in these uncertain times -- and the nick.