Note Floristiche Piemontesi N. 309-392
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gli Anemoni Bianchi Sono Piante Molto Belle E Diffuse
14 maggio 2011 (f.f.) gli anemoni bianchi sono piante molto belle e diffuse sulle nostre montagne anche se non creano i meravigliosi tappeti fioriti presenti nei boschi di latifoglie del nord-Europa. Distinguiamo due specie molto simili che devono essere rispettate anche se solo una è presente tra le specie protette in Toscana. IL GENERE ANEMONE Famiglia Ranunculaceae Anemone L. fu classificato da Linneo nel 1753. Il nome generico Anemone deriva dal latino ănĕmōnē, es termine usato da Plinio il Vecchio, a sua volta derivato dal greco άνεμώνη che denominava queste piante. Il termine è legato, nella tradizione popolare, a άνεμος (= vento) essendo questa pianta diffusa nei boschi esposti ai venti oppure perchè il suo fiore si apre al soffio dei venti. In realtà gli studiosi sono incerti sulla reale origine del termine che alcuni fanno derivare da Naaman, nome semitico di Adone, dal cui sangue, secondo la leggenda, si formarono gli anemoni. Diversi sono i miti che riguardano questo fiore: in uno di essi Zefiro si innamorò della ninfa Anemone e Chloris, la dea dei fiori, gelosa, la trasformò nel fiore condannato a schiudersi al soffio dei venti. In un altro mito Adone,del quale si era innamorata Venere, venne ucciso dal gelosissimo Marte trasformatosi in cinghiale, dalle lacrime di Venere e dal sangue di Adone sbocciarono gli anemoni. L’anemone era considerato simbolo di malinconia e dolore e in alcune tradizioni divenne simbolo del lutto e della morte Il genere Anemone è strettamente imparentato con i generi Pulsatilla e Hepatica tanto che in passato essi erano compresi nello stesso genere. -

A New Plant Community with the Strictly Endemic "Cirsium Alpis-Lunae
ARTICLES Mediterranean Botany ISSNe 2603-9109 http://dx.doi.org/10.5209/MBOT.60195 A new plant community with the strictly endemic Cirsium alpis-lunae (Asteraceae) in the Northern Apennines (Italy) and considerations on the alliances Senecionion samniti and Adenostylion alpinae Daniele Viciani1, Lorenzo Lazzaro1, Vincenzo Gonnelli2 & Lorenzo Lastrucci3 Received: 13 May 2018 / Accepted: 20 January 2019 / Published online: 20 February 2019 Abstract. We conducted a phytosociological study of the particular coenoses with presence of Cirsium alpis-lunae, a strictly endemic species living in marly-arenaceous montane screes of the Apennines between Tuscany, Emilia-Romagna and Marche. We surveyed all the reported locations and analyzed the coenological and ecological features of the communities by means of standard statistical methods, describing a new association, Laserpitio latifolii-Cirsietum alpis-lunae. We attributed the new association to Mulgedio-Aconitetea, but we noted in the literature some nomenclatural misinterpretations concerning the syntaxonomic treatment of this Apennine vegetation at the order and alliance level. We found that Adenostylion alpinae is the most suitable alliance to encompass Laserpitio latifolii-Cirsietum alpis-lunae and it cannot be considered a synonym of Senecionion samniti. Senecionion samniti was here lectotypified, and seems to be closer toMolinio-Arrhenetheretea than to Mulgedio-Aconitetea. Keywords: Cirsium alpis-lunae; Ecology; Phytosociology; screes; Syntaxonomy; vegetation. Una nueva asociación de Cirsium alpis-lunae (Asteraceae) endémica de los Apeninos del Norte (Italia) y consideraciones sobre las alianzas Senecionion samniti y Adenostylion alpinae Resumen. Se presenta el estudio fitosociológico de las comunidades con presencia de Cirsium alpis-lunae, una especie estrictamente endémica que vive en taludes o pedreras margoso o arenosas de los Apeninos entre la Toscana, Emilia- Romagna y Marche. -

Contributo Al PIA Della Provincia Di
PROVINCIA DI VERCELLI Ufficio Studi e Statistica, Controllo di Gestione Contributo al Progetto integrato d’area (PIA) della provincia di Vercelli per il Vercellese PROVINCIA DI VERCELLI DOCUP 2000-2006 – Misura 3.1 a) Progetti integrati d’area PROGETTO INTEGRATO D’AREA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI ZONA “VERCELLESE” Maggio 2002 RELAZIONE SOCIO-ECONOMICA Situazione socio-economica della provincia di Vercelli Per meglio comprendere le caratteristiche socio-economiche del territorio che fa riferimento al Progetto integrato d’area (PIA) del Vercellese è necessario tracciare un quadro della situazione provinciale. La provincia di Vercelli è caratterizzata da un forte elemento di particolarità, sempre da evidenziare e da tenere ben presente se si vuole comprendere appieno la realtà locale: il territorio provinciale è ripartito in due aree geograficamente distinte, contrassegnate da diverse caratteristiche morfologiche e differenziate dal punto di vista socio-economico. L’area del Vercellese, che costituisce la parte meridionale della provincia, è pianeggiante, con una consistente presenza dell’agricoltura ed una minore incidenza relativa delle attività industriali. Conta il 76,7% della popolazione residente ed il 59,4% della superficie territoriale sul totale provinciale. L’area della Valsesia, localizzata nella parte settentrionale, è quasi interamente montana, con una forte presenza industriale nella Bassa Valle ed una marcata rarefazione abitativa nell’Alta Valle. Detiene il 23,3% della popolazione residente ed il 40,6% della superficie territoriale. La provincia ha una popolazione residente di 180.668 persone (87.279 maschi, 93.389 femmine, sulla base del dato al 31 dicembre 2000). Gli ultimi tre anni vedono un arresto della tendenza alla perdita di popolazione residente, che si era protratta per tutto il triennio precedente (prendendo cioè in considerazione i dati a partire dall’anno 1995, quando la provincia di Vercelli, con il distacco del territorio biellese, ha assunto la configurazione attuale). -

Piano Chiusure Cantieri BUL PROVINCIA COMUNE
Piano chiusure cantieri BUL PROVINCIA COMUNE Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021 185 Torino Agliè Chiuso con collaudo certificato 184 Biella Ailoche Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 183 Vercelli Albano Vercellese Chiuso con collaudo certificato 182 Vercelli Alice Castello Chiuso con collaudo certificato 181 Torino Alice Superiore Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 180 Torino Alpette Chiuso con collaudo certificato 179 Biella Andorno Micca Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 178 Verbano‐Cusio‐Ossola Antrona Schieranco Chiuso con collaudo certificato 177 Vercelli Arborio Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 176 Verbano‐Cusio‐Ossola Arizzano Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 175 Verbano‐Cusio‐Ossola Arola Chiuso con collaudo certificato 174 Vercelli Asigliano Vercellese Chiuso con collaudo certificato 173 Verbano‐Cusio‐Ossola Aurano Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 172 Vercelli Balmuccia Chiuso con collaudo certificato 171 Alessandria Balzola Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 170 Verbano‐Cusio‐Ossola Bee Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 169 Alessandria Belforte Monferrato Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 168 Biella Benna Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 167 Vercelli Bianzè Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ -

PDG Alpe Luna
SOMMARIO PAG. I SOMMARIO 1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVO .................................................. 1 2 AMBIENTE FISICO ............................................................................................................... 2 2.1 CLIMA ............................................................................................................................... 2 2.1.1 Aspetti generali ........................................................................................................ 2 2.1.2 Clima locale ............................................................................................................. 3 2.1.3 Temperatura ............................................................................................................ 4 2.1.4 Precipitazioni ........................................................................................................... 4 2.1.5 Direzione e velocità dei venti ................................................................................... 5 2.1.6 Inquadramento biogeografico .................................................................................. 5 2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ........................................................................................... 9 2.2.1 Aspetti geologici ....................................................................................................... 9 2.2.1.1 Generalità ............................................................................................................. 9 2.2.1.2 Litotipi affioranti -
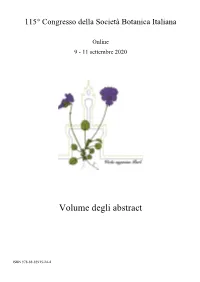
Volume Degli Abstract
115° Congresso della Società Botanica Italiana Online 9 - 11 settembre 2020 Volume degli abstract ISBN 978-88-85915-24-4 Comitato Scientifico Comitato Tecnico e Organizzativo Consolata Siniscalco (Torino) (President) Chiara Barletta Maria Maddalena Altamura (Roma) Gianniantonio Domina Stefania Biondi (Bologna) Lorenzo Lazzaro Alessandro Chiarucci (Bologna) Marcello Salvatore Lenucci Salvatore Cozzolino (Napoli) Stefano Martellos Lorenzo Peruzzi (Pisa) Giovanni Salucci Ferruccio Poli (Bologna) Lisa Vannini Carlo Blasi (Università La Sapienza, Roma) Luca Bragazza (Università di Ferrara) Giuseppe Brundu (Università di Sassari) Stefano Chelli (Università di Camerino) Vincenzo De Feo (Università di Salerno) Giuseppe Fenu (Università di Cagliari) Goffredo Filibeck (Università della Tuscia) Marta Galloni (Università di Bologna) Lorenzo Gianguzzi (Università di Palermo) Stefano Martellos (Università di Trieste) Anna Maria Mercuri (Università di Modena e Reggio Emilia) Lorella Navazio (Università di Padova) Alessio Papini (Università di Firenze) Anna Maria Persiani (Università La Sapienza, Roma) Rossella Pistocchi (Università di Bologna) Marta Puglisi (Università di Catania) Francesco Maria Raimondo (Università di Palermo) Luigi Sanità di Toppi (Università di Pisa) Fabio Taffetani (Università delle Marche) Sponsor 115° Congresso della Società Botanica Italiana onlus Online, 9-11 settembre 2020 Programma Mercoledì 9 settembre 2020 SIMPOSIO GENERALE “I VARI VOLTI DELLA BOTANICA” (Moderatori: A. Canini e A. Chiarucci) 9.00-11.00 Comunicazioni • Luigi Cao Pinna, Irena Axmanová, Milan Chytrý et al. (15 + 5 min) “La biogeografia delle piante aliene nel bacino del Mediterraneo” • Andrea Genre, Veronica Volpe, Teresa Mazzarella et al. (15 + 5 min) “Risposte trascrizionali in radici di Medicago truncatula esposte all'applicazione esogena di oligomeri di chitina a catena corta” • Gianluigi Ottaviani, Luisa Conti, Francisco E. -

La Flora Della Provincia Di Pavia (Lombardia, Italia Settentrionale). 1
Natural History Sciences. Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano, 3 (2): 51-79, 2016 DOI: 10.4081/nhs.2016.269 La flora della provincia di Pavia (Lombardia, Italia settentrionale). 1. L’Oltrepò Pavese Nicola Maria Giuseppe Ardenghi1*, Francesco Polani2 Riassunto – Viene presentata ed analizzata la flora vascolare no longer recorded after 1980; 245 doubtfully present taxa and 161 taxa dell’Oltrepò Pavese, uno dei territori floristicamente più variegati e erroneously recorded in the past are additionally reported. Species and meno conosciuti dell’Italia nord-occidentale. L’opera costituisce il subspecies endemic to Italy amount to 16 while the alien taxa to 321 primo di tre contributi relativi alla flora della provincia di Pavia, per (neophytes and archaeophytes). 4 new neophytes (Bidens triplinervia, la quale mancava un lavoro di sintesi da oltre centocinquant’anni. I Cucurbita melopepo subsp. melopepo, Morus kagayamae, Vitis ber- due elenchi floristici allegati si basano sui dati raccolti in campo dagli landieri × V. vinifera) and one new archaeophyte (×Triticosecale) to autori, integrati con le informazioni derivanti dallo studio critico della Italy are here recorded; among the 30 novelties and the 16 confirmed bibliografia esistente e dalla revisione dei campioni conservati soprat- taxa to the flora of Lombardy, 6 are Italian endemics (Adenostyles aus- tutto presso l’Erbario Lombardo dell’Università di Pavia (PAV) e tralis, Brachypodium genuense, Centaurea aplolepa s.l., Hieracium l’erbario del Museo di Storia Naturale di Milano (MSNM). Nell’area grovesianum s.l., Stipa etrusca, Tephroseris italica). di studio risultano presenti 1.871 taxa (specie, sottospecie e ibridi), di cui 183 non più ritrovati dopo il 1980; a questi si aggiungono 245 Key words: Alien flora, Italian endemics, Northern Apennines, entità di presenza dubbia e 161 segnalate per errore. -

ATO N. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”
Allegato 2 alla relazione dell’Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati Giugno 2020 ATO n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” Data di costituzione 13 -mag -02 Presidente Claudio CORRADINO Direttore Elena AUDAGNA Via G.Carducci, 4 Sede 13100 VERCELLI Via G.Carducci, 4 Sede Direzione e Uffici 13100 VERCELLI Sito Web http://www.ato2pi emonte.it PEC [email protected] Posta elettronica [email protected] Telefono 0161/210811 SUPERFICIE E POPOLAZIONE Superficie territoriale 3.339 Km2 Popolazione residente 419.147 abitanti * * Fonte ISTAT – aggiornamento al 01/01/2018 REFERENTI DI AREA Area di competenza Funzionario Telefono Servizio Amministrativo - Finanziario - Comunicazione: Elena Audagna 0161/501219 Cesare Cuzzi 0161/213353 Servizio Tecnico - Controllo - Approvazione Progetti Giovanni Mercuri 0161/257658 An drea Manachino 0161/257658 Monica Fiore 0161/258538 Segreteria e amministrazione Giulia Ranaboldo 0161/210811 1 Allegato 2 alla relazione dell’Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati Giugno 2020 COMPOSIZIONE N° Province 4 (Alessandria, Biella, Novara,Vercelli) Città Metropolitane 1 (Torino) N° Unioni Montane 6 N° Comuni Montani 75 Aree Omogenee 15 N° Comuni 172 RAPPRESENTATIVITÀ Ente % Provincia di Alessandria 2,88% Provincia di Biella 10,93% Provincia di Novara 0,09% Città Metropolitana di Torino 0,21% Provincia di Vercelli 10,89% AO Biellese 1 6,28% AO Bielles e 2 2,21% AO Biellese 3 1,71% AO Biellese 4 1,28% AO Vercellese 1 6,47% AO Vercellese 2 2,96% AO Vercellese 3 1,86% AO Vercellese 4 3,52% AO -

Provincia Di Vercelli
Provincia di Vercelli DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO DECRETO DICH. INESISTENZA USI ALAGNA VALSESIA 14/05/1941 COMMISSARIALE CIVICI SITUAZIONE DA SITUAZIONE DA ALAGNA VALSESIA 02/11/1994 DEFINIRE DEFINIRE DECRETO ASSEGNAZIONE ALBANO VERCELLESE 26/01/1940 MINISTERIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A ALBANO VERCELLESE 16/12/1977 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A ALICE CASTELLO 28/05/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA ARBORIO - - DECRETO ASIGLIANO DECRETO ASSEGNAZIONE A 11/01/1940 VERCELLESE COMMISSARIALE CATEGORIA ASIGLIANO DECRETO ASSEGNAZIONE A 11/01/1941 VERCELLESE COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA BALMUCCIA - - DECRETO DECRETO ASSEGNAZIONE A BALOCCO 13/03/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIANZE' 07/03/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA BOCCIOLETO - - DECRETO DECRETO ASSEGNAZIONE A BORGO D'ALE 05/02/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA BORGO VERCELLI - - DECRETO DECRETO ASSEGNAZIONE A BORGOSESIA 25/06/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BREIA 20/10/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BURONZO 24/03/1937 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE BURONZO 05/11/1938 MINISTERIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMPERTOGNO 18/11/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMPERTOGNO 08/04/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CARCOFORO 23/03/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CARESANA 12/06/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA CARESANABLOT -

A Cura Di G. Sommo
Basso Vercellese e Vercellese occidentale 1 2 Luoghi fortificati fra Dora Baltea, Sesia e Po Basso Vercellese e Vercellese occidentale a cura di 3 GIOVANNI SOMMO LUOGHI FORTIFICATI FRA DORA BALTEA. SESIA E PO Atlante aerofotografico dell'architettura fortificata sopravvissuta e dei siti abbandonati II Basso Vercellese e Vercellese occidentale Ex tipis cardi Edizione elettronica per Archeovercelli.it © Edizioni del Cardo - Edizioni del Gruppo Archeologico Vercellese Vercelli 2012 4 Luoghi fortificati fra Dora Baltea, Sesia e Po Studi sul territorio 3 1992 “Edizioni del Cardo © Gruppo Archeologico Vercellese, Abbazia di S. Andrea, piazza Roma, 13100 Vercelli-tel. 0161-57651-255251 Composizione-videoimpaginazione a cura di Edizioni del Cardo, Vercelli. Progetto grafico Paolo M. Galimberti. Stampa Tipografia Saviolo, Vercelli. Pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri soci. Riguardo alle illustrazioni la redazione si è curata delle relative autorizzazioni degli aventi diritto. Nei casi in cui ciò non è stato possibile, resta comunque a disposizione per regolare eventuali spettanze o per eventuali adempimenti burocratici. In ogni caso si sono indicate le fonti. Per l’edizione dei materiali aerofotografici si è ottenuta autorizzazione dello S. M. A., n. 824, del 6. 9. 1991. La riproduzione dei documenti dell’Archivio di Stato di Vercelli è stata autorizzata con nota della Direzione n. 1772.X.9, del 29. 9. 1992. La pubblicazione è stata patrocinata da Basso Vercellese e Vercellese occidentale 5 INDICE SOMMARIO p. 6 Premessa 9 Basso Vercellese e Vercellese occidentale, fra Sesia, Po e Dora Baltea 17 Confienza 17 Palestro 20 Robbio 21 Rosasco 21 Castelnovetto 23 Langosco 24 Cozzo 26 Celpenchio 27 Candia Lomellina 27 Gazzo 29 Villanova Monferrato 30 Balzola 32 Pobietto 32 Castellario 34 Motta de’Conti 36 Caresana 39 Stroppiana 41 Rive 42 Pertengo 43 Costanzana 45 Saletta 46 Torrione 48 Castelli di Trino 50 S. -

Actaplantarum Notes Aprile 2013.Pdf
arabAFenice Acta Plantarum Notes 1 Le raccolte di Acta Plantarum Esplorazioni e Notizie sulla flora del territorio italiano *** A cura di: Alessandro Alessandrini Vito Buono Valerio Lazzeri Cristiano Magni Quintino G. Manni Gianluca Nicolella Aprile 2013 Le raccolte di Acta Plantarum Collana di Esplorazioni e Notizie sulla Flora del Territorio Italiano diretta da Alessandro Alessandrini Redazione grafica e impaginazione Quintino Manni coordinamento redazionale Cristiano Magni Vito Buono Valerio Lazzeri Gianluca Nicolella in collaborazione con Daniela Longo Chiusura editoriale il giorno 27 febbraio 2013 Immagini, testo, impaginazione e dati sono soggetti a Copyright © by ActaPlantarum 2007-2013 e Araba Fenice quando l'autore non è specificato. Tutti i diritti di Copyright © riservati agli autori quando specificati. I testi possono essere liberamente utilizzati citando la fonte. Araba Fenice via Re Benvenuto, 33 12012 Boves (CN) Tel. 0171/389814 I edizione elettronica: aprile 2013 ISBN: 978.88.6617.089.1 www.actaplantarum.org www.araba fenicelibri.it Indice Presentazione pag. 9 Una risorsa del WEB: il database IPFI (Index Plantarum Florae Italicae) Daniela Longo pag. 13 Kaspar Maria von Sternberg. Ritratto di un conte spesso ricordato solo come “autore” di alcune delle nostre specie floristiche più interessanti. Enzo Bona pag. 18 Contributo alla flora vascolare del Lazio Gianluca Nicolella pag. 27 Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & Gams Viperina pustulosa: una boraginacea poco conosciuta. Quintino G. Manni pag. 32 Vicia villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball Una conferma per il Salento. Aggiornamento all’areale di distribuzione. Quintino G. Manni pag. 37 Stachys cretica L. subsp. cretica (Lamiaceae) Dal Salento una nuova subspecie per la flora italiana Quintino G. -

An Inventory of the Names of Vascular Plants Endemic to Italy, Their Loci Classici and Types
Phytotaxa 196 (1): 001–217 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2015 Magnolia Press Monograph ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.196.1.1 PHYTOTAXA 196 An inventory of the names of vascular plants endemic to Italy, their loci classici and types LORENZO PERUZZI1§*, GIANNIANTONIO DOMINA2§, FABRIZIO BARTOLUCCI3§, GABRIELE GALASSO4§, SIMONETTA PECCENINI5§, FRANCESCO M. RAIMONDO6§, ANTONELLA ALBANO7, ALESSANDRO ALESSANDRINI8, ENRICO BANFI4, GIUSEPPINA BARBERIS5, LILIANA BERNARDO9, MAURIZIO BOVIO10, SALVATORE BRULLO11, GIUSEPPE BRUNDU12, ANTONELLO BRUNU12, IGNAZIO CAMARDA12,13, LUISA CARTA12, FABIO CONTI3, ANTONIO CROCE14, DUILIO IAMONICO16, MAURO IBERITE17, GIANLUCA IIRITI18, DANIELA LONGO5, STEFANO MARSILI5, PIETRO MEDAGLI7, ANNALAURA PISTARINO19, CRISTINA SALMERI6, ANNALISA SANTANGELO14, ELISABETTA SCASSELLATI17, FEDERICO SELVI20, ADRIANO SOLDANO21, ADRIANO STINCA15, MARIACRISTINA VILLANI22, ROBERT P. WAGENSOMMER11 & NICODEMO G. PASSALACQUA23§ 1Dipartimento di Biologia, Unità di Botanica, Università di Pisa, Via Luca Ghini 13, 56126, Pisa, Italy; e-mail [email protected] 2Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università di Palermo, Via Archirafi 38, 90123, Palermo, Italy 3Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università di Camerino - Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, San Colombo, 67021 Barisciano (L’Aquila), Italy 4Sezione di Botanica, Museo di Storia Naturale di Milano, corso Venezia