La Newsletter N.56 Di R.A.R.E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Linee Guida Per La Conservazione E La
La Newsletter n.53 di R.A.R.E. Novembre 2016 Cari Soci, in questa Newsletter troverete un sunto delle relazioni presentate nel corso del Convegno annuale di RARE tenutosi a Guastalla (RE) nell’ambito della manifestazione “Piante e animali perduti” del Comune di Guastalla. Informazioni sulla nostra associazione sono reperibili sul nostro sito: o www.associazionerare.it Abbiamo di recente aperto anche un account di RARE (RARE - Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione) su FaceBook, vi invitiamo a cercarci, comunicare notizie, opinioni… o https://www.facebook.com/associazionerare/?fref=ts è possibile contattarci via mail al nostro indirizzo di posta elettronica: o [email protected] o telefonando al numero: 0968.51633 (Floro De Nardo) Ricordiamo che non verranno più spedite NL ai soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Le quote associative sono: € 25 (socio sostenitore) o almeno € 10 (socio simpatizzante). Spero che, anche nel 2015, continuerai a sostenere R.A.R.E. rinnovando la tua adesione con un versamento su CCP n° 21786397 intestato a RARE – Via Nemo Sottili, 1 – 42123 Reggio Emilia. E’ possibile versare la quota di adesione tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN n. IT31Z0760101000000021786397 ma per l’invio delle Newsletter ed eventuali comunicazioni, si invita chi paga tramite bonifico ad inviare i propri dati, via mail all’indirizzo dell’associazione indicato sopra. In questo numero 14° convegno annuale di RARE …………………….…………………..……2 Riccardo Fortina - Università di Torino, RARE -

Relazione Attività Anno 2019
Assemblea Generale dei Soci Cuneo, 30 settembre 2020 RELAZIONE TECNICA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE Via Torre Roa, 13 12100 Madonna dell’Olmo - CUNEO www.arapiemonte.it 2 CARICHE SOCIALI Comitato Direttivo Chialva Roberto Presidente ARAP Presidente STA Cuneo Serra Franco Vice presidente Presidente STA Asti Odetti Paolo Vice presidente Presidente STA Torino Bongianino Roberto consigliere Presidente STA Vercelli e Biella Fortunato Mario consigliere Presidente STA Liguria Panizza Sergio consigliere Presidente STA Alessandria Parmigiani Simone consigliere Presidente STA Novara e VCO Dalmasso Elia consigliere Fassino Antonino consigliere Fiandino Davide consigliere Gianoglio Mario consigliere Fina Claudio consigliere Magliana Andrea consigliere Sanmartino Luca consigliere Viarengo Domenico consigliere Collegio Sindacale Morgese Vittorio Presidente Morabito Domenico sindaco effettivo Gallo Elena sindaco effettivo Probiviri Brondelli di Brondello Guido probiviro Salvini Elisabetta probiviro Bovetti Bartolomeo probiviro Direttore Valperga Tiziano 3 ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI Via XXIV Maggio n. 44/45, 00187 Roma SISTEMA ALLEVATORI DEL PIEMONTE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE e STA* di CUNEO Via Torre Roa, 13, Madonna dell’Olmo – 12100 Cuneo – Tel. 0171/410.800 Fax 0171/ 413.863 e-mail: [email protected] Via dell’Artigianato, 1 – 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) Tel. 0172/713972 Fax 0172/726348 e-mail: [email protected] STA di ALESSANDRIA Fraz. Gerlotti, via Casale 113 – 15122 Alessandria - Tel. 0131/1750290 Fax 0131/1750291 e-mail: [email protected] STA di ASTI Via Guttuari, 23 - 14100 Asti - Tel. 0141/530690 Fax 0141/530690 e-mail: [email protected] STA di NOVARA V.C.O. Corso Vercelli, 120 - 28100 Novara - Tel. 0321/453140 Fax 0321/453373 e-mail: [email protected] Regione Nosere - c/o Compl. -

Intervento Battaglini
Allevamenti pastorali sulle Alpi: prodotti, opportunità e servizi Luca Battaglini DISAFA - Università degli Studi di Torino Rete Nazionale della Pastorizia [email protected] 30 maggio 2017 Museo Paul Russotto Palazzo Caporale 1. Allevamento degli ovini e dei caprini : una reale «necessità» per territori «meno favoriti» 2. I servizi ecosistemici e la pastorizia sulle Alpi occidentali 3. Nuove esigenze e prospettive anche culturali per lo sviluppo della pastorizia 1. Allevamento degli ovini e dei caprini Problemi di ordine generale • Riduzioni delle superfici a pascolo • Aumento delle dimensioni medie di greggi (e mandrie) • Perdita di caratteristiche di determinati ambienti • Riduzione della variabilità delle risorse genetiche (biodiversità zootecnica) • Perdita delle produzioni locali (e tipiche) Alpine livestock farming systems in the Alps: abandonment and intensification Abandonment 1980-2000 in the Alps (Streifeneder et al., 2005; mod.) 0 -10 % -20 -30 -40 -50 Abandonment Abandonment -60 -70 aziendefarms UBALivestock units Allevamenti alpini in Italia (Battaglini et al., 2014) Variation Year 1990 2000 2010 1990-2010 (%) Meadows and pastures (ha) 1,109,367 1,016,180 812,236 -26.6 Cattle (n.): Farms 43,774 26,949 21,221 -51.5 Heads 578,484 492,701 446,531 -22.8 Heads/farm 13.2 18.3 21.0 +59.2 Dairy cows 275,605 223,115 194,440 -29.4 Dairy farms 37,803 20,924 15,157 -59.9 Dairy cows/dairy farm 7.3 10.7 12.8 +76.0 Sheep (n.): Farms 7,901 6,279 4,402 -44.3 Heads 175,274 176,054 191,713 +9.4 Heads/farm 22.2 28.0 43.6 +96.3 Goats (n.): Farms 7,221 6,258 4,442 -38.5 Heads 84,455 95,872 89,625 +6.1 Heads/farm 11.7 15.3 20.2 +72.5 Variazioni superfici pastorali (Reg. -

Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animali in Italia
▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ Rapporto sullo Stato delle Risorse Genetiche Animali in Italia Luglio 2005 ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ Introduzione L’autorizzazione per la stesura di questo Primo Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animale del Paese è stata concessa nel marzo 2001 a seguito di una comunicazione pervenuta dal Direttore Generale dell’Organizzazione Nazionale per l’Alimentazione e Agricoltura – FAO - invitando l’Italia a partecipare alla stesura di un rapporto che dovrà chiarificare lo stato delle risorse genetiche del Paese. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha assegnato il compito della stesura del 1º Rapporto al ConSDABI, nella persona del prof. Donato Matassino. Questo 1. Rapporto del Paese, sinteticamente, descrive l’attuale situazione delle risorse genetiche animali per l’alimentazione e per l’agricoltura e identifica i bisogni per consentirne la tutela, la conservazione e l’utilizzazione; inoltre, riferisce sullo stato delle risorse genetiche animali, sullo stato e sull’andamento delle risorse, nonché sul loro potenziale contributo all’agricoltura, all’alimentazione e allo sviluppo della ruralità multifunzionale sostenibile; in piú, analizza l’attuale capacità del paese per la gestione di queste risorse ed evidenzia le priorità che potrebbero risultare utili per la cooperazione internazionale. 3 ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ CAPITOLO 1 RESOCONTO DELLO STATO DELLA BIODIVERSITÀ NEL SETTORE DEGLI ANIMALI IN ITALIA. 1.1. Punto di vista dell’agricoltura italiana sistemi di produzione animale e relativa biodiversità. 1.1.1. Il Paese L’Italia confina a ovest con la Francia, a nord con la Svizzera e l’Austria, a est con la Slovenia, e nel suo interno si trovano lo Stato Vaticano e quello di San Marino. -

Allegato 1 Ammontare Dei Risarcimenti Dei Danni Da Predazione Sul
Allegato 1 Ammontare dei risarcimenti dei danni da predazione sul bestiame domestico per l’anno 2010 OVINI MORTI Meticci Ovini di razza Agnelli 0-3 mesi 44,00 85,00 Agnelli 3-6 mesi 100,00 110,00 Adulti > 6 mesi 90,00 115,00 1- Le razze riconosciute sono le seguenti: Delle Langhe,Sambucana, Frabosana, Bergamasca, Biellese, Saltasassi, Tacola, Garessina, Savoiarda, Sarda. 2- Per i capi di alta genealogia è assegnato un valore aggiunto pari al 2% per ogni punto di rank in più da 51 a 99. 3- Per i capi appartenenti a razze in via d’estinzione (Sambucana, Frabosana, Saltasassi, Tacola, Garessina, Savoiarda) è assegnato per ciascun capo un valore aggiunto di 30,00 Euro (pari al valore corrispettivo di 2 anni del premio). 4- Per i capi destinati alla produzione lattiero casearia il valore è aumentato del 20%. CAPRINI MORTI Meticci Caprini di Razza Capretti 0-3 mesi 50,00 90,00 Capretti 3-8 mesi 115,00 205,00 Capre > 8 mesi 85,00 248,00 Becchi >12 mesi 132,00 264,00 1- Le razze riconosciute sono le seguenti: Saanen, Camosciata, Roccaverano, Vallesana, Sempione. 2- Per i capi di alta genealogia è assegnato un valore aggiunto pari al 2% per ogni punto di rank in più da 51 a 99. 3- Per i capi appartenenti a razze in via d’estinzione (Roccaverano, Vallesana, Sempione) è assegnato per ciascun capo un valore aggiunto di 30,00 Euro (pari al valore corrispettivo di 2 anni del premio). 4- Per i capi destinati alla produzione lattiero casearia il valore è aumentato del 20%. -

Country Report Italy 2011
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) 21 st April 2011 ERFP Country report 2010 – 2011 COUNTRY: ITALY reported by: Giovanni Bittante Strategic Priority Area 1: Characterization, Inventory and Monitoring of Trends and Associated Risks The inventory of Italian animal genetic resources and the monitoring of trends and associated risks has been undertaken and summarized il the paper "Italian animal genetic resources in the Domestic Animal Diversity Information Systm of FAO" (Giovanni Bittante, 2011, Italian Journal of Animal Science,vol 10:e29, Annex 2). Several research activities on this topic have been carried out by Universities and Research Institutions. Among them see the important activity of ConSDABI (Annex 3). Strategic Priority Area 2: Sustainable Use and Development Beyond the systematic control of animals of Italian populations (herd books, pedigree registries, milk recording, type evaluation, etc.) made by the different associations of breeders, as outlined in Annex 2, several projects dealing with sustainable use, products valorisation and development has been carried out by national and local governments, agencies, breeders associations and consortia. Strategic Priority Area 3: Conservation (please give details for the most relevant institutions for national genebanks / cryopreservation in the table in Annex 1) In situ conservation activities are going on for almost all the Italian AnGR, while the project of a national virtual cryo-bank is not yet fully established, despite the intense work of the -

Livestock Biodiversity in Mediterranean Mountains”
International Programme on Research and Training on Sustainable Management of Mountain Areas “PROTECTING MOUNTAIN BIODIVERSITY” LivestockLivestock biodiversitybiodiversity inin MediterraneanMediterranean mountainsmountains Luca Battaglini & Manuela Renna UNIVERSITY OF TURIN Faculty of Agronomy – Department of Animal Science Wednesday, 14 July 2010 – Alagna Valsesia – Valle Otro (Vercelli Province) WhatWhatWhat isisis biodiversity?biodiversity?biodiversity? Luca Battaglini & Manuela Renna - “Livestock biodiversity in Mediterranean mountains” BiologicalBiologicalBiological DiversityDiversityDiversity BiodiversityBiodiversityBiodiversity The contracted term Biodiversity was coined by W.G. Rosen in 1985 while planning the National Forum on Biological Diversity organized by the National Research Council. Luca Battaglini & Manuela Renna - “Livestock biodiversity in Mediterranean mountains” DefinitionsDefinitionsDefinitions ofofof biodiversitybiodiversitybiodiversity The term can have many interpretations and it is most commonly used to replace the more clearly defined terms species diversity and species richness. Variation of life at all levels of biological organisation. The variability among living organisms from all sources, including inter-alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part (Convention on Biological Diversity, 1992) Luca Battaglini & Manuela Renna - “Livestock biodiversity in Mediterranean mountains” WhatWhatWhat doesdoesdoes “““losslossloss ofofof biodiversitybiodiversitybiodiversity””” -

La Salvaguardia Della Biodiversità Animale
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE LA SALVAGUARDIA DELLA LA SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ ANIMALE Iniziative generali ed azioni intraprese in Italia a tutela delle razze minacciate A cura di Francesco Panella ISBN 978-88-904416-8-4 FONDAZIONE INIZIATIVE FONDAZIONE - BRESCIA E ZOOTECNICHE ZOOPROFILATTICHE EDITO A CURA DELLA FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE - BRESCIA 84 9 788890 441684 84 LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITà ZOOTECNICA BIODIVERSITY CONSERVATION Nella stessa collana sono stati pubblicati i seguenti volumi: l - 1979 Infezioni respiratorie del bovino 2 - 1980 L’oggi e il domani della sulfamidoterapia veterinaria 3 - 1980 Ormoni della riproduzione e Medicina Veterinaria 4 - 1980 Gli antibiotici nella pratica veterinaria 5 - 1981 La leucosi bovina enzootica 6 - 1981 La «Scuola per la Ricerca Scientifica» di Brescia 7 - 1982 Gli indicatori di Sanità Veterinaria nel Servizio Sanitario Nazionale 8 - 1982 Le elmintiasi nell’allevamento intensivo del bovino 9 - 1983 Zoonosi ed animali da compagnia 10 - 1983 Le infezioni da Escherichia coli degli animali 11 - 1983 Immunogenetica animale e immunopatologia veterinaria 12 - 1984 5° Congresso Nazionale Associazione Scientifica di Produzione Animale 13 - 1984 Il controllo delle affezioni respiratorie del cavallo 14 - 1984 1° Simposio Internazionale di Medicina veterinaria sul cavallo da competizione 15 - 1985 La malattia di Aujeszky. Attualità e prospettive di profilassi nell’allevamento suino 16 - 1986 -

Elenco Di Tipologie Di Intervento Per La Compilazione Del Modello Di Domanda COD
Elenco di tipologie di intervento per la compilazione del modello di domanda COD. PROCED. NUM. INTERV. DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA (non visibile all'utente) (non visibile all'utente) 149 A001 Barra irroratrice numero 149 A002 Atomizzatore portato numero 149 A003 Rimorchio agricolo numero 149 A004 Bruciatore numero 149 A005 Motore per pompaggio o uso vario Kw 149 A006 Attrezzature per coltivazione 149 A007 Attrezzature per allevamento 149 A008 Attrezzature per apicoltura 149 A009 Attrezzature per trasformazione prodotti 149 A010 Attrezzature per conservazione prodotti 149 A011 Attrezzature per commercializzazione prodotti 149 A012 Attrezzature per vendita diretta 149 A013 Attrezzature informatiche 149 A014 Software 149 A099 Altre attrezzature 149 B001 Bovini allevamento 149 B001001 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze capi 149 B001001001 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Altre razze capi 149 B001001002 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Bruna capi 149 B001001003 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Frisona italiana capi 149 B001001004 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Grigio alpina capi 149 B001001005 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Limousine capi 149 B001001006 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Meticci capi 149 B001001007 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Pezzata R. d'Oropa capi 149 B001001008 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Pezzata R. italiana capi 149 B001001009 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Piemontese capi 149 B001001010 Bovini allevamento, 1-2 anni, manze Valdostana P.N. capi 149 B001001011 Bovini allevamento, -

Atlante Delle Razze Autoctone Bovini, Equini, Ovicaprini, Suini Allevati in Italia
00_Avanti_00_Avanti 15/07/19 10.26 Pagina I L'estratto contiene pagine non in sequenza Atlante delle razze autoctone Bovini, Equini, Ovicaprini, Suini allevati in Italia Daniele Bigi e Alessio Zanon 00_Avanti_00_Avanti 20/12/19 15.51 Pagina II L'estratto contiene pagine non in sequenza 1a edizione: novembre 2008 2a edizione: gennaio 2020 In copertina: Asino Romagnolo (A. Zanon, RARE); Scrofa Casertana (V. Peretti, RARE); Cavallo Salernitano (V. Peretti, RARE); Vacca Piemontese con vitello (R. Fortina, RARE); Capra Alpina Comune (L. Brambilla, RARE). © Copyright 2020 by “Edagricole – Edizioni Agricole di New Business Media S.r.l.”, Via Eritrea, 21 – 20157 Milano Redazione: Piazza G. Galilei, 6 – 40123 Bologna Vendite: tel. 051/6575833; fax 051/6575999 email: [email protected] – www.edagricole.it 5561 Proprietà letteraria riservata - printed in Italy La riproduzione con qualsiasi processo di duplicazione delle pubblicazioni tutelate dal diritto d’autore è vietata e penalmente perseguibile (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633). Quest’opera è protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore e delle Convenzioni internazionali per la protezione del diritto d’autore (Convenzione di Berna, Convenzione di Ginevra). Nessuna parte di questa pubblicazione può quindi essere riprodotta, memoriz- zata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, ecc.) senza l’autorizzazione scritta dell’editore. In ogni caso di riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge. Progetto -

Tesi Solimene 28Mar2013
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI DOTTORATO DI RICERCA IN PRODUZIONE E SANITA’ DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE INDIRIZZO: SCIENZE DELL ’ALLEVAMENTO ANIMALE XXV CICLO Caratterizzazione di geni che influenzano la prolificità nelle razze ovine autoctone Bagnolese e Laticauda allevate in regione Campania TUTOR CANDIDATO Ch.mo Prof. Vincenzo Peretti Dott.ssa Roberta Solimene COORDINATORE Ch.ma Prof.ssa M.L. Cortes i 1 INDICE 1. INTRODUZIONE 4 2. L’ALLEVAMENTO OVINO IN ITALIA 14 2.1 Il Miglioramento Genetico 16 2.2 La riproduzione 24 2.3 Le produzioni: latte, carne, lana 28 3. LA RAZZA OVINA LATICAUDA 33 3.1 Origini e diffusione 33 3.2 L’allevamento 34 3.3 Consistenza 37 3.4 Caratteristiche morfologiche 38 3.5 Caratteristiche riproduttive 41 3.6 Caratteristiche produttive 42 3.7 Selezione e Libro Genealogico 46 4. LA RAZZA OVINA BAGNOLESE 49 4.1 Origini e diffusione 49 4.2 L’allevamento 50 4.3 Consistenza 51 4.4 Caratteristiche morfologiche 53 4.5 Le Caratteristiche riproduttive 55 4.6 Caratteristiche produttive 56 4.7 Il Registro Anagrafico 59 5. GENI CHE REGOLANO LA FECONDITA’ 60 2 5.1 BMPR – 1 B 61 5.2 BMP 15 64 5.3 GDF 9 66 5.4 Interazioni tra i geni BMP 15, GDF 9 e BMPR – 1B 68 5.5 Effetti delle mutazioni dei geni BMP 15, GDF 9 e BMPR – 1B sulla fecondità 70 6. SCOPO DEL LAVORO 72 7. MATERIALI E METODI 73 8. RISULTATI E DISCUSSIONI 82 9. CONCLUSIONI 96 10. -
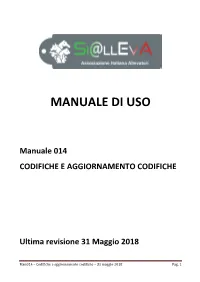
Codifiche E Aggiornamento Codifiche
MANUALE DI USO Manuale 014 CODIFICHE E AGGIORNAMENTO CODIFICHE Ultima revisione 31 Maggio 2018 Man014 – Codifiche e aggiornamento codifiche – 31 maggio 2018 Pag. 1 CODIFICHE Le codifiche sono tutti i codici che vengono utilizzati nel programma per definire le caratteristiche dell’informazione. I codici sono spesso utilizzati nelle liste al posto della descrizione estesa. Le codifiche sono registrate nel Data Base centrale e vengono salvate in locale dal programma per velocizzare la consultazione e l’utilizzo del software. Le codifiche non subiscono generalmente modifiche e vengono aggiornate ad ogni aggiornamento del programma. Qualora si dovesse procedere ad un aggiornamento nel Data Base centrale di alcune codifiche (ad esempio se si aggiungono Patologie mancanti), l’utente può procedere manualmente cliccando su Aggiorna Codifiche nel menu in alto a sinistra. Indice Codifiche incluse nel documento: RAZZE DIFFICOLTA’ AL PARTO STATI RIPRODUTTIVI CODICI EVENTI PATOLOGIE METODI DI CONTROLLO FUNZIONALE Man014 – Codifiche e aggiornamento codifiche – 31 maggio 2018 Pag. 2 RAZZE Specie Razza Specie Razza Cod Descrizione Cod Descrizione Cod Descrizione Cod Descrizione ND Non Definito ND Non definito AT Tuxer 70 Bufalo Mediterraneo AY Ayrshire 70 BUFALI Z0 Bufalo Meticcio BA Blonde d'Aquitaine Z1 Bufalo Murrah CZ Cserwona Polska -2 Rotbunte (importato) DX Dexter -1 Rotbunte (discendenza) GR Guernsey 00 Meticcia GW Galloway 01 Bruna HE Hereford 02 Frisona Italiana HL Highland 03 Valdostana Pezzata Rossa HS Hérens (Heringer ) 04 Pezzata Rossa Italiana