Reading Giancarlo De Carlo, Urbino 2013/14
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Giancarlo De Carlo : an Obituary John Mckean
Giancarlo De Carlo : an obituary John McKean Giancarlo De Carlo, who died on Saturday morning 4th June aged 85, was architecture’s last great link with the heroic modernism of CIAM; not least in his scathing critique of pre-war existenz-minimum, his finding Corbu’s Marseille Unité “terrible”, and his providing the serious theoretical underpinning for Team-X. He was, as his close friend Aldo van Eyck said long ago, a master of paradox. He was both elusive and absolutely clear. He was both renowned and yet a secret. One of the foremost architectural thinkers of his time, he published no unified volume of theory. He was not an architect who played at being a theorist, but an intellectual whose medium was architecture. (That is, not abstract writing around architecture, but its concrete profession, embedded in its social practice.) He was one of the most memorable architectural teachers of his generation, and yet always set himself outside, at a critical angle to the academy. Fascinated by Napoleon (a man nearly as small as himself) he was a lifelong anarchist and prominent anti-Fascist fighter during the Second World War. In architecture too, he fought against heroes, signatures and icons, as against so much else which subverts the possibility of a real modern architecture. This - in itself an heroic struggle - forced a continual questioning of the nature of the modern. I remember, at a time when so many couldn’t be bothered with the issue, in those post-modern years around 1980, not just his intellectual probing of the differences between eclecticsm and multiplicity, but his generous invitations to Charles Moore and Donlyn Lyndon and others to enrich the debates. -

Architettura 1.2016 Stare in Tanti Architettura Spedizione Inabbonamento Postale 70% Firenze € Anno XX N.1 Periodico Semestrale Firenze PRESS UNIVERSITY FIRENZE
FIRENZE stare in tanti architettura 1.2016 1.2016 stare in tanti FIRENZE UNIVERSITY firenze architettura PRESS ISSN 1826-0772 Periodico semestrale Anno XX n.1 € 14,00 Spedizione in abbonamento postale 70% Firenze In copertina: Le Corbusier, photogramme da sequenza filmata con la sua cinepresa tra il 1936 e il 1939 © FLC Paris DIDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA architetturaFIRENZE via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze - tel. 055/2755419 fax. 055/2755355 Periodico semestrale* Anno XX n. 1 - 2016 ISSN 1826-0772 (print) - ISSN 2035-4444 (online) Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 4725 del 25.09.1997 Direttore responsabile - Saverio Mecca Direttore - Maria Grazia Eccheli Comitato scientifico - Alberto Campo Baeza, Maria Teresa Bartoli, Fabio Capanni, João Luís Carrilho da Graça, Francesco Cellini, Maria Grazia Eccheli, Adolfo Natalini, Ulisse Tramonti, Chris Younes, Paolo Zermani Redazione - Fabrizio Arrigoni, Valerio Barberis, Riccardo Butini, Francesco Collotti, Fabio Fabbrizzi, Francesca Mugnai, Alberto Pireddu, Michelangelo Pivetta, Andrea Volpe, Claudio Zanirato Collaboratori - Simone Barbi, Gabriele Bartocci, Caterina Lisini, Francesca Privitera Info-Grafica e Dtp - Massimo Battista - Laboratorio Comunicazione e Immagine Segretaria di redazione e amministrazione - Grazia Poli e-mail: [email protected] Copyright: © The Author(s) 2016 This is an open access journal distribuited under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode) -

Clelia Tuscano
Giancarlo de Carlo and the Italian context of Team 10 Clelia Tuscano 227 Sociology, Production and the City Introduction Giancarlo de Carlo is the only Italian meber of Team 10. He was born in 1919 and now lives in Milan. He is an individualist, and a humanistic architect and a man of strong morality. I say humanistic, because of his manyfold culture and because of his view of architecture as something which is about people. He looks at architecture as part of the whole, com- plex process which deals with transformation of society through time. Architecture cannot change society as a whole, but can suggest the directions of change and support them, make them grow, give them spaces and represent them in physical forms. He has said somewhere that towns are written history, and the process of designing in his case is somehow linked to ‘read’ the context, both social and physical, and to find out the vital forces in it, and to deal with them for transformation. And ‘reading’ the context is not the recording of an objective pattern, but a tendentious interpretation of how a local context works and, through planning and architectural design, bring it closer to how it should work. Giancarlo de Carlo is one of the most tough moral architects, one of those persons who might make their client regret their choice: working for people is not always a private and even a public aim. No celebration or monumentalism in his work, and a lot of energy spent on designing the open spaces, which are not sold or used in ‘productive’ ways. -

Mauro Marzo Lotus. the First Thirty Years of an Architectural Magazine
DOI: 10.1283/fam/issn2039-0491/n43-2018/142 Mauro Marzo Lotus. The first thirty years of an architectural magazine Abstract Imagined more as an annual dedicated to the best works of architectu- re, urban and industrial design, during the first seven issues, the maga- zine «Lotus» shifts the axis of its purpose from that of information and professional updating to one of a critical examination of the key issues intrinsic to the architectural project. This article identifies some themes, which pervaded the first thirty years of «Lotus» life, from 1964 to 1994, re- emerging, with variations, in many successive issues. If the monographic approach set a characteristic of the editorial line that endures over time, helping to strengthen the magazine’s identity, the change in the themes dealt with over the course of the decades is considered as a litmus test of the continuous evolution of the theoretical-design issues at the core of the architectural debate. Keywords Lotus International — Architectural annual — Little Magazine — Pier- luigi Nicolin — Bruno Alfieri The year 1963 was a memorable one for the British racing driver Jim Clark. At the helm of his Lotus 25 custom-made for him by Colin Chapman, he had won seven of the ten races scheduled for that year. The fastest lap at the Italian Grand Prix held at Monza on 8 September 1963 had allowed him and his team to win the drivers’ title and the Constructors’ Cup,1 with three races to go before the end of the championship. That same day, Chap- man did “the lap of honour astride the hood of his Lotus 25”.2 This car, and its success story, inspired the name chosen for what was initially imagined more as an annual dedicated to the best works of archi- tecture, urban and industrial design, rather than a traditional magazine. -

Giancarlo De Carlo Centennial
Benedict Zucchi Learning from Giancarlo De Carlo: Interview with Benedict Zucchi, by Antonello Alici Anglosaxon sensibility; William Morris and Patrick Geddes; “Simulating slow growth”; Stamina; Commitment /Introduction by Antonello Alici /Author Giancarlo De Carlo’s centennial has the merit of bringing the Principal and architect profession chair at BDP, younger generations of students and researchers closer to the London [email protected] work of an extraordinary interpreter of 20th century architectural culture. An uncomfortable and controversial interpreter who has Benedict Zucchi studied architecture at the universities of Cambrid- experienced all the seasons of the second half of the 20th century ge and Harvard, writing his degree dissertation on the work of Gian- with tenacity and consistency, opposing every form of architec- carlo De Carlo. This was subsequently published in 1992 as the first ture distant from the experience and needs of society. comprehensive English-language monograph of De Carlo’s work. In a panorama of studies that up until now has been lacking, two After a period in De Carlo’s Milan studio, Benedict joined Building of the most important monographs on De Carlo, capable of fully Design Partnership (BDP) in 1994. grasping his complexity and modernity, are by English authors BDP’s culture of user-centred, interdisciplinary design was a welco- first of them is Benedict Zucchi who approached De Carlo during me compliment to his experience with De Carlo, leading to a rewar- his studies at the faculty of architecture in Cambridge, and then ding sequence of public sector projects across the education and further enriched his experience with a professional internship health sectors. -

The Design of New Buildings in Historical Urban Context: Formal Interpretation As a Way of Transforming Architectural Elements of the Past
THE DESIGN OF NEW BUILDINGS IN HISTORICAL URBAN CONTEXT: FORMAL INTERPRETATION AS A WAY OF TRANSFORMING ARCHITECTURAL ELEMENTS OF THE PAST A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY ELİF BEKAR IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARCHITECTURE IN ARCHITECTURE SEPTEMBER 2018 Approval of the thesis: THE DESIGN OF NEW BUILDINGS IN HISTORICAL URBAN CONTEXT: FORMAL INTERPRETATION AS A WAY OF TRANSFORMING ARCHITECTURAL ELEMENTS OF THE PAST submitted by ELİF BEKAR in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Architecture in Architecture Department, Middle East Technical University by, Prof. Dr. Halil Kalıpçılar _________________ Dean, Graduate School of Natural and Applied Sciences Prof. Dr. Cânâ Bilsel _________________ Head of Department, Architecture Prof. Dr. Aydan Balamir _________________ Supervisor, Architecture Dept., METU Examining Committee Members: Assoc.Prof. Dr. Haluk Zelef _________________ Department of Architecture, METU Prof. Dr. Aydan Balamir _________________ Department of Architecture, METU Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu _________________ Department of Architecture, Gazi University Date: 07.09.2018 I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Name, Last name : Elif Bekar Signature : ____________________ iv ABSTRACT THE DESIGN OF NEW BUILDINGS IN HISTORICAL URBAN CONTEXT: FORMAL INTERPRETATION AS A WAY OF TRANSFORMING ARCHITECTURAL ELEMENTS OF THE PAST Bekar, Elif M.Arch., Department of Architecture Supervisor: Prof. -

Born in Venice in 1944, He Took the Degree in Architecture at the Istituto
Daniele Pini Architect Planner Office: Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Ferrara via Quartieri 8 - 44121 Ferrara (Italy) Tel (39) 0532. 293600-293637 Fax (39) 0532 293600 E-mail: [email protected] Personal: Corso Ercole 1° d’Este, 4 44121 Ferrara (Italy) Tel & Fax: (39) 0532. 241415 Mobile: (39) 348 5108593 E-Mail: [email protected] CURRICULUM VITAE Born in Venice (Italy) in 1944. Degree in Architecture at the Istituto Universitario di Architettura of Venice in 1969. Full Professor of Urban Planning and Deputy Director of the Department of Architecture of the Università degli Studi of Ferrara, where he teaches since the institution in 1992 (formerly assistant and associate professor at the Istituto Universitario di Architettura of Venice since 1973) and visiting professor on Urban Conservation at the Raymond Lemaire International Conservation Centre of the Katholieke Universiteit Leuven (Belgium). He visited several universities abroad (Dublin, Southbank Polytechnic of London, Leuven, Paris-Belleville, Aix-en-Provence, Clermond Ferrand, Bordeaux, New Dehli, University of California - Berkeley, Stockholm and Goetheborg). As an expert-consultant of the Ministry of Foreign Affairs he was appointed to the Scientific Committee of the Post-Graduate schools of Planning in Algiers and Tunis. He also practices, in Italy and abroad, as a consultant of local governments, public administrations and international organisations (UNESCO, World Bank, UNDP), in the fields of conservation planning and urban design. As a teacher, scholar and consultant architect-planner, his interests are focussed on the urban rehabilitation and regeneration, with regard to the issues of cultural heritage and landscape conservation, the design of the open public spaces, and the reorganisation of the mobility and infrastructural systems. -

Lecture Handouts, 2013
Arch. 48-350 -- Postwar Modern Architecture, S’13 Prof. Gutschow, Classs #1 INTRODUCTION & OVERVIEW Introductions Expectations Textbooks Assignments Electronic reserves Research Project Sources History-Theory-Criticism Methods & questions of Architectural History Assignments: Initial Paper Topic form Arch. 48-350 -- Postwar Modern Architecture, S’13 Prof. Gutschow, Classs #2 ARCHITECTURE OF WWII The World at War (1939-45) Nazi War Machine - Rearming Germany after WWI Albert Speer, Hitler’s architect & responsible for Nazi armaments Autobahn & Volkswagen Air-raid Bunkers, the “Atlantic Wall”, “Sigfried Line”, by Fritz Todt, 1941ff Concentration Camps, Labor Camps, POW Camps Luftwaffe Industrial Research London Blitz, 1940-41 by Germany Bombing of Japan, 1944-45 by US Bombing of Germany, 1941-45 by Allies Europe after WWII: Reconstruction, Memory, the “Blank Slate” The American Scene: Pearl Harbor, Dec. 7, 1941 Pentagon, by Berman, DC, 1941-43 “German Village,” Utah, planned by US Army & Erich Mendelsohn Military production in Los Angeles, Pittsburgh, Detroit, Akron, Cleveland, Gary, KC, etc. Albert Kahn, Detroit, “Producer of Production Lines” * Willow Run B-24 Bomber Plant (Ford; then Kaiser Autos, now GM), Ypsilanti, MI, 1941 Oak Ridge, TN, K-25 uranium enrichment factory; town by S.O.M., 1943 Midwest City, OK, near Midwest Airfield, laid out by Seward Mott, Fed. Housing Authortiy, 1942ff Wartime Housing by Vernon Demars, Louis Kahn, Oscar Stonorov, William Wurster, Richard Neutra, Walter Gropius, Skidmore-Owings-Merrill, et al * Aluminum Terrace, Gropius, Natrona Heights, PA, 1941 Women’s role in the war production, “Rosie the Riverter” War time production transitions to peacetime: new materials, new design, new products Plywod Splint, Charles Eames, 1941 / Saran Wrap / Fiberglass, etc. -

BREAKING BARRIERS Giancarlo De Carlo from CIAM to ILAUD Lorenzo
BREAKING BARRIERS Giancarlo De Carlo from CIAM to ILAUD Lorenzo Grieco Università degli Studi di Roma Tor Vergata / University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy Abstract After World War II, the inflexibility characterizing the first CIAM congresses soon become unsustainable, provoking the criticism of Team 10, active from 1953 for a reform of the congress. The participated discourse of the group, “considering the characteristics of society and individuals”, would be inherited, years later, by the International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD), founded by Giancarlo De Carlo in 1976. The laboratory, together with the magazine Spazio e Società (1978-2001), called back to De Carlo’s operative militancy in Team 10, expressing a brand-new approach to urban studies. As De Carlo himself affirmed: “Some messages of Team 10 have been gathered in ILAUD […] but ILAUD and Team 10 are different things”. Indeed, the laboratory strongly pushed on the dimension of the project and on the students’ collective contribution. The project was no more an end point but became the tool through which every possible solution to the problem could be tested. Courses at ILAUD were given by international professionals like Aldo Van Eyck, Peter Smithson, Renzo Piano, Sverre Fehn and Balkrishna Vithaldas Doshi, some already in Team 10. The laboratory formed many young students, and several would have become internationally-recognized professionals -e.g. Eric Miralles, Carme Pinos, Santiago Calatrava, Mario Cucinella-. The paper wants to consider the contribution of ILAUD to urban studies and didactics through the examination of the rich material (annual publications, posters, projects, photos, etc.) collected in the archive of the Biblioteca Poletti in Modena. -

Of Bologna: Preservation Policies and Reinvention of an Urban Identity Filippo De Pieri and Paolo Scrivano
Document generated on 10/01/2021 4 a.m. Urban History Review Revue d'histoire urbaine Representing the "Historical Centre" of Bologna: Preservation Policies and Reinvention of an Urban Identity Filippo De Pieri and Paolo Scrivano Volume 33, Number 1, Fall 2004 Article abstract This article analyzes the visual and textual representations of the "historical URI: https://id.erudit.org/iderudit/1015673ar centre" of Bologna before and after 1969 the year when the first of the city's DOI: https://doi.org/10.7202/1015673ar celebrated plans for the preservation of the ancient urban fabric were approved. In spite of the attempts made by architects and planners to precisely See table of contents and "technically" define the object of the plans, the notion of "historical city centre" remained a vague and ambiguous one. Conflicting images of history, tradition, and centrality shaped the preservation policies, and were in turn Publisher(s) reshaped by them. The visual, historical, and political discourse behind the Bologna plans intentionally brought together a multiplicity of local and Urban History Review / Revue d'histoire urbaine non-local cultures, resulting in an overall reinvention of both a local identity and an idea of the city of the past. ISSN 0703-0428 (print) 1918-5138 (digital) Explore this journal Cite this article De Pieri, F. & Scrivano, P. (2004). Representing the "Historical Centre" of Bologna: Preservation Policies and Reinvention of an Urban Identity. Urban History Review / Revue d'histoire urbaine, 33(1), 34–45. https://doi.org/10.7202/1015673ar All Rights Reserved © Urban History Review / Revue d'histoire urbaine, 2004 This document is protected by copyright law. -

Giancarlo De Carlo and the Industrial Design
Luigi Mandraccio, Stefano Passamonti, Francesco Testa Giancarlo De Carlo and the Industrial Design Industrialdesign, Interior, Domestic, Modern, Custom /Abstract /Authors Giancarlo De Carlo is best known for his attention towards themes Luigi Mandraccio such as participatory design, the concept of project as a series University of Genoa - DAD Department of Architecture and Design of attempts, the questioning of the modern tradition in the wake Italy – [email protected] of the last CIAM and of the experience gained with Team Ten, his Luigi Mandraccio (Genoa, 1988) is an Architect and a Ph.D. Stu- uncertain and painful anarchic stance, the study of ancient archi- dent at the Architecture and Design Department (dAD), Polytechnic tecture and his sensitivity towards regional and spontaneous School, University of Genoa. His doctorate research – “Architecture modes of construction. and special structures for scientific research” – concerns the rela- It’s important therefore to go beyond a simple understanding of tions between the theory/practice of the project and the themes of the foundation of his professional experience as an architect, to science and machine, through the critical analysis of cases of ex- also grasp the rationale behind the formal outcomes of his work, treme structures for scientific research. with their technological and material implications, and behind a Since 2019 he has been involved within a research on the figure of workflow that was not only supported by logical thinking. Giancarlo De Carlo. His more comprehensive reflection on figures of “minor” masters is also expressed by the portraits of emblematic Still a hundred years since his birth, GDC’s professional experi- characters such as Bruno Zevi and Giuseppe Samonà, published in ence highlights a very modern approach that requires new inves- collective books. -
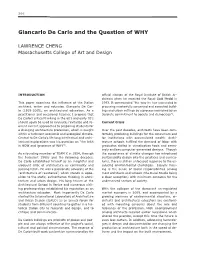
Giancarlo De Carlo and the Question of WHY
306 WHERE DO YOU STAND Giancarlo De Carlo and the Question of WHY LAWRENCE CHENG Massachusetts College of Art and Design INTRODUCTION official citation of the Royal Institute of British Ar- chitects when he received the Royal Gold Medal in This paper examines the influence of the Italian 1993. It commended “the way he has succeeded in architect, writer and educator, Giancarlo De Car- procuring masterfully conceived and executed build- lo (1919-2005), on architectural education. As a ings and urban settings by a process nourished by an practitioner and occasional teacher, I propose that absolute commitment to society and democracy”2. De Carlo’s critical thinking in the 60’s and early 70’s should again be used to evaluate, revitalize and re- Current Crisis orient current approaches to preparing students for a changing architecture profession, which is caught Over the past decades, architects have been com- within a turbulent economic and ecological climate. fortably producing buildings for the consumers and Central to De Carlo’s life long intellectual and archi- for institutions with accumulated wealth. Archi- tectural explorations was his question on “the faith tecture schools fulfilled the demand of labor with in HOW and ignorance of WHY”1. graduates skilled in visualization tools and seem- ingly endless computer generated designs. Though As a founding member of TEAM X in 1954, through the acceptance of climate changes has introduced the turbulent 1960s and the following decades, sustainability design into the practices and curricu- De Carlo established himself as an insightful and lums, there is still an unfocused response to the es- eloquent critic of architecture as commodity and calating environmental challenges.