Comunicare Lo Spazio, Collocare La Storia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kiepert's Maps After Robinson and Smith
Haim Goren, Bruno Schelhaas Kiepert’s Maps after Robinson and Smith: Revolution in Re-Identifying the Holy Land in the Nineteenth Century Summary In the long history of Palestine research one interesting devel- aus den USA stammende Theologe Edward Robinson in Be- opment has to be noted. In the 19th century the Holy Land gleitung des Missionars Eli Smith eine Reise durch das Hei- was ‘rediscovered’, leading to the detailed use of all existing lige Land. Ihre Vorreiterrolle in der Erforschung des Heili- sources, the foremost being the Scriptures. The US theologian gen Landes und die ausführliche Rekonstruktion der Bibel als Edward Robinson, accompanied by the missionary Eli Smith, historisch-geographische Quelle wurde von ihren Zeitgenos- traveled in the Holy Land in 1838. The pioneering role in Holy sen anerkannt und stellte einen Meilenstein auf dem Weg der Land research, the detailed reconstruction of the Scriptures Palästinaforschung zur akademischen Disziplin dar. Ergebnis as a historical-geographical source was accepted by contempo- der Reise war ein umfassendes dreibändiges Werk, das mehre- raries – a milestone in the process of establishing Palestine re- re Karten des jungen Kartographen Heinrich Kiepert enthielt. search as a modern academic discipline. The voyage yielded a Mit diesen Karten wurde ein neues Narrativ im historisch- detailed, three-volume work, including various maps drawn by geographischen Diskurs eingeführt, das zu einer neuen Iden- the young cartographer Heinrich Kiepert. These maps estab- titätskonstruktion des Heiligen Landes führte. lished a new narrative within the historical-geographical dis- Keywords: Palästinaforschung; Kartographiegeschichte; Ed- course, leading to a new construction of the identity of the ward Robinson; Eli Smith; Heinrich Kiepert Holy Land. -

High-Elevation Limits and the Ecology of High-Elevation Vascular Plants: Legacies from Alexander Von Humboldt1
a Frontiers of Biogeography 2021, 13.3, e53226 Frontiers of Biogeography REVIEW the scientific journal of the International Biogeography Society High-elevation limits and the ecology of high-elevation vascular plants: legacies from Alexander von Humboldt1 H. John B. Birks1,2* 1 Department of Biological Sciences and Bjerknes Centre for Climate Research, University of Bergen, PO Box 7803, Bergen, Norway; 2 Ecological Change Research Centre, University College London, Gower Street, London, WC1 6BT, UK. *Correspondence: H.J.B. Birks, [email protected] 1 This paper is part of an Elevational Gradients and Mountain Biodiversity Special Issue Abstract Highlights Alexander von Humboldt and Aimé Bonpland in their • The known uppermost elevation limits of vascular ‘Essay on the Geography of Plants’ discuss what was plants in 22 regions from northernmost Greenland known in 1807 about the elevational limits of vascular to Antarctica through the European Alps, North plants in the Andes, North America, and the European American Rockies, Andes, East and southern Africa, Alps and suggest what factors might influence these upper and South Island, New Zealand are collated to provide elevational limits. Here, in light of current knowledge a global view of high-elevation limits. and techniques, I consider which species are thought to be the highest vascular plants in twenty mountain • The relationships between potential climatic treeline, areas and two polar regions on Earth. I review how one upper limit of closed vegetation in tropical (Andes, can try to -

Steve Kemper's a Labyrinth of Kingdoms
Comptes Rendus Méga-Tchad - Mega-Chad Book Reviews http://lah.soas.ac.uk/projects/megachad/comptesrendus.html KEMPER, Steve. 2012. A Labyrinth of Kingdoms - 10,000 Miles through Islamic Africa. New York and London: W. W. Norton & Company. 396p. Book review: Gerhard Muller-Kosack - www.mandaras.info Kemper's interesting book is about the German scientific explorer Heinrich (Henry) Barth who travelled in the mid 19th century for the British government for over five years from Tripoli to the Kingdom of Bornu to the south of Lake Chad and beyond, as far as Timbuktu. The book also describes how, on his return to Europe, Barth failed to receive satisfying recognition. The book, meant as a long overdue English biography, appears to be well researched and is very well written but is obviously aiming for a general rather than a academic readership. This manifests itself in the fact that the main text, full of biographical and other historical details, is completely unreferenced. However, Kemper has produced a separate note section in which he tells us what his sources were for each chapter. It certainly feels that he did read most of the relevant English materials on Barth, as this is also visible in his selected bibliography which includes not only published but also archived materials. Kemper also familiarised himself with African explorers contemporary to Barth not only to contrast and appreciate Barth's achievements but also to assess Barth's style and influence in the context of the general trend of the other 19th century English literature on the exploration of Africa. -

CONCEPTS and TRENDS in GEOGRAPHY UNIT -II Modern
CONCEPTS AND TRENDS IN GEOGRAPHY UNIT -II Modern schools-German,British,French and Americans-Foundations of Scientific Geography-Founders of Modern Geographical Thought-Alexander von Humboldt,Carl Ritter,Vidal de la Blache,Jean Brunes,Mackinder,W.M.Davis,and E.C.Semple The Foundation of Modern Scientific Geography in Ancient Greek The foundation of modern scientific geography appears to have been laid by the ancient Greek scholars. It was the Greek scholars who tried to distinguish between kenos (meaning void) and cosmos (i.e. universe conceived as a system of harmoniously related parts). Although the roots of the ancient Greek scholarship in the development of geographical ideas reach back to the observations, measurements and generalisations of the ancient Egyptians, the Phoenicians and the Mesopotamians, its organisation in the form of concepts or paradigm was essentially the achievements of Herodotus, Plato, Aristotle, Eratosthenes and Starbo. Both literary and mathematical traditions can be traced in the works of Greek philosophers. They produced topographical description of places in the known world, discussing both natural conditions and the culture of the inhabitants. Greek sailors of the 8th century BC could distinguish four kinds of winds and their directions. The town of Miletus on the eastern side of Aegean Sea emerged as the centre of geographic philosophy. It was basically a commercial centre which received reports on Egyptian geometry, Sumerian algebra and Assyrian astronomy. Thales was the first among Greek scholars to be concerned about, measurements and locations of things on the face of the earth during the 7th and 6th centuries BC. Anaximander introduced a Babylonian instrument, gnoman which made possible a variety of observations regarding relative positions of celestial bodies. -
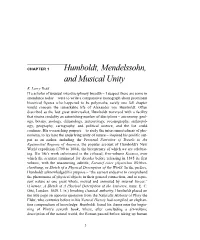
Humboldt, Mendelssohn, and Musical Unity R
CHAPTER 1 Humboldt, Mendelssohn, and Musical Unity R. Larry Todd If a scholar of unusual interdisciplinary breadth – I suspect there are some in attendance today – were to write a comparative monograph about prominent historical figures who happened to be polymaths, surely one full chapter would concern the remarkable life of Alexander von Humboldt. Often described as the last great universalist, Humboldt traversed with a facility that strains credulity an astonishing number of disciplines – astronomy, geol- ogy, botany, zoology, climatology, meteorology, oceanography, anthropol- ogy, geography, cartography, and political science, and the list could continue. His overarching purpose – to study the interconnectedness of phe- nomena, to lay bare the underlying unity of nature – inspired his prolific out- put as an author, including the Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of America, the popular account of Humboldt’s New World expedition (1799 to 1804), the bicentenary of which we are celebrat- ing. His life’s work culminated in the colossal, five-volume Kosmos, over which the scientist ruminated for decades before releasing in 1845 its first volume, with the unassuming subtitle, Entwurf einer physischen Weltbes- chreibung, or Sketch of a Physical Description of the World. In the preface, Humboldt acknowledged his purpose – “the earnest endeavor to comprehend the phenomena of physical objects in their general connection, and to repre- sent nature as one great whole, moved and animated by internal forces.” (Cosmos: A Sketch of A Physical Description of the Universe, trans. E. C. Otté, London, 1849, I, ix.) Invoking classical authority, Humboldt placed on the title page an apposite quotation from the Naturalis Historia of Pliny the Elder, who centuries before in his Natural History had compiled an elephan- tine compendium of knowledge. -

“The Silk Road”?
Did Richthofen Really Coin “the Silk Road”? Matthias Mertens here is little doubt that Ferdinand von the person who first conceived of a significant TRichthofen, the famous German geographer, word or thing has been crucial for the evolution of played an important role in conceptualizing and modern Western public consciousness” (2014: 417). popularizing the idea of a “silk road.” According to Because of this collective tendency, “intellectual historian Daniel C. Waugh, “almost any discussion innovators and technological inventors have been of the Silk Road today will begin with the obliga singled out and showered with praise” (417). tory reminder that the noted German geographer Richthofen is an excellent example of the individu [Ferdinand von Richthofen] had coined the term, alizing drive described by James and Stenger. As an even if few seem to know where he published it intellectual innovator, Richthofen certainly did and what he really meant” (2007: 1). But did much to consolidate the concept of “the silk road” Richthofen really invent the phrase “the Silk Road,” and introduce it to a broader, albeit still academic, either in its singular (die Seidenstrasse) or plural audience. But was Richthofen truly the sole inven (Seidenstrassen) usages? The German archaeolo tor of the term? gist and geographer Albert Herrmann certainly With the aid of electronic search engines, a ques thought so. In 1910, Herrmann boldly declared that tion like this is now much easier to answer. If “it was he [Richthofen] who introduced into litera Richthofen invented the term in 1877, as is often ture the apt name silk roads [Seidenstrassen]” asserted, then it should not appear in books or ar (Herrmann 1910: 7). -

An Early Measuring of the Holy City, Forgotten for Over a Century: Westphal's Jerusalem Map of 1825
Vol. 146, No. 1 · Research article An early measuring of the Holy City, DIE ERDE forgotten for over a century: Journal of the Geographical Society Westphal’s Jerusalem map of 1825 of Berlin Haim Goren1, Bruno Schelhaas2 1 Tel-Hai College, Upper Galilee 1208000, Israel, [email protected] 2 Leibniz Institute for Regional Geography, Archiv für Geographie, Schongauerstr. 9, 04328 Leipzig, Germany, [email protected] Manuscript submitted: 10 July 2014 / Accepted for publication: 3 November 2014 / Published online: 25 March 2015 Abstract In 1822 and 1823 three young German scholars, Peter von Medem, Gustav Parthey and Johann Heinrich West- phal, undertook a research expedition to Egypt and Palestine. One major result of this journey was a very ac- curate map of Jerusalem: “Jerusalem und seine nächsten Umgebungen” (“Jerusalem and its environs”), published in 1825 by Heinrich Berghaus in his journal Hertha. Together with Franz Wilhelm Sieber’s plan of 1818 this map belongs to the very first “modern” maps of Jerusalem, based on measurements and new scientific research results. In addition, the sketches, as well as extracts from Parthey’s and von Medem’s diaries, formed the mate- rial for Berghaus’ memoir to his Map of Syria in 1835. This article deals with the background of the voyage, the production, publication and reception of the map, and the complex network of actors involved, based on recently discovered archival sources. Moreover, the map became forgotten in the 19th and 20th centuries. Apart from Berghaus, the map was actually never used by later cartographers of Jerusalem and no longer mentioned in stud- ies concerning the history of the city’s modern cartography. -

Carl Schurz Was in the Pledge Class of 1870
Appendix Gamma2: The Breslau Intellectual Line Connecting brothers of Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University, tracing their fraternal Big Brother/Little Brother line to the tri-Founders and their Pledges . Brother Carl Schurz was in the Pledge Class of 1870. . Carl Schurz was friends with Gottfriend . Felix Mendelssohn studied under Kinkel years . Carl Friedrich Zelter . . Gottfried Kinkel was spouse to . Carl Friedrich Zelter studied under Carl Johanna Kinkel. Friedrich Christian Fasch . . Johanna Kinkel studied music under . Carl Philipp Emanuel Bach studied Jewish musician, under Sylvius Leopold Weiss. Felix Mendelssohn . Below we present short biographies of the Breslau intellectual line of the Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University. “Who defends the House.” We begin with brother Carl Schurz (1870), tapped into Phi Kappa Psi at Cornell in the first class after the Founding: Carl Schurz (March 2, 1829 – May 14, 1906) was a German revolutionary, American statesman and reformer, and Union Army general in the American Civil War. He was also an accomplished author, newspaper editor and journalist, who in 1869 became the first German-born American elected to the United States Senate. His wife Margarethe Schurz and her sister Bertha von Ronge were instrumental in establishing the kindergarten system in the United States. During his later years, Schurz was perhaps the most prominent Independent The University of Bonn in American politics, noted for his high principles, his avoidance of political partisanship, and his moral conscience. Brother Schurz is famous for saying: "Our country right or wrong. When right, to be kept right; when wrong, to be put right." Many streets, schools, and parks are named in honor of him, including New York City's Carl Schurz Park. -

Ziel Ist Es Sowohl Die Hintergründe Von Reisen Zu Beleuchten
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Reiseberichte von Frauen im 19. Jahrhundert. Eine Analyse des Werkes von Ida Pfeiffer und ihrer Legitimationsstrategien als weibliche Autorin“ Verfasserin Katharina Lehmann Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Juli 2009 Matrikelnummer: 9805972 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A301 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswiss. Betreuerin: Vertragsprofessorin Dr. Susanne Kinnebrock INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 4 1.1. Vorwort 4 1.2. Themenwahl 5 1.3. Thematische Einbettung 5 1.4. Aktueller Forschungsstand 7 1.5. Aufbau der Arbeit 9 1.6. Methode 10 1.7. Zielsetzung und Forschungsfragen 14 1.7.1. Legitimationsstrategien reisender Frauen 15 1.7.2. Kommunikations- und Darstellungsformen von Fremde in Reiseberichten des 19. Jahrhunderts 16 2. DER REISEBERICHT 17 2.1. Begriffsdefinition 17 2.2. Verschiedene Grundtypen des Reiseberichtes 19 2.3. Der Reisebericht als Spezialform der Reportage? – Reiseberichte als Einstieg in den Journalismus 22 2.4. Wahrnehmung von Fremde 25 2.4.1. Das Fremdbild im Wandel der Zeit 27 2.4.2. Strategien im Umgang mit dem Fremden 29 2.4.3. Geschlechtsspezifische Wahrnehmung des Fremden 30 3. DIE GESELLSCHAFT DES 19. JAHRHUNDERTS 32 3.1. Das soziale Gefüge 33 3.2. Das Weiblichkeitsideal und seine Werte 39 4. REISENDE FRAUEN IM 19. JAHRHUNDERT 47 4.1. Gesellschaftlicher Status von Reisen 47 4.2. Für Frauen anerkannte Reisen 49 5. FRAUEN ALS SCHRIFTSTELLERINNEN 52 5.1. Frauen als Reiseschriftstellerinnen 52 - 2 - 5.2. Bekannte Reiseschriftstellerinnen 59 5.2.1. Anne Blunt 59 5.2.2. -
Influences of 'Kosmos' in 'Earth and Man'
CHAPTER 30 Influences of ‘Kosmos’ in ‘Earth and Man’ Philip K. Wilson In January and February 1849, a newly emigrated European natural philoso- pher, Arnold Guyot, delivered a series of twelve lectures before the Lowell Institute in Boston. These “enormously popular” lectures introduced several hundred listeners to a new depth of geographical understanding.1 For in these lectures, Guyot expanded the view of geography from a descriptive gazetteer of places and chronology of discovery to an all encompassing view of geog- raphy as “the mutual [inter]actions of . different portions of physical nature upon each other . the perpetual play of which . might be called the life of the globe.”2 Although the newly arrived Guyot was, beyond his investigations into glacial motion, still a relatively unknown figure in the world of science, his lectures attracted many New England savants including Edward Everett, Henry Wadsworth Longfellow, Nathaniel Hawthorne, Horace Mann, Benja- min Pierce, George Ticknor, and Cornelius Conway Felton, the Elliot Profes- 1. Antonello Gerbi, The Dispute of the New World: A History of a Polemic, 1750-1900 (Pittsburgh, PA; University of Pittsburgh Press, 1973), p. 525. 2. Arnold Guyot, Earth and Man: Lectures on Comparative Physical Geography, in its Relation to the History of Mankind, 2nd ed., rev., (Boston: Gould, Kendall and Lincoln, 1849), p. 21. For relatively recent assessments of Guyot, see especially Edith Ferrell, “Arnold Henry Guyot 1807-1884,” Geographers: Biobibliographical Studies 5 (1981): 63-71; George Kish, “Carl Ritter’s Influence on American Geography,” in Karl Lenz (ed) Carl Ritter – Geltung und Deutung (Berlin: Dietrich Reimer, 1981), pp. -

Friedrich Schnurrer's 'Charte Uber Die Geographische Ausbreitung Der Krankheiten' (1827)
Chapter 10 The first Global Map of the Distribution of Human Diseases: Friedrich Schnurrer's 'Charte Uber die geographische Ausbreitung der Krankheiten' (1827) RAINER BROMER The practice of global cartographic representation of diseases dates from the first third of the nineteenth century, that is, from a time when, in the context of large- scale exploration of the physical world, naturalists such as Alexander von Humboldt (1769-1859) devised the conceptual means for such visual representation, namely, the technique of isotherms.' By means of these, a coherent, geographical distribution of physical parameters could be visualized. Leonhard Ludwig Finke's (1747-1837) early, three-volume Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie (Essay on General Medico-Practical Geography) was not accompanied by any cartographic representations (although he may have attempted such a map).2 Yet disease maps were published before 1830, the year commonly associated with the emergence of a widespread interest in medical geography, when a cholera epidemic threatened Europe.3 In 1827, the Swabian physician Friedrich Schnurrer (1784-1833), Amtsarzt (public health officer) in Vaihingen on the Enz (near Stuttgart), presented what is believed to be the first global 'Charte iiber die geographische Ausbreitung der Krankheiten' (Map of the geographical Distribution of Diseases).4 The map is here interpreted as Rainer Bromer, Cultural History Group, University of Aberdeen, Old Brewery, Aberdeen AB24 3UB, Scotland. ' See Nicolaas A Rupke, 'Humboldtian Medicine', Medical History, 1996, 40: 293-3 10. 2L L Finke, Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie, 3 vols. Leipzig, Weidmann, 1792-5. See also Frank A Barrett, 'Finke's 1792 Map of Human Diseases: The First World Disease Map?', Social Science and Medicine, 2000, 50: 915-21. -

HUMBOLDT and the MODERN GERMAN UNIVERSITY an Intellectual History
HUMBOLDT AND THE MODERN GERMAN UNIVERSITY An intellectual history JOHAN1 ÖSTLING Helena Ifill HUMBOLDT AND THE MODERN GERMAN UNIVERSITY Humboldt and the modern German university An intellectual history JOHAN ÖSTLING Translation: Lena Olsson Lund University Press Copyright © Johan Östling 2018 The right of Johan Östling to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. Lund University Press The Joint Faculties of Humanities and Theology P.O. Box 117 SE-221 00 LUND Sweden http://lunduniversitypress.lu.se Lund University Press books are published in collaboration with Manchester University Press Lund University Press gratefully acknowledges the generous financial assistance of Riksbankens Jubileumsfond, the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, which funded the translation and most of the production costs of this volume. First published by Atlantis, Stockholm, in 2016, as Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tysklands historia ISBN 978-91-7353-856-5 ISBN 978-91-983768-0-7 hardback ISBN 978-91-983768-1-4 open access First published 2018 This electronic version has been made freely available under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND) licence. A copy of the licence can be viewed at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ The publisher has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for any external or third-party internet websites referred to in this book, and does not guarantee that any content on such websites