Forme Amministrative E Scelte Linguistiche Nelle Epigrafi E Nelle Monete Della Sicilia Romana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From #13 to #15
Plant Sociology 57(1) 2020, 65–74 | DOI 10.3897/pls2020571/07 Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV) New national and regional Annex I Habitat records: from #13 to #15 Lorenzo Gianguzzi1, Simonetta Bagella2, Giuseppe Bazan3, Maria Carmela Caria2,4, Bruno Enrico Leone Cerabolini5, Alice Dalla Vecchia6, Giovanni Rivieccio4, Rossano Bolpagni6 1 Department Agricultural, Food and Forest Sciences - University of Palermo, Viale delle Scienze Ed. 4, I-90128, Palermo, Italy 2 Department of Chemistry and Pharmacy - University of Sassari, Via Piandanna 4, I-07100, Sassari, Italy 3 Department of Biological, Chemical, and Pharmaceutical Sciences and Technologies - University of Palermo, via Archirafi 18, I-90123, Palermo, Italy 4 Desertification Research Centre - University of Sassari, Via de Nicola - 07100, Sassari, Italy 5 Department of Biotechnologies and Life Sciences - Insubria University, Via J.H. Dunant 3, I-21100, Varese, Italy 6 Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability - University of Parma, Parco Area delle Scienze 11/a, I-43124, Parma, Italy Corresponding author: Giovanni Rivieccio ([email protected]) Subject editor: Daniela Gigante ♦ Received 29 May 2020 ♦ Accepted 12 June 2020 ♦ Published 3 July 2020 Abstract New data on the distribution of the Annex I Habitats 3160, 7210* and 9320 are reported in this contribution. In detail, 24 new occur- rences in Natura 2000 Sites are presented and 42 new cells in the EEA 10 km x 10 km Reference grid are added. The new data refer to Italy and in particular to the Administrative Regions Lombardy, Sardinia, and Sicily. Keywords 3160, 7210*, 9320, biodiversity, conservation, 92/43/EEC Directive, Italy, vegetation Introduction synthetic overview of the newly recorded occurrences is provided in Table 1. -

Defining and Perceiving Peoples in the Chronicles of Norman Italy" (2011)
Western Michigan University ScholarWorks at WMU Master's Theses Graduate College 6-2011 "Videbantur Gens Effera": Defining and erP ceiving Peoples in the Chronicles of Norman Italy Jesse Hysell Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses Part of the European History Commons Recommended Citation Hysell, Jesse, ""Videbantur Gens Effera": Defining and Perceiving Peoples in the Chronicles of Norman Italy" (2011). Master's Theses. 394. https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/394 This Masters Thesis-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. "VIDEBANTUR GENS EFFERA": DEFINING AND PERCEIVING PEOPLES IN THE CHRONICLES OF NORMAN ITALY by Jesse Hysell A Thesis Submitted to the Faculty ofThe Graduate College in partial fulfillment ofthe requirements for the Degree of Master ofArts Department of History Advisor: Luigi Andrea Berto, Ph.D. Western Michigan University Kalamazoo, Michigan June 2011 "VIDEBANTUR GENS EFFERA": DEFINING AND PERCEIVING PEOPLES IN THE CHRONICLES OF NORMAN ITALY Jesse Hysell, M. A. Western Michigan University, 2011 The goal ofthis project is to analyze the ways different cultural groups in Sicily and southern Italy were depicted in a set ofhistorical texts associated with the Norman takeover ofthose regions in the eleventh and twelfth centuries. To achieve that aim, I consider social vocabulary applied to three distinct peoples (native Italians, Greeks, and Muslims) in five sources written by Amatus ofMontecassino, Geoffrey Malaterra, William ofApulia, Alexander ofTelese, and Hugo Falcandus. -

ANCIENT TERRACOTTAS from SOUTH ITALY and SICILY in the J
ANCIENT TERRACOTTAS FROM SOUTH ITALY AND SICILY in the j. paul getty museum The free, online edition of this catalogue, available at http://www.getty.edu/publications/terracottas, includes zoomable high-resolution photography and a select number of 360° rotations; the ability to filter the catalogue by location, typology, and date; and an interactive map drawn from the Ancient World Mapping Center and linked to the Getty’s Thesaurus of Geographic Names and Pleiades. Also available are free PDF, EPUB, and MOBI downloads of the book; CSV and JSON downloads of the object data from the catalogue and the accompanying Guide to the Collection; and JPG and PPT downloads of the main catalogue images. © 2016 J. Paul Getty Trust This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042. First edition, 2016 Last updated, December 19, 2017 https://www.github.com/gettypubs/terracottas Published by the J. Paul Getty Museum, Los Angeles Getty Publications 1200 Getty Center Drive, Suite 500 Los Angeles, California 90049-1682 www.getty.edu/publications Ruth Evans Lane, Benedicte Gilman, and Marina Belozerskaya, Project Editors Robin H. Ray and Mary Christian, Copy Editors Antony Shugaar, Translator Elizabeth Chapin Kahn, Production Stephanie Grimes, Digital Researcher Eric Gardner, Designer & Developer Greg Albers, Project Manager Distributed in the United States and Canada by the University of Chicago Press Distributed outside the United States and Canada by Yale University Press, London Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: J. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting
FIBULAE OF THE NINTH THROUGH SEVENTH CENTURIES BC IN CENTRAL ITALY By JENNIFER M. HAMBLETON A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF FLORIDA 2008 1 © 2008 Jennifer M. Hambleton 2 To my mom for the time we spent together in Paris and our shared love of art and history. 3 ACKNOWLEDGMENTS Sincere appreciation is given to Dr. Barbara Barletta for her guidance throughout my years of graduate study, but especially in researching the Italic fibula. Gratitude is expressed to Dr. Robin Poynor for his helpful comments and suggestions on my thesis. To my family and friends whose encouragement has meant so much, thank you. Your constant support of my education has inspired me. I would like to express my appreciation to the library staff at the University of Florida for their hard work in helping me to obtain items that were not readily accessible. Special acknowledgement is given to Janice Kahler of the University of Florida interlibrary loan staff for her effort in overseeing the delivery of items that were requested for this thesis. I want to recognize Jennifer Testa for her help with the Italian translations. Finally, I thank Dr. Hartigan and Dr. Eaverly, who first sparked my interest in the ancient world as an undergraduate while studying architecture. 4 TABLE OF CONTENTS page ACKNOWLEDGMENTS ...............................................................................................................4 LIST OF FIGURES .........................................................................................................................7 -

Contrada Agnese Project (CAP)
The Journal of Fasti Online (ISSN 1828-3179) ● Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica ● Palazzo Altemps, Via Sant’Appolinare 8 – 00186 Roma ● Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 ● http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org Preliminary Report on the 2018 Season of the American Excavations at Morgantina: Contrada Agnese Project (CAP) Christy Schirmer – D. Alex Walthall – Andrew Tharler – Elizabeth Wueste – Benjamin Crowther – Randall Souza – Jared Benton – Jane Millar In its sixth season, the American Excavations at Morgantina: Contrada Agnese Project (CAP) continued archaeological investigations inside the House of the Two Mills, a modestly-appointed house of Hellenistic date located near the west- ern edge of the ancient city of Morgantina. This report gives a phase-by-phase summary of the significant discoveries from the 2018 excavation season, highlighting the architectural development of the building as well as evidence for the various activities that took place there over the course of its occupation. Introduction The sixth season of the American Excavations at Morgantina: Contrada Agnese Project (CAP) took place between 25 June and 27 July 20181. Since 2014, the focus of the CAP excavations has been the House of the 1 Our work was carried out under the auspices of the American Excavations at Morgantina (AEM) and in cooperation with authori- ties from the Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali and Parco Archeologico Regionale di Morgantina. We would like to thank Prof. Malcolm Bell III and Prof. Carla Antonaccio, Directors of the American Excavations at Morgantina, for their permission and constant encouragement as we pursue this project. -

WWII CAMPAIGN in NORTH AFRICA, SICILY and ITALY 2021
RESPONSIBILITY: Valor Tours, Ltd. acts only as an agent in providing all the services in connection with the tour described in this brochure, and cannot assume responsibility for injury, death, damage or loss due to delays, mechanical defects or failure of any nature aboard aircraft, buses, ships, ship's tenders or zodiacs, or any other means of conveyance, accommodation, or other services resulting directly or indirectly from any acts of God, dangers incident to the sea, fire, breakdown of machinery or equipment, acts of government, other authorities de jure or de facto, wars (whether declared or not), hostilities and civil disturbances, acts of terrorism, strikes, riots, thefts, pilferage, PRESENTS… epidemics, quarantine, medical or customs regulations or procedures, defaults, delays or cancellations, or changes from any causes beyond our control, or any loss or damage resulting from improperly issued passports, visas, travel documents, and that neither we nor any of our affiliates shall become WWII CAMPAIGN in liable for any additional expenses of liability sustained or incurred by a tour member as a result of the foregoing causes. The airlines concerned are not to be held responsible for any act or omission or events during the time the passenger is not aboard the aircraft or conveyance. The passenger contract NORTH AFRICA, SICILY in use shall constitute the sole contract between the carrier and the purchaser of the tour and/or the passenger and the carrier. The right is reserved, should the circumstances warrant it, to alter the AND ITALY 2021 itinerary or the sequence of places visited. The right is reserved to substitute hotels for other hotels of a similar category. -

La Necrópolis De Cozzo Delle Giummare (Noto-Siracusa, Sicilia Oriental)
LA NECRÓPOLIS DE COZZO DELLE GIUMMARE (NOTO-SIRACUSA, SICILIA ORIENTAL) M.a ENCARNA SANAHUJA YLL M.a DEL VILAR VILA BOTA La necrópolis del Cozzo delle Giummare y la de la Grotta del Murmuro, situadas en las laderas del Monte Finocchito, pertenecen a dos pequeños caseríos del arrabal. Fueron descubiertas por Paolo Orsi a pocos kilómetros de la cumbre del monte - donde estaba asentada la ciudad rodeada de la vasta necrópolis del Finocchito-, precisamente en las laderas meridionales junto a las que transcurre el río Tellaro. Orsi las consideró como necrópolis dependientes de la misma ciudad y estaba convencido de que pertenecían a idéntica época que aquélla, por dos razones fundamentales: a} Estaban separadas de la ciudad por 3 o 4 km. únicamente. b} La mayoría de los materiales de estos cementerios pueden englobarse dentro de la llamada Civilización o Cultura del Finocchito (730-650 a. de J. C.). La necrópolis del Cozzo delle Giummare, denominada así por la Chamerops humilis, que crece allí frecuentemente, ocupa la parte extrema de un contrafuerte poco ondulado. Consta de treinta sepul turas relacionadas con un pequeño hábitat que debía existir en una planicie situada a mayor altura, la cual dista 2,5 km. de la cúspide de la montaña. Orsi, a través de un examen superficial de las sepulturas, creyó que pertenecían a la cultura de Casteluccio (primer período de Orsi); sin embargo, no sabía cómo conciliar con esta hipótesis la presencia de pequeños bronces típicos de la fase IV de Pantálica (tercer pe ríodo de Orsi), recogidos en el mismo lugar por algunos pastores . -

•Œthe Eyes of All Fixed on Sicilyâ•Š Canadaâ•Žs Unexpected Victory
Canadian Military History Volume 22 Issue 3 Article 2 2013 “The Eyes of All Fixed on Sicily” Canada’s Unexpected Victory, 1943 Lee Windsor Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/cmh Part of the Military History Commons Recommended Citation Lee Windsor "“The Eyes of All Fixed on Sicily” Canada’s Unexpected Victory, 1943." Canadian Military History 22, 3 (2013) This Article is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in Canadian Military History by an authorized editor of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. : “The Eyes of All Fixed on Sicily” Canada’s Unexpected Victory, 1943 Soldiers of the 1st Canadian Infantry Division on the road during the advance on Ispica, 12 July 1943. Published4 by Scholars Commons @ Laurier, 2013 1 Canadian Military History, Vol. 22 [2013], Iss. 3, Art. 2 “The Eyes of All Fixed on Sicily” Canada’s Unexpected Victory, 1943 Lee Windsor his year’s seventieth anniversary in the next scheduled Mediterranean Tcommemoration of Canada’s Abstract: Canada’s role in the Battle operation.2 contribution to the 1943 invasion of for Sicily is usually overshadowed The inexperienced and unproven Sicily is a worthy time to reflect on by Anglo-American tensions and 1st Canadian Infantry Division and 1st German assertions that they were the why it matters. Operation Husky, real victors. The green 1st Canadian Canadian Army Tank Brigade were as the Allied collective effort was Division was supposed to play a assigned supporting roles in plans to code-named, constituted the largest supporting role alongside veteran invade Sicily, second to battle-tested international military air, sea and British and American formations, British and American formations land operation in history and turned but found themselves at the centre fresh from victory in North Africa. -

The Hellenistic and Roman Fine Pottery
II The Later 4th and 3rd Centuries BCE 1. Introduction: Fine Pottery in Sicily in the Later 4th and 3rd Centuries BCE The fills associated with the capture of Morgantina by the Romans in 211 BCE cast valuable light on the chronology of Hellenistic Sicilian tablewares. e destruction deposits at Gela (ca. 280 BCE) and a vast series of graves on Lipari (sacked by the Romans in 252 BCE, with most of the graves dated before that event and only a few after it), provide a picture of ceramic development on Sicily during the later 4th century and through the first half of the 3rd century. However, the deposits at Gela are limited in size, and one may also conjecture that the funerary assemblages on Lipari are specialized and do not wholly reflect the range of pottery used in domestic contexts.1 is seems to be demonstrated by appendix 3 below, which correlates the black-gloss shapes from the 3rd-century fills at Morgantina with the shapes commonly found in the graves on Lipari. Enormous numbers of some shapes have been found in the graves, a few examples of other shapes, but no examples of a good number of vase types. Taken together, however, the ceramics from the destructions at Gela, the cemeteries on Lipari, and the late-3rd-century BCE fills at Morgantina provide a reasonably full picture of 3rd-century Sicilian ceramics. There are useful contexts from this period at other sites on Sicily. Tomb assemblages at Assoros north of Enna, Butera near Gela, Montagna di Marzo (ancient Herbessos, south of Morgantina), and Morgantina provide information about -
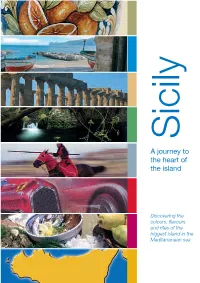
A Journey to the Heart of the Island
Sicily A journey to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea Regione Siciliana POR Sicilia UNIONE EUROPEA Assessorato Turismo, 2000-2006 Fondo Europeo Trasporti e Comunicazioni Misura 4.18 a/b Sviluppo Regionale www.regione.sicilia.it/turismo A journeySicily to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea index Knowing Sicily A paradise made of sea and sun island Treasure oasi Green pag 04 pag 12 pag 22 pag 54 Language ......................... 6 Among shores, The early settlements ..... 24 Regional parks ............... 56 cliffs and beaches .......... 14 Documents and Exchange . 6 The Greek domination .... 26 Reserves and The fishing villages, the protected areas .............. 58 The weather and what The Roman civilization ... 32 fishing tourism and wearing ............................ 6 The Arab-Norman period .. 34 Outdoor sports................ 60 the sea cooking .............. 16 Festivities ......................... 7 Frederick II and the Country tourism Minor Islands and marine Swabians ....................... 38 and baths ...................... 62 Trasportation .................... 7 protected areas: a paradise Medieval Sicily ............... 42 Roads ............................... 8 for diving and snorkelling .. 18 The explosion of Emergency numbers ........ 8 Marina Charters, tourist 02 harbours and the Baroque..................... 45 Geography ........................ 8 aquatic sports ................. 20 Bourbon’s age ................ 48 History ............................ 10 The Florio’s splendour .... 50 The museums ................ 52 The memory of the Island An island opened all the year Master in hosting Maps of the provinces pag 64 pag 76 pag 86 pag 100 The non-material Religious celebrations .... 78 The routes of wine ......... 88 Palermo ........................ 102 heritage register ............. 66 Theatre and Gastronomy ................... -
Chronology of Events – Sicily]
1 May 2020 [CHRONOLOGY OF EVENTS – SICILY] Chronology of Events – Sicily 1943 January 1943 Decision taken at the Casablanca Conference, attended by Allied Heads of Government and Chiefs of Staff, to invade Sicily once operations in North Africa concluded. Invasion of Sicily allocated the codename ‘Husky’. General Dwight D EISENHOWER appointed Supreme Allied Commander and General Sir Harold ALEXANDER as Deputy. 11 February 1943 Supreme Allied Commander appoints General MONTGOMERY to command Eastern Task Force (Force 545) and Lieutenant General PATTON to command the Western Task Force (Force 343). Force 141 (later to become 15th Army Group) formed to assume overall command of operations, commanded by General ALEXANDER. 10 July 1943 Units from the 1st Airlanding Brigade land by glider to capture the Ponte Grande bridge near Syracuse. Only twelve gliders land in the vicinity of the brigade which is captured by troops from the South Staffordshire Regiment. 40 (Royal Marine) and 41 (Royal Marine) Commandos land with difficulty to attack Italian coastal batteries. Units from 82nd (U.S.) Airborne Division land inland of designated beaches. British 8th Army lands in the south east corner of Sicily, with the XIII Corps (5th Infantry Division and 50th (Northumbrian) Infantry Division) on the right flank, near Syracuse; and XXX Corps (51st (Highland) Infantry Division, 1st Canadian Infantry Division and 231st Infantry Brigade) on the left flank. U.S. 7th Army lands on southern shores of Sicily, with 1st U.S. Infantry Division, 45th U.S. Infantry Division under command of II U.S. Corps, with 3rd (U.S.) Infantry Division under direct command of U.S. -

Sicily (Sicilia)
Sicily (Sicilia) General Sicily (Italian: Sicilia) is an autonomous region of Italy, in Southern Italy along with surrounding minor islands, officially referred to as Regione Siciliana. Sicily is located in the central Mediterranean Sea, south of the Italian Peninsula, from which it is separated by the narrow Strait of Messina. Its most prominent landmark is Mount Etna, the tallest active volcano in Europe, and one of the most active in the world, currently 3,329 m (10,922 ft.) high. The island has a typical Mediterranean climate. Administrative Divisions Administratively, Sicily is divided into 9 administrative provinces, each with a capital city of the same name as the province. The areas and populations of these provinces are: Province of Agrigento ......................................... 3,042 km2 ....... pop. 453,594 Province of Caltanissetta .................................... 2,128 km2 ....... pop. 271,168 Province of Catania ............................................ 3,552 km2 .... pop. 1,090,620 Province of Enna ................................................ 2,562 km2 ....... pop. 172,159 Province of Messina ........................................... 3,247 km2 ....... pop. 652,742 Province of Palermo ........................................... 4,992 km2 .... pop. 1,249,744 Province of Ragusa ............................................ 1,614 km2 ....... pop. 318,980 Province of Siracusa ........................................... 2,109 km2 ....... pop. 403,559 Province of Trapani ............................................. 2,460 km2 ....... pop. 436,240 The City of Palermo is the Capital City of the region Small surrounding islands are also part of various Sicilian provinces: Aeolian Islands (Messina), The isle of Ustica (Palermo), Aegadian Islands (Trapani), The isle of Pantelleria (Trapani) and Pelagian Islands (Agrigento). Geography Sicily is the largest island in the Mediterranean Sea. It has a roughly triangular shape, earning it the name Trinacria.