Rodolfo Pallucchini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Marriage Contract in Fine Art
The Marriage Contract in Fine Art BENJAMIN A. TEMPLIN* I. INTRODUCTION ................................................................................ 45 II. THE ARTIST'S INTERPRETATION OF LAW ...................................... 52 III. THE ARNOLFINI MARRIAGE: CLANDESTINE MARRIAGE CEREMONY OR BETROTHAL CONTRACT? .............................. ........................ .. 59 IV. PRE-CONTRACTUAL SEX AND THE LAWYER AS PROBLEM SOLVER... 69 V. DOWRIES: FOR LOVE OR MONEY? ........................ ................ .. .. 77 VI. WILLIAM HOGARTH: SATIRIC INDICTMENT OF ARRANGED MARRIAGES ...................................................................................... 86 VII. GREUZE: THE CIVIL MARRIAGE CONTRACT .................................. 93 VIII.NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURY COMPARISONS ................ 104 LX . C ONCLUSION ..................................................................................... 106 I. INTRODUCTION From the Middle Ages to the Enlightenment, several European and English artists produced paintings depicting the formation of a marriage contract.' The artwork usually portrays a couple-sometimes in love, some- * Associate Professor, Thomas Jefferson School of Law. For their valuable assis- tance, the author wishes to thank Susan Tiefenbrun, Chris Rideout, Kathryn Sampson, Carol Bast, Whitney Drechsler, Ellen Waldman, David Fortner, Sandy Contreas, Jane Larrington, Julie Kulas, Kara Shacket, and Dessa Kirk. The author also thanks the organizers of the Legal Writing Institute's 2008 Summer Writing Workshop -

The Age of Pleasure and Enlightenment European Art of the Eighteenth Century Increasingly Emphasized Civility, Elegance, Comfor
The Age of Pleasure and Enlightenment European art of the eighteenth century increasingly emphasized civility, elegance, comfort, and informality. During the first half of the century, the Rococo style of art and decoration, characterized by lightness, grace, playfulness, and intimacy, spread throughout Europe. Painters turned to lighthearted subjects, including inventive pastoral landscapes, scenic vistas of popular tourist sites, and genre subjects—scenes of everyday life. Mythology became a vehicle for the expression of pleasure rather than a means of revealing hidden truths. Porcelain and silver makers designed exuberant fantasies for use or as pure decoration to complement newly remodeled interiors conducive to entertainment and pleasure. As the century progressed, artists increasingly adopted more serious subject matter, often taken from classical history, and a simpler, less decorative style. This was the Age of Enlightenment, when writers and philosophers came to believe that moral, intellectual, and social reform was possible through the acquisition of knowledge and the power of reason. The Grand Tour, a means of personal enlightenment and an essential element of an upper-class education, was symbolic of this age of reason. The installation highlights the museum’s rich collection of eighteenth-century paintings and decorative arts. It is organized around four themes: Myth and Religion, Patrons and Collectors, Everyday Life, and The Natural World. These themes are common to art from different cultures and eras, and reveal connections among the many ways artists have visually expressed their cultural, spiritual, political, material, and social values. Myth and Religion Mythological and religious stories have been the subject of visual art throughout time. -

Giovanni Gasparro: Revelations of the Human and the Holy by Richard Dellamorte
Giovanni Gasparro: Revelations of the Human and the Holy by Richard Dellamorte In terms of art, Italy could possibly be l’Antico ed il Nuovo Testamento e gli scritti dei santi the richest country in the world. Boasting many famous artists cattolici, Thomas Mann e la letteratura in genere, le altre from Giotto Di Bondone and Sandro Botticelli to Leonardo Da arti come il teatro e la musica, le opere di pittura e scultura Vinci and Masaccio, it seems fairly obvious that even today, del passato e contemporanee.” In addition to biblical there are artists exploring the depths of the extraordinary, scripture, Giovanni finds inspiration from literature, theatre, carving new frontiers in the world of art. In the last few music, and of course, art, past and present. However, months, I’d quickly become captivated and enamoured with Gasparro maintains that sensorial reality and nature prove the work of Italian artist, Giovanni Gasparro, and was lucky to be the main source of inspiration for him, stimulating his enough to speak with him about his work. creative and artistic muse. Born in Bari, Gasparro had aspirations of becoming an artist Delving deeper into the psyche of Gasparro, one can ever since he was a child, realizing a strong affinity for envision the vast recesses of Italian history and art, fusing brushes and crayons, putting them to paper. He spent hours this amalgamation of the spiritual and the aesthetic. admiring works by Gaspare Traversi and Michelangelo, and Gasparro says his interest lies in the impulses governing according to Giovanni, both living in such a culturally rich the human soul — “mi interessa indagare le pulsioni che country as Italy, and experiencing so much artistic influence agitano l’umano.” Many of Giovanni’s works depict naked, has helped shape him as an artist: “è stato determinante twisted bodies and intertwined limbs; one reoccurring il fatto che vivessi in Italia, fra capolavori assoluti di tutti i element of his art includes imagery of hands — sometimes tempi.” cascading several hands in gesture across the canvas, as if in movement. -

Lettera Da San G Iorgio
Lettera da San Giorgio Lettera da San Year XIX, number 37. Six-monthly publication. September 2017 – February 2018 Spedizione in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 DCB VE. Tassa pagata / Taxe perçue PROGRAMMES (SEPTEMBER – FEBRUARY 2017) 12 MAY 2017 – VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE 30 NOV 2018 Le Stanze del Vetro Installation Qwalala by Pae White 1 SEP – 15 NOV 2017 VENICE, PALAZZO CINI GALLERY AT SAN VIO Exhibition Lyda Borelli: A Leading Lady of the 20th Century 4 SEP VENICE, TEATRO LA FENICE 19, 21, 22 SEP VENICE, LA CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI 8 NOV 2017 VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE Cinema Series Lyda Borelli: Film Diva 9 SEP – 16 DEC 2017 VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE Lo Squero Auditorium Concert Season 2017 10–17 SEP 2017 VENICE, VARIOUS VENUES The Venice Glass Week 11 SEP 2017 – VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE 7 JAN 2018 Le Stanze del Vetro Exhibition Vittorio Zecchin: Transparent Glass for Cappellin and Venini 12–15 SEP 2017 VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE Dialoghi di San Giorgio What’s the Body of the Body Politic? Sovereignty, Identity, Ecology 21–22 SEP 2017 VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE Thirteenth World Conference on the Future of Science The Lives to Come 4, 10, 18 OCT 2017 VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE Books at San Giorgio 9–13 OCT 2017 VENICE, ISLAND OF SAN GIORGIO MAGGIORE The Egida Sartori and Laura Alvini Early Music Seminars Roman de Fauvel. Music and Corruption in the Paris of Philip the Fair. -

La Vita, La Fortuna Critica, I Capolavori Giuseppe Bonito Nacque A
La vita, la fortuna critica, i capolavori Giuseppe Bonito nacque a Castellammare di Stabia, terzo dei dodici figli di Saverio e di Anastasia Grosso e fu battezzato in quella cattedrale il 2 novembre 1707. Ancora fanciullo, entrò nella bottega di Francesco Solimena che dominava la scena artistica di Napoli. Fu con il Vanvitelli tra i protagonisti della scena artistica napoletana negli anni del regno di Carlo, della reggenza del Tanucci e poi sotto Ferdinando IV, conseguendo incarichi pubblici prestigiosi ed un grande successo tra i committenti. Peppariello diventerà Cavaliere di grazia, pittore di corte, professore dell’Accademia di Belle Arti e direttore a vita della medesima. Una figura che ebbe un ruolo rilevante nel mondo dell’arte ufficiale e non fu immune, come affermava la Lorenzetti, dalla taccia di soverchia invadenza. La critica dell'Ottocento e del primo Novecento ha apprezzato nel Bonito solo il pittore di genere, che come tale avrebbe precorso il realismo e valorizzato le virtù borghesi al contrario, la critica recente riconosce in lui il custode della più schietta tradizione pittorica neoveneta, che ha contribuito a ritardare sino ai limiti del possibile l'avvento del neoclassicismo. Dopo un inizio influenzato dalle esperienze puriste del Solimena, verso la fine degli anni Trenta con le tele (040 - 041) per la chiesa della Graziella a Napoli ed in San Domenico a Barletta (037), muovendo dalla svolta di indirizzo pretiano e dalle ultime tele del Giordano, si orientò verso soluzioni di gusto neo barocco, come si evince chiaramente nella splendida Carità (029) nella sacrestia del Monte di Pietà, eseguita nel 1742 e nel bozzetto(031) per la distrutta decorazione della volta della chiesa di Santa Chiara del 1752. -

Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art
Differentia: Review of Italian Thought Number 5 Spring Article 14 1991 The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art David Tabbat Follow this and additional works at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia Recommended Citation Tabbat, David (1991) "The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art," Differentia: Review of Italian Thought: Vol. 5 , Article 14. Available at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia/vol5/iss1/14 This document is brought to you for free and open access by Academic Commons. It has been accepted for inclusion in Differentia: Review of Italian Thought by an authorized editor of Academic Commons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. The Eloquent Eye: Roberto Longhi and the Historical Criticism of Art David Tabbat Bernard Berenson once observed that Vasari's greatest strength as a writer was that sure instinct for narrative and char acterization which made him a worthy heir of Boccaccio. Lest his readers misconstrue this appreciation of Vasari's "novelistic ten dency" as a denigration of his work when judged by purely art historical criteria, Berenson added that the author of the Lives "is still the unrivaled critic of Italian art," in part because "he always describes a picture or a statue with the vividness of a man who saw the thing while he wrote about it." 1 To a remarkable degree, these same observations may aptly introduce the work of Roberto Longhi (1890-1970),2who is often regarded by the Italians themselves (whether specialists or inter ested laymen) as the most important connoisseur, critic, and art historian their country has produced in our century. -

Old Master Paintings Wednesday 30 October 2013 at 1Pm Knightsbridge, London
Old Master Paintings Wednesday 30 October 2013 at 1pm Knightsbridge, London Old Master Paintings Wednesday 30 October 2013 at 1pm Knightsbridge, London Bonhams Enquiries Customer Services Montpelier Street [email protected] Monday to Friday 8.30am to 6pm Knightsbridge +44 (0) 20 7468 8307 +44 (0) 20 7447 7447 London SW7 1HH www.bonhams.com Specialists Please see back of catalogue Head of Sale: for important notice to bidders Viewing Carlotta Mascherpa Sunday 27 October +44 (0) 20 7468 8307 [email protected] Illustrations 11am to 3pm Front cover: Lot 206 (detail) Monday 28 October Back cover: Lot 241 (detail) 9am to 4.30pm Andrew McKenzie Tuesday 29 October +44 (0) 20 7468 8261 [email protected] Live online bidding is 9am to 4.30pm available for this sale Wednesday 30 October Caroline Oliphant Please email [email protected] 9am to 11am +44 (0) 20 7468 8271 with “Live bidding” in the subject [email protected] line 48 hours before the auction Bids to register for this service. +44 (0) 20 7447 7448 David Dallas +44 (0) 20 7447 7401 fax +44 (0) 20 7468 8336 To bid via the internet please visit [email protected] www.bonhams.com Lisa Greaves Please provide details of the lots +44 (0) 20 7468 8325 on which you wish to place bids at [email protected] least 24 hours prior to the sale. New bidders must also provide Poppy Harvey-Jones proof of identity when submitting +44 (0) 20 7468 8308 bids. Failure to do this may result [email protected] in your bids not being processed. -

Thethird Past-Present-Catalogue.Pdf
Past Present: Conversations Across Time Masterpieces from the Kress Collection paired with contemporary work by Alison Hall Creighton Michael Gregory Coates Jonsara Ruth & Lorella Di Cintio Pat Badt & Scott Sherk Pinkney Herbert Sanford Wurmfeld February 22 – May 17, 2015 Allentown Art Museum of the Lehigh Valley Past Present: Conversations Across Time Masterpieces from the Kress Collection paired with contemporary work by Alison Hall Creighton Michael Gregory Coates Jonsara Ruth & Lorella Di Cintio Pat Badt & Scott Sherk Pinkney Herbert Sanford Wurmfeld February 22 – May 17, 2015 Allentown Art Museum of the Lehigh Valley Curator’s Notes Past Present: Conversations Across Time magine a conversation between artists — one a 21st Century world-weary, contemporary artist; and the by Stephen Maine Iother, a Renaissance Master of the 16th Century. What would they have to say to each other? Would this be a dialogue, a lesson, an argument? Past Present establishes conversations between contemporary artists and the Allentown Art Museum’s Samuel H. Kress Collection. Art is always part of a larger conversation between artists and cultures, crossing time and place. The art of the past from all cultures has a direct influence on the creation of art in the present. Regardless of different styles and technologies, art can remain fresh through the ongoing discovery of looking. Nine artists working individually or collectively were invited to study the Kress collection and select a specific painting from it. These contemporary artists have created new works that exist in conversation with their Kress selection. In many cases these contemporary artists use very different tools, techniques and technologies than the Kress masters, but each has identified a common interest that they share with the artists of the past. -

Pittori Napoletani Del Settecento Aggiornamenti Ed Inediti
ACHILLE DELLA RAGIONE PITTORI NAPOLETANI DEL SETTECENTO AGGIORNAMENTI ED INEDITI EDIZIONI NAPOLI ARTE INDICE Prefazione pag. 1 I Sarnelli: una famiglia di pittori napoletani del Settecento » 2 Dipinti da cavalletto di Giacomo Del Po » 13 Lorenzo De Caro un pittore “disubbidiente” del Settecento napoletano » 20 Tommaso Realfonso, detto Masillo » 32 Nicola Malinconico un generista da rivalutare » 37 Evangelista Schiano un solimenesco di seconda battuta » 40 Giacomo Nani pittore napoletano di natura morta » 43 Mariano Nani un figlio d’arte » 49 Elenco delle figure » 51 Elenco delle tavole » 53 Napoli, 30 settembre 2010 Prima edizione In 1a di copertina Lorenzo De Caro, Estasi di San Luigi Gonzaga, Bari collezione Ferorelli In 4a di copertina Evangelista Schiano, Sacra famiglia, Napoli collezione della Ragione 2 Prefazione Il libro raccoglie una serie di articoli di Achille della Ragione riguardanti pittori napoleta- ni del Settecento pubblicati negli ultimi anni su svariate riviste sia cartacee che telematiche. Talune volte si tratta di contributi esaustivi, al limite della monografia, densi di aggiorna- menti e di inediti, corredati da numerose foto, sia a colori che in bianco e nero, che ci permet- tono di conoscere approfonditamente pittori come Evangelista Schiano o i fratelli Sarnelli, ai quali i trattati di storia dell’arte dedicano poche righe frettolose, soprattutto questi ultimi, per quanto già citati dal De Dominici e titolari di una fiorente bottega specializzata in pale d’alta- re, destinate alle chiese del meridione, attiva per oltre sessanta anni, erano a tutt’oggi poco più che dei Carneadi dei quali non si conosceva che il nome e per Francesco nemmeno quello. -

La Natura Morta Napoletana Del Settecento
ACHILLE DELLA RAGIONE LA NATURA MORTA NAPOLETANA DEL SETTECENTO EDIZIONI NAPOLI ARTE INDICE Baldassarre De Caro pag. 3 Giuseppe e Lorenzo De Caro » 9 Nicola Casissa » 12 Tommaso Realfonso » 17 Gaspare Lopez » 22 Giacomo Nani » 28 Mariano Nani » 35 Nicola Malinconico » 37 Francesco Della Questa » 41 Aniello Ascione » 47 Gaetano Cusati » 50 Marco di Caro » 55 Elena Recco »57 Nicola Maria Recco » 60 Onofrio Loth » 64 Domenico Brandi » 68 Giorgio Garri » 70 Francesco e Giuseppe Lavagna » 72 Alberto Lionelli » 74 Luis Melendez » 76 Alessandro (?) Sangiovanni » 78 Mariano Cefis » 79 Figure minori » 80 Anonimi »83 Monogrammisti » 84 Francesco Solimena » 85 Elenco delle tavole » 87 Elenco delle figure » 93 Napoli, 30 novembre 2010 Prima edizione In 1a di copertina Recco Elena, Natura morta di pesci, fiori, frutta, ortaggi e selvaggina Roma antiquario Parenza In 4a di copertina Giacomo Nani, Cestino con ricci, capesante, fichi, olive, pere alici, cipolle e meloni in un contenitore di legno, Roma collezione privata Natura morta napoletana del Settecento La natura morta napoletana è più apprezzata dal mercato antiquariale che dalla critica, più conosciuta dai collezionisti che dal grande pubblico. Essa non raggiunge i fasti del secolo pre- cedente, ma mantiene un livello dignitoso almeno per i primi cinquanta anni, per spegnersi poi senza svilupparsi in esiti di un qualche interesse, ad eccezione forse di Mariano Nani, figlio di Jacopo ed attivo in Spagna fino alle soglie dell’Ottocento e del notevole Mariano Cefis, sco- perto nel corso delle ricerche esperite per la stesura di questo contributo, con i quali si chiude una gloriosa tradizione. Alcuni artisti come Tommaso Realfonso, Nicola Casissa, Gaspare Lopez, Giacomo Nani e Baldassarre De Caro continuano la tradizione locale specializzandosi nel dipingere fiori, frut- ta, pesci, cacciagione, soddisfacendo così le richieste di una vasta committenza, il cui gusto era semplicemente cambiato in linea coi tempi. -
Bernardino Licinio: Portraiture, Kinship and Community in Renaissance Venice
Bernardino Licinio: Portraiture, Kinship and Community in Renaissance Venice by Karine Tsoumis A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto © Copyright by Karine Tsoumis 2013 Bernardino Licinio: Portraiture, Kinship and Community in Renaissance Venice Karine Tsoumis Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto 2013 Abstract Bernardino Licinio was a painter of Bergamasque origin active in Venice from c. 1510 to c. 1550. Licinio was a prolific painter of portraits, concert scenes and religious images for the home and headed a prosperous family workshop. Yet the artist is largely denied importance within the current art historical narrative, being conceived as “minor,” “provincial” or “second- rate.” My dissertation questions the “constructedness” of historical identities and presents the first nuanced understanding of Licinio’s place within Venetian culture. I argue that his status as “minor” is a modern construct rather than a reflection of his contemporaries’ perception. My dissertation inscribes itself within endeavours to “de-centre” the Renaissance conceptually, and is especially indebted to recent studies of material culture that challenge art historical hierarchies and aesthetic biases. The dissertation provides a multilayered reading of Bernardino Licinio’s artistic identity through frameworks that stem from what I consider unique aspects of his practice, while others arise from problems posed by his historiographical reception. The artist’s position between Venice and Bergamo provides the line of enquiry for chapter one, where I engage with the Bergamasque ii community conceived, on the one hand, as a form of historiographical framing, and on the other, as a social reality. -
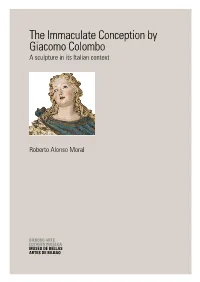
The Immaculate Conception by Giacomo Colombo a Sculpture in Its Italian Context
The Immaculate Conception by Giacomo Colombo A sculpture in its Italian context Roberto Alonso Moral This text is published under an international Attribution-NonCommercial-NoDerivs Creative Commons licence (BY-NC-ND), version 4.0. It may therefore be circulated, copied and reproduced (with no alteration to the contents), but for educational and research purposes only and always citing its author and provenance. It may not be used commercially. View the terms and conditions of this licence at http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/legalcode Using and copying images are prohibited unless expressly authorised by the owners of the photographs and/or copyright of the works. © of the texts: Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa-Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao Photography credits © Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa-Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao: figs. 1, 15, 16 and 17 © Museo del Monasterio de Sancti Spiritu, Toro: fig. 9 © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage: fig. 13 Text published in: Buletina = Boletín = Bulletin. Bilbao : Bilboko Arte Eder Museoa = Museo de Bellas Artes de Bilbao = Bilbao Fine Arts Museum, no. 7, 2013, pp. 163-193. Sponsor: 2 uring the Modern Age, intense political and cultural relations between Spain and the capital of one of its viceroyalties, Naples, provided a major stimulus for the development of art collections and Dpatronage of the arts. The viceroys and their court, ecclesiastics and Spanish merchants resident in the city all played a large part in the shipping of artworks to the homes of the nobility, church chapels and convents. It was a time when galleries and collections of paintings came into their own, a time about which many important essays have been written; this interest is in contrast to the rather vague notions we still hold about the sculptures such people gathered and brought home with the rest of their baggage.