Dufay Guillaume
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Music in the Mid-Fifteenth Century 1440–1480
21M.220 Fall 2010 Class 13 BRIDGE 2: THE RENAISSANCE PART 1: THE MID-FIFTEENTH CENTURY 1. THE ARMED MAN! 2. Papers and revisions 3. The (possible?) English Influence a. Martin le Franc ca. 1440 and the contenance angloise b. What does it mean? c. 6–3 sonorities, or how to make fauxbourdon d. Dunstaple (Dunstable) (ca. 1390–1453) as new creator 4. Guillaume Du Fay (Dufay) (ca. 1397–1474) and his music a. Roughly 100 years after Guillaume de Machaut b. Isorhythmic motets i. Often called anachronistic, but only from the French standpoint ii. Nuper rosarum flores iii. Dedication of the Cathedral of Santa Maria de’ Fiore in Florence iv. Structure of the motet is the structure of the cathedral in Florence v. IS IT? Let’s find out! (Tape measures) c. Polyphonic Mass Cycle i. First flowering—Mass of Machaut is almost a fluke! ii. Cycle: Five movements from the ordinary, unified somehow iii. Unification via preexisting materials: several types: 1. Contrafactum: new text, old music 2. Parody: take a secular song and reuse bits here and there (Zachara) 3. Cantus Firmus: use a monophonic song (or chant) and make it the tenor (now the second voice from the bottom) in very slow note values 4. Paraphrase: use a song or chant at full speed but change it as need be. iv. Du Fay’s cantus firmus Masses 1. From late in his life 2. Missa L’homme armé a. based on a monophonic song of unknown origin and unknown meaning b. Possibly related to the Order of the Golden Fleece, a chivalric order founded in 1430. -

Fulgens Iubar Ecclesiae Dei
Guillaume Du Fay Opera Omnia 02/14 Fulgens iubar ecclesiae Dei Edited by Alejandro Enrique Planchart Marisol Press Santa Barbara, 2011 Guillaume Du Fay Opera Omnia Edited by Alejandro Enrique Planchart 01 Cantilena, Paraphrase, and New Style Motets 02 Isorhythmic and Mensuration Motets 03 Ordinary and Plenary Mass Cycles 04 Proper Mass Cycles 05 Ordinary of the Mass Movements 06 Proses 07 Hymns 08 Magnificats 09 Benedicamus domino 10 Songs 11 Plainsongs 12 Dubious Works and Works with Spurious Attributions © Copyright 2011 by Alejandro Enrique Planchart, all rights reserved. Guillaume Du Fay, Fulgens iubar ecclesiae: 1 02/14 Fulgens iubar ecclesiae - Puerpera pura - Virgo post partum [ ] = Guillaume Du Fay Cantus Ful gens iu bar ec cle si ae de [ ] Contratenor 8 Pu er pe ra, pu ra pa Tenor 8 Tenor secundus 7 i, Pec ca to rum sa lus prom 8 rens, E ni xa re 8 13 ptis si ma, Si pre ci bus qui 8 gem sae cu li, Ti bi non 8 Virgo post partum quem genuit adoravit Tenores isti ter dicuntur: Primo de modo et tempore perfectis minores. Secundo per tertium. Tertio cise per semi de primo. 19 bus cum que fle cti Que as, no bis da, vir 8 fit or ba pa rens Ri tu mens: va 8 D-OO Guillaume Du Fay, Fulgens iubar ecclesiae: 2 25 go be a ta, Ut om nes qui tu ae 8 les sae cu li Vi tam red de re, non nul li 8 31 my ste ri a Pu ri fi ca ti o nis co li mus 8 Sal va ti sunt hoc li mi 8 37 Post tem po ris hu ius cur ri cu 8 te; Das haec me ri to ti tu 8 43 la Sub li me mur san cto rum se di bus. -

Music in the Renaissance Objectives Renaissance Themes
2/9/2017 Music in the Renaissance objectives • two aspects of Renaissance music • Nuper rosarum flores: – “old‐fashioned” isorhythmic motet – symbolism Renaissance themes • back to the ancients • back to nature 1 2/9/2017 Giotto, Ognissanti madonna (1310) Michelangelo, David (1504) 2 2/9/2017 Renaissance themes • back to the ancients – music theory • back to nature – 3rds & 6ths – text setting fall of the Eastern (Byzantine) Empire • 1265 • 1355 • 1450 • Christian scholars flee to Italy • no modern transcriptions of ancient Greek music until 1581 Guillaume Du Fay and Pope Eugenius IV 3 2/9/2017 Cathedral of Florence (3/25/1436) Pantheon, Rome 27 CE Du Fay, Nuper rosarum flores I. The harsh winter [of the Hebraic Law] III. Therefore, sweet parent Having past, roses, And daughter of your son, A recent papal gift, God, virgin of virgins, perpetually adorn To you your devoted The Temple of the grandest structure Populace of Florence petitions Piously and devoutly dedicated That whoever begs for something To you, heavenly Virgin. With pure spirit and body II. Today the vicar IV. Through your intercession Of Jesus Christ and successor And the merits Of Peter, Eugenius, Of your son, their lord, This same most enormous Temple Owing to His carnal torment, With sacred hands It may be worthy to receive And holy oils Gracious benefits and Has deigned to consecrate. Forgiveness of sins. Amen. Guillaume Du Fay, Nuper rosarum flores (1436) [score] • Isorhythmic motet – tenor: Terribilis est locus iste • From mass used to consecrate churches – canon 4 2/9/2017 Tenor voice = Guillaume Du Fay, Nuper rosarum flores (1436) • Isorhythmic motet – tenor: Terribilis est locus iste • From mass used to consecrate churches – canon • Symbolic proportions – 6:4:2:3 – text = 4 x 7 1 Kings 6, vv. -

Du Fay: Nuper Rosarum Flores. Szellemi Áramlatok Találkozása a Későközépkor Zeneesztétikájában
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28-as számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola DU FAY: NUPER ROSARUM FLORES. SZELLEMI ÁRAMLATOK TALÁLKOZÁSA A KÉSŐKÖZÉPKOR ZENEESZTÉTIKÁJÁBAN. SÁNDOR LÁSZLÓ TÉMAVEZETŐ: BALI JÁNOS (DLA HABIL.) DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2020 Tartalomjegyzék Képek jegyzéke IV Köszönetnyilvánítás V 1. Bevezetés VII 2. A Nuper rosarm flores motetta ünnepi szimbolikai kapcsolódásai 1 2.1. Az Angyali Üdvözlet ünnepe Firenzében, 1436-ban 1 2.1.1. A Nuper megszólalási időpontjának kérdése 1 2.1.2. A dómszentelés napjának időzítése 3 2.1.3. Az arany rózsa járulékos rejtett szimbolikája 5 2.2. A Mária-szimbolika, a szerelmi költészet és a motetta 10 2.2.1. Szövegpolifónia a korai Mária-motettákban 10 2.2.2. A 3:4-es szimbolika 12 2.2.3. A Nuper cantus firmusa – Terribilis est locus iste 18 2.2.4. Szimbólumok összefonódása a motetta szövegében 25 2.3. Imaszándék és kontempláció 31 2.3.1. A votív imaalkalmak elterjedése 31 2.3.2. A legfontosabb közbenjáró: Szűz Mária 33 2.3.3. A kontempláció fogalmának és gyakorlatának 15. századi alakulása 35 2.3.4. A kontempláció természete és lépcsőfokai Nicolaus Cusanusnál 41 2.3.5. A kontempláció és spiritualitás visszhangja a dómszentelési beszámolókban 46 2.3.6. A Nuper almos rose flores szekvencia az Edili 151-ben 53 3. Templom és motetta 57 3.1. Bevezetés 57 3.2. A Nuper rosarum flores és a dómszentelés történeti háttere 62 3.2.1. IV. Jenő Firenzében 62 3.2.2. Salve, flos Tuscae gentis – a másik dómszentelési motetta? 63 3.2.3. A Santa Maria del Fiore terveinek módosulásai 1296 és 1436 között 68 3.3. -

Magnanimae Gentis
Guillaume Du Fay Opera Omnia 02/11 Magnanimae gentis Edited by Alejandro Enrique Planchart Marisol Press Santa Barbara, 2011 Guillaume Du Fay Opera Omnia Edited by Alejandro Enrique Planchart 01 Cantilena, Paraphrase, and New Style Motets 02 Isorhythmic and Mensuration Motets 03 Ordinary and Plenary Mass Cycles 04 Proper Mass Cycles 05 Ordinary of the Mass Movements 06 Proses 07 Hymns 08 Magnificats 09 Benedicamus domino 10 Songs 11 Plainsongs 12 Dubious Works and Works with Spurious Attributions © Copyright 2011 by Alejandro Enrique Planchart, all rights reserved. Guillaume Du Fay, Magnanimae gentis: 1 02/11 Magnanimae gentis - Nexus amicitiae - Haec est vera fraternitas [ ] = Guillaume Du Fay Cantus Ma gna ni mae gen tis lau des pa ti a [ ] Contratenor 8 Ne xus a mi ci ti ae Mu sa mo du lan Tenor Quater dicitur, Primo crescit in duplo, Aliis tribus vicibus, ut signa notant, primas pausas tamen obtinendo 9 re, Mi ner va, 8 te Ca me nam 17 Au ge at us que su um nun ti a fa 8 Ma gni fi ce tur e nim nil si ne pa ce va Haec est vera fraternitas I 27 ma de cus. Vox Pe ga se a lo 8 let. O 37 cum mun di per cur rat ad om 8 Quan do iun gi po tu i sti, Ber na, Fri bur D-OO Guillaume Du Fay, Magnanimae gentis: 2 45 nem: Co gno scant Da chus, Teu 8 go, Quan ta ma li ra bi es 53 cri a, Par thus A rabs, 8 im pe ru o sa ru it! Op ti ma 61 Quam for tes a ni mos, quam fer 8 cum vo bis com mu ni 69 re a pec to ra quam 8 a vo ta fu e re, 77 que 8 D-OO Guillaume Du Fay, Magnanimae gentis: 3 85 E gre gi os sen sus, op 8 O qui bus, o quan tis u tra II 93 ti ma Ber na, pa ris. -
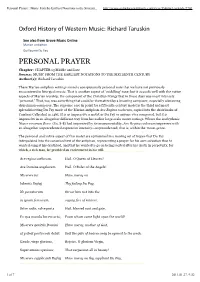
Josquin Des Prez in Fact and Legend
Personal Prayer : Music from the Earliest Notations to the Sixteent... http://www.oxfordwesternmusic.com/view/Volume1/actrade-9780... Oxford History of Western Music: Richard Taruskin See also from Grove Music Online Marian antiphon Guillaume Du Fay PERSONAL PRAYER Chapter: CHAPTER 13 Middle and Low Source: MUSIC FROM THE EARLIEST NOTATIONS TO THE SIXTEENTH CENTURY Author(s): Richard Taruskin These Marian antiphon settings sound a conspicuously personal note that we have not previously encountered in liturgical music. That is another aspect of “middling” tone; but it accords well with the votive aspects of Marian worship, the component of the Christian liturgy that in those days was most intensely “personal.” That, too, was something that could be thematized by a knowing composer, especially a knowing churchman-composer. The supreme case in point for a fifteenth-century motet is the third and most splendid setting Du Fay made of the Marian antiphon Ave Regina coelorum, copied into the choirbooks of Cambrai Cathedral in 1465. It is as impressive a motet as Du Fay or anyone ever composed, but it is impressive in an altogether different way from his earlier large-scale motet settings. Where the isorhythmic Nuper rosarum flores (Ex. 8-8) had impressed by its monumentality, Ave Regina coelorum impresses with an altogether unprecedented expressive intensity—unprecedented, that is, within the motet genre. The personal and votive aspect of this motet are epitomized in a moving set of tropes that Du Fay interpolated into the canonical text of the antiphon, representing a prayer for his own salvation that he wanted sung at his deathbed, and that he wanted to go on being recited after his death in perpetuity, for which, a rich man, he provided an endowment in his will: Ave regina coelorum, Hail, O Queen of Heaven! Ave Domina angelorum, Hail, O Ruler of the Angels! Miserere tui Have mercy on labentis Dufaÿ Thy failing Du Fay, Ne peccatorum throw him not into the in ignem fervorum. -

The World of Guillaume Du Fay(C. 1397–1474)
The World of Guillaume Du Fay The World of Guillaume Du Fay (c. 1397–1474) Program and his colleagues and friends Apostolo glorioso · Du Fay Isorhythmic motet (probably for the rededication of the church of St Andrew in Patras, 1426) s (c. 1390–c. 1453) John Dun table Ave maris stella · Vespers hymn for the Blessed Virgin Mary Verses 1, 3, 5, 7 · plainchant · GB PG DY sm s s s (c. 1400–1460) Verse 2 · Du Fay, contratenor “au faulx bourdon” · DT JM MS Gille de Bin , called Binchoi Verse 4 · Dunstable · MN jm ac Verse 6 · Du Fay, contratenor “sine faulx bourdon” · PD AS AC s (fl. 1420s–30s) Hugo de Lantin Four Chansons Entre vous, gentils amoureux · Du Fay · DT AS SM s (c. 1420–1497) Johanne Ockeghem Tant plus ayme · Binchois · DT MS SM Je me complains · Du Fay · AS MS JM Sunday, March 5, 2006, at 3 p.m. J’atendray tant qu’il vous playra · Du Fay · LK AS MS First Church in Cambridge, Congregational Veni sancte spiritus / Veni creator · Dunstable · Isorhythmic motet for Pentecost Flos florum · Du Fay · DT AS MS Sanctus “Papale” · Du Fay Troped Sanctus (possibly for the dedication of the cathedral of Florence, March 25, 1436) intermission Rite majorem Jacobum canamus · Du Fay Isorhythmic motet in praise of St James the Greater (probably late 1420s) Permanent vierge / Pulchra es / Sancta dei genitrix · attributed to Ockeghem · PD AS GB DY PG Blue Heron Aurea luce et decore roseo · Du Fay · Vespers hymn for Sts Peter and Paul Verse 1 · plainchant · GB PG DY sm Noël Bisson Pamela Dellal Allen Combs Glenn Billingsley Verse 1 repeat · plainchant -

Salve, Flos Tuscae Gentis
Guillaume Du Fay Opera Omnia 02/10 Salve, flos Tuscae gentis Edited by Alejandro Enrique Planchart Marisol Press Santa Barbara, 2011 Guillaume Du Fay Opera Omnia Edited by Alejandro Enrique Planchart 01 Cantilena, Paraphrase, and New Style Motets 02 Isorhythmic and Mensuration Motets 03 Ordinary and Plenary Mass Cycles 04 Proper Mass Cycles 05 Ordinary of the Mass Movements 06 Proses 07 Hymns 08 Magnificats 09 Benedicamus domino 10 Songs 11 Plainsongs 12 Dubious Works and Works with Spurious Attributions © Copyright 2011 by Alejandro Enrique Planchart, all rights reserved. Guillaume Du Fay, Salve flos Tuscae: 1 02/10 Salve flos Tuscae gentis - Vos nunc Etruscae - Viri mendaces [ ] = Guillaume Du Fay Cantus Sal ve flos Tu [ ] Contratenor 8 Vos nunc, E tru Tenor 1 8 Viri mendaces Tenor 2 I, 1 7 scae gen tis, Flo ren ti a, sal 8 cae iu be o sal ve te pu 8 15 ve, O sal ve, I ta li ci glo ri 8 el lae. 8 21 a ma gna so li. Sal ve, quae doc 8 Sic se det hoc a ni mo nec si ne a mo 8 D-OO Guillaume Du Fay, Salve flos Tuscae: 2 29 tos fe lix tot ma ter a lum 8 re mo 8 I, 2 35 nos, Tot ge ne ras ma gnos con si li o 8 ror. Stant fo ri bus Nym 8 43 at que fi de, Quae tot 8 phis 8 49 prae stan tes mi ra in te ri tu di ne que 8 si mi les, stant Na ia des ut que 8 D-OO Guillaume Du Fay, Salve flos Tuscae: 3 57 tot Prae stan tes ge ne 8 Aut 8 Viri mendaces II, 1 63 ras re li gi o ne vi ros, Sal ve, 8 ut A ma zo ni des 8 71 cu i de bet quod cum 8 aut pro ca di va 8 77 que est ar tis ho ne 8 Ve nus. -

Phd/Renaissance Seminar: Text, Performance, Interpretation, Aesthetics Dr
1 PhD/Renaissance Seminar: Text, Performance, Interpretation, Aesthetics Dr. Jennifer Thomas MUH 7938 Section 2C92 Office hours: MUH 6671 Section 3D62 T/TH 10:45 – 11: 45 or by appointment TH: 1:55 – 3:50; R: 3:003:50 (TBA) e-mail: [email protected] University of Florida , Fall 2018 QUESTIONS • Notated music: How does the appearance of notated music affect performers’ perceptions about how to interpret it? What advantages and disadvantages do we find in each type? • Performance: How does performance serve music? Serve students and scholars? Serve audiences? • Interpretation: What is interpretation, and how does it come about? How can we determine viable or successful musical interpretations of early music? • Aesthetics: Whose taste do we/ can we/ should we serve in creating performances, editions, written accounts, interpretations? DEVELOPING SKILLS • in research, writing, discussion, score reading, and music listening • ability to interpret primary source documents such as musical sources, theoretical treatises, letters • fluency in using standard library materials for the period, such as critical score editions, music facsimile editions, writings of theorists, source readings, etc. • ability to interpret and discuss the scholarly work on this period and these topics WHAT IS A SEMINAR? A seminar is a collection of scholars working together to probe issues of mutual interest. (Merriam- Webster: “a group of advanced students studying under a professor with each doing original research and all exchanging results through reports and discussions.”) The seminar allows for the possibility of individual discovery as well as for the mastery of particular areas of content. The success of the seminar depends on the quality of the contributions of each member of the group. -

Magyar Zenetudományi És Zenekritikai Társaság „Mûelemzés – Ma” Címmel Rendezett VIII
5 T ANULMÁNY Vikárius László ECCE NOMEN DOMINI ÉS ISTI SUNT DUE OLIVE Stílus és szimbolika Guillaume Du Fay két „koronázási” motettájában* Guillaume Du Fay (vlsz. 1397–1474)1 izoritmikus motettái, a kor kitüntetett rep- rezentációs mûfajának e mestermûvei a kor más kompozícióihoz hasonlóan nagy zenei kéziratokban elszórva, datálatlanul maradtak fenn. Maguknak a kéziratok- nak, illetve a bennük található egyes mûvek bejegyzésének sokszor valóságos de- tektívmunkát igénylô datálása a legjobb esetben is csupán arról tudósít, mely idô- pontban létezett már biztosan (s volt még följegyzésre, megôrzésre méltónak ítélt) egy kompozíció (terminus ante quem) anélkül, hogy tényleges keletkezése ezál- tal közelebbrôl meghatározhatóvá válna. A korabeli motetta, a kor mûfaji hierar- chiájában a chanson és a mise között álló cantus mediocris2 sajátosságai közé tarto- zik azonban, hogy a kompozíciók meghatározott alkalomra íródtak, s a feltételez- hetô elhangzás eseményére rendszerint magukban a kompozíciókban találunk utalást. A 13. században megszületett mûfaj e késôbbi reprezentációs típusa tehát immár nem egy rendszeresen visszatérô, elvont liturgikus alkalomhoz, hanem ki- emelkedô, és ha nem is egyszeri, de nem rendszeresen visszatérô, egyedi társadalmi eseményhez kapcsolódott. Guillaume de Machaut (1300–1377) legkorábbinak tar- tott motettája, a Bone pastor Guillerme/Bone pastor, qui pastores/Bone pastor Guillaume de Trie reimsi hercegérsek tiszteletére – nagy valószínûséggel beiktatására – íród- hatott. Mind az alapul választott „Bone pastor” (Jó pásztor) (egyelôre azonosítat- *A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Mûelemzés – ma” címmel rendezett VIII. tudo- mányos konferenciáján, az MTA Zenetudományi Intézet Bartók- termében 2011. október 7- én elhang- zott elôadás tanulmánnyá átdolgozott változata. 1 Du Fay nevének írásmódja és három szótagú kiejtése (dü fá- i) ma elfogadottnak tekinthetô. -

ECCE NOMEN DOMINI ÉS ISTI SUNT DUE OLIVE Stílus És Szimbolika Guillaume Du Fay Két „Koronázási” Motettájában*
5 T ANULMÁNY Vikárius László ECCE NOMEN DOMINI ÉS ISTI SUNT DUE OLIVE Stílus és szimbolika Guillaume Du Fay két „koronázási” motettájában* Guillaume Du Fay (vlsz. 1397–1474)1 izoritmikus motettái, a kor kitüntetett rep- rezentációs mûfajának e mestermûvei a kor más kompozícióihoz hasonlóan nagy zenei kéziratokban elszórva, datálatlanul maradtak fenn. Maguknak a kéziratok- nak, illetve a bennük található egyes mûvek bejegyzésének sokszor valóságos de- tektívmunkát igénylô datálása a legjobb esetben is csupán arról tudósít, mely idô- pontban létezett már biztosan (s volt még följegyzésre, megôrzésre méltónak ítélt) egy kompozíció (terminus ante quem) anélkül, hogy tényleges keletkezése ezál- tal közelebbrôl meghatározhatóvá válna. A korabeli motetta, a kor mûfaji hierar- chiájában a chanson és a mise között álló cantus mediocris2 sajátosságai közé tarto- zik azonban, hogy a kompozíciók meghatározott alkalomra íródtak, s a feltételez- hetô elhangzás eseményére rendszerint magukban a kompozíciókban találunk utalást. A 13. században megszületett mûfaj e késôbbi reprezentációs típusa tehát immár nem egy rendszeresen visszatérô, elvont liturgikus alkalomhoz, hanem ki- emelkedô, és ha nem is egyszeri, de nem rendszeresen visszatérô, egyedi társadalmi eseményhez kapcsolódott. Guillaume de Machaut (1300–1377) legkorábbinak tar- tott motettája, a Bone pastor Guillerme/Bone pastor, qui pastores/Bone pastor Guillaume de Trie reimsi hercegérsek tiszteletére – nagy valószínûséggel beiktatására – íród- hatott. Mind az alapul választott „Bone pastor” (Jó pásztor) (egyelôre azonosítat- *A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Mûelemzés – ma” címmel rendezett VIII. tudo- mányos konferenciáján, az MTA Zenetudományi Intézet Bartók- termében 2011. október 7- én elhang- zott elôadás tanulmánnyá átdolgozott változata. 1 Du Fay nevének írásmódja és három szótagú kiejtése (dü fá- i) ma elfogadottnak tekinthetô. -

A Contemporary Perception of Early Fifteenth-Century Style; Bologna Q15 As a Document of Scribal Editorial Initiative.” Musica Disciplina 41 (1987): 183-201
Sándor László: Kimondani a kimondhatatlant avagy politikai korrektség Du Fay Vasilissa ergo gaude motettájában A Vasilissa ergo gaude Du Fay első izoritmikus motettája.1 Komponálása idején, 1420 nyarán a mester valószínűleg 23 éves.2 A fiatal Du Fay az által, hogy az izoritmikus motetta műfajához nyúl mintegy másfél évszázados szellemi hagyomány áramlatába kapcsolódik be. Kikristályosodott, kiérlelt formában kapja meg mindazt, ami a 13. század elején Párizsból útjára induló motetta- komponálás gyakorlatában kialakult, és mindazt a lehetőséget is, mely a műfaj legfőbb sajátosságaiban, technikai fogásaiban benne rejlik; ezek közül a három legfontosabb az izoritmikus szerkesztés, a szövegpolifónia és a cantus firmus kezelése. Az izoritmikus szerkesztés az ókori pythagoreus kozmológia örököseként a musica, mint számtani ars boethiusi látásmódját őrzi, a többszövegűség a szövegpolifónia által létrejövő járulékos és rejtett értelmezési lehetőségeket hordozza, a cantus firmus kiválasztása pedig adott esetben liturgikus, más esetben politikai kontextusba helyezi a megszólaló zeneművet. A fiatal Du Fay tanárok, mesterek és elődök által tökélyre vitt és kiérlelt műfajt kap örökül, mely hangsúlyozottan az egyéni lelemény és a modernitás legfontosabb zenei terepe volt kialakulásától kezdve. Sokak véleménye szerint Du Fay mindezek ellenére az izoritmikus motetta történetében inkább összegző, mintsem újító szerepet tölt be;3 mi sem bizonyítja jobban e kijelentést, minthogy Du Fay Fulgens iubar szövegkezdetű motettája az utolsó izoritmikus motetta a zenetörténetben. Nem tűnik elhamarkodottnak az a kijelentés sem, miszerint Du Fay az izoritmikus motetta műfajában hasonló szerepet tölt be, mint J. S. Bach a fugáéban. Összegez és konklúziót von.4 Így, bár a Vasilissa ergo gaude egy szerző első alkotása a szóban forgó műfajban, maga a szerző az utolsó szereplője a műfaj történetének.5 1 A mű három kéziratos forrásban maradt fenn: Bologna (I-Bc) Q15 276v–277r, Oxford, Bodleian Library GB-Ob 213.