Tesi Di Laurea
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Washington State Census Board and Its Demographic Legacy
SPRINGER BRIEFS IN POPULATION STUDIES David A. Swanson The Washington State Census Board and Its Demographic Legacy 123 SpringerBriefs in Population Studies More information about this series at http://www.springer.com/series/10047 David A. Swanson The Washington State Census Board and Its Demographic Legacy 123 David A. Swanson Department of Sociology University of California Riverside USA ISSN 2211-3215 ISSN 2211-3223 (electronic) SpringerBriefs in Population Studies ISBN 978-3-319-25947-5 ISBN 978-3-319-25948-2 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-25948-2 Library of Congress Control Number: 2015954599 Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London © The Author(s) 2016 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. -

Butler Hansen a Trailblazing Washington Politician John C
Julia Butler Hansen A trailblazing Washington politician John C. Hughes Julia Butler Hansen A trailblazing Washington politician John C. Hughes First Edition Second Printing Copyright © 2020 Legacy Washington Office of the Secretary of State All rights reserved. ISBN 978-1-889320-45-8 Ebook ISBN 978-1-889320-44-1 Front cover photo: John C. Hughes Back cover photo: Hansen Family Collection Book Design by Amber Raney Cover Design by Amber Raney and Laura Mott Printed in the United States of America by Gorham Printing, Centralia, Washington Also by John C. Hughes: On the Harbor: From Black Friday to Nirvana, with Ryan Teague Beckwith Booth Who? A Biography of Booth Gardner Nancy Evans, First-Rate First Lady Lillian Walker, Washington State Civil Rights Pioneer The Inimitable Adele Ferguson Slade Gorton, a Half Century in Politics John Spellman: Politics Never Broke His Heart Pressing On: Two Family-Owned Newspapers in the 21st Century Washington Remembers World War II, with Trova Heffernan Korea 65, the Forgotten War Remembered, with Trova Heffernan and Lori Larson 1968: The Year that Rocked Washington, with Bob Young and Lori Larson Ahead of the Curve: Washington Women Lead the Way, 1910-2020, with Bob Young Legacy Washington is dedicated to preserving the history of Washington and its continuing story. www.sos.wa.gov/legacy For Bob Bailey, Alan Thompson and Peter Jackson Julia poses at the historic site sign outside the Wahkiakum County Courthouse in 1960. Alan Thompson photo Contents Preface: “Like money in the bank” 6 Introduction: “Julia Who?” 10 Chapter 1: “Just Plain Me” 17 Chapter 2: “Quite a bit of gumption” 25 Chapter 3: Grief compounded 31 Chapter 4: “Oh! Dear Diary” 35 Chapter 5: Paddling into politics 44 Chapter 6: Smart enough, too 49 Chapter 7: Hopelessly disgusted 58 Chapter 8: To the last ditch 65 Chapter 9: The fighter remains 73 Chapter 10: Lean times 78 Chapter 11: “Mrs. -

A Forest Kingdom Unlike Any Other
Utah State University DigitalCommons@USU Undergraduate Honors Capstone Projects Honors Program 1979 A Forest Kingdom Unlike Any Other Kurt F. Ruppel Utah State University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/honors Part of the Natural Resources Management and Policy Commons Recommended Citation Ruppel, Kurt F., "A Forest Kingdom Unlike Any Other" (1979). Undergraduate Honors Capstone Projects. 222. https://digitalcommons.usu.edu/honors/222 This Thesis is brought to you for free and open access by the Honors Program at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in Undergraduate Honors Capstone Projects by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. A FOREST KINGDOMUNLIKE ANY OTHER by Kurt F. Ruppel A senior thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of BACHELOROF SCIENCE Wildlife Sci~nce (Honors) Approved by: UTAHSTATE UNIVERSITY Logan, Utah 1979 ii ACKNOWLEDGEMENTS Many people were instrumental in the formation and completion of this study. I would specifically like to thank Dr. Bernard Shanks and Dr. Douglas D. Alder for their guidance, counsel, and patience during the course of this research. My gratitude also to the USU librarians who guided me through the maze of government publications on this subject. iii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS ii LIST OF MAPS iii CHRONOLOGY . iv I. INTRODUCTION 1 Uniqueness Survival II. COMING OF THE WHITE MAN 5 Exploration Early Federal Control: Confusion Monument Status: More Confusion III. ESTABLISHMENT OF A NATIONAL PARK. 12 Impetus for a Park Wallgren's Bills Issues and Adversaries Compromise and Resolution IV. -

Extensions of Remarks Section
June 20, 1996 CONGRESSIONAL RECORD Ð Extensions of Remarks E1115 EXTENSIONS OF REMARKS IN HONOR OF MRS. SALLIE rights cases, as well as pro bono services for ZACKY COLD STORAGE GROWTH LANGSETH FOR HER INDUCTION the NAACP. Hilbert is a noted trial lawyer and WARMS FRESNO ECONOMY INTO THE NATIONAL TEACHERS has had a distinguished career as a deputy HALL OF FAME, DEER PARK, TX prosecutor, corporation counsel, and interim HON. GEORGE P. RADANOVICH judge and mediator. OF CALIFORNIA HON. KEN BENTSEN In 1987, Hilbert founded the Indiana Coali- IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF TEXAS tion for Black Judicial Officials, and he serves Wednesday, June 19, 1996 IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES as the group's general chairman today. The Mr. RADANOVICH. Mr. Speaker, a major Wednesday, June 19, 1996 organization's purpose is to increase the num- ber of black judicial officials in the State of In- California poultry producer, Zacky Farms, is Mr. BENTSEN. Mr. Speaker, I rise to honor diana. The Indiana Coalition for Black Judicial embarking on an expansion plan in coopera- Mrs. Sallie Langseth of Pasadena, TX, who Officials organizes statewide public awareness tion with the city of Fresno, and I am pleased will be inducted into the National Teachers campaigns which have resulted in an in- to bring it to the attention of my colleagues. Hall of Fame in Emporia, KS, on June 22, creased number of black referees and judges Zacky Farms is an engine of economic en- 1996. She is one of five educators in the pro tem, the election of a black judge to the terprise in my 19th Congressional District. -
Douglas Edge Murie and the American Conservation Movement
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 2002 Women for the Wild: Douglas Edge Murie and the American conservation movement. Mary Anne Peine The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Peine, Mary Anne, "Women for the Wild: Douglas Edge Murie and the American conservation movement." (2002). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 4757. https://scholarworks.umt.edu/etd/4757 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. Maureen and Mike MANSFIELD LIBRARY The University of Montana Permission is granted by the author to reproduce this material in its entirety, provided that this material is used for scholarly purposes and is properly cited in published works and reports. **Please check "Yes" or "No" and provide signature Yes, I grant permission ^ No, I do not grant permission _________ Author's Signature: Kj\A(AAA/j A AvIaX Date: 2*4; 2 002._______ Any copying for commercial purposes or financial gain may be undertaken only with the author's explicit consent. 8/98 Women for the Wild: Douglas, Edge, Murie and the American Conservation Movement by Mary Anne Peine B.A. University of Tennessee 1997 presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science The University of Montana April 2002 Approved by: Donald Snow, Chair Dean, Graduate School Date UMI Number: EP40221 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. -

Annual Report 2015
WASHINGTON MILITARY DEPARTMENT ANNUAL REPORT 2015 - EMERGENCY MANAGEMENT DIVISION - WASHINGTON NATIONAL GUARD - WASHINGTON STATE GUARD - WASHINGTON YOUTH ACADEMY CONTENTS The Adjutant General’s Letter............................................................................................2 The Adjutant General Summary.......................................................................................4 Elected Officials........................................................................................................................3 Agency History.........................................................................................................................5 2015 Overview.........................................................................................................................8 Fiscal and Personnel...........................................................................................................12 Adjutant General’s Department Offices......................................................................17 Emergency Management Division................................................................................18 Washington Youth Academy............................................................................................31 Enterprise Improvement..................................................................................................35 Washington National Guard............................................................................................37 Joint Force Headquarters -

HMJ Cover Graphic4e.Cdr
Senator Henry M. Jackson Remembering ‘Scoop’ on the 100th anniversary of his birth. By Jonathan S. Tobin Freedom25, a group that seeks to commemorate the 25th anniversary of the 1987 March on Washington for Soviet Jewry, reminds us that today is the 100th anniversary of the birth of Senator Henry Jackson, the intrepid Democratic senator from Washington State who was a bulwark of the fight for freedom against Communism. Jackson is worth remembering not just because of his hard work for the just cause of freedom for Soviet Jewry and his dogged opposition to appeasement of the Soviet Union. His career embodied a rare brand of patriotism as well as insight into international affairs. He was also the best example of a political breed that is now all but extinct: a liberal on domestic issues who was an ardent hawk on foreign affairs. It is on the shoulders of Henry M. "Scoop" Jackson. (Herald file) men like Jackson that a genuine bipartisan consensus on defense issues, opposition to Soviet tyranny and support for the State of Israel was built. Though he passed away in 1983, all these years later he is still deeply missed by his country. The expression “Scoop Jackson Democrat” is a term that is “Today, we hear a great now falling out of use because there are few liberals left who deal about the need for understand that while Americans can afford to differ on bipartisanship, a line of domestic policy and the economy, we must present a united front against foes of liberty. Though once his sort of politician argument that is was commonplace in an era when both major parties were “big generally a cover for tents,” nowadays it is inconceivable that a Democrat who shared getting officials to throw Jackson’s worldview could survive a primary. -
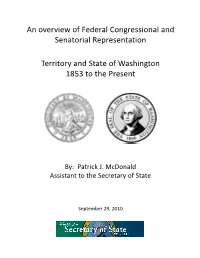
An Overview of Federal Congressional and Senatorial Representation
An overview of Federal Congressional and Senatorial Representation Territory and State of Washington 1853 to the Present By: Patrick J. McDonald Assistant to the Secretary of State September 29, 2010 Overview of Washington State’s Congressional Representation (1853 – Present) Page 2 of 14 United States House of Representatives Members from the Territory of Washington 1853-1889. Democrat Republican From the time that Washington Territory was formed in 1853, through statehood in 1889, the voters of the territory elected an at-large non-voting Delegate to the United States House of Representatives. Congress Delegate Columbia Lancaster 33rd Lost in the 1854 Democratic Convention for (1853–1855) renomination James Patton Anderson 34th Did not Run for Re-election -Later Confederate Major (1855–1857) General in the Civil War 35th (1857–1859) Isaac Ingalls Stevens Did not Run for Re-election–Later Union Major General 36th and died in Civil War (1859–1861) William Henson Wallace 37th Resigned due to appointment as first Governor of the (1861–1863) Idaho Territory by President Lincoln 38th George Edward Cole (1863–1865) Did not Run for Re-election Overview of Washington State’s Congressional Representation (1853 – Present) Page 3 of 14 39th Arthur Armstrong Denny (1865–1867) Did not Run for Re-election 40th Alvan Flanders (1867–1869) Did not Run for Re-election 41st (1869–1871) Selucius Garfielde Lost Re-election 42nd (1871–1873) 43rd Obadiah Benton McFadden (1873–1875) Did not Run for Re-election 44th (1875–1877) Orange Jacobs Did not Run for Re-election 45th (1877–1879) 46th (1879–1881) Thomas Hurley Brents 47th Lost in the 1884 Republican Convention for (1881–1883) renomination 48th (1883–1885) Overview of Washington State’s Congressional Representation (1853 – Present) Page 4 of 14 49th (1885–1887) Charles Stewart Voorhees Lost Re-election 50th (1887–1889) 51st John Beard Allen (1889) Elected to the U.S. -

Western Legal History
WESTERN LEGAL HISTORY THE JOURNAL OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT HISTORICAL SOCIETY VOLUME 12, NUMBER 1 WINTER/SPRING 1999 Western Legal History is published semiannually, in spring and fall, by the Ninth Judicial Circuit Historical Society, 1,25 S. Grand Avenue, Pasadena, California 91105, (626) 795-0266/fax (626) 229-7462. The journal explores, analyzes, and presents the history of law, the legal profession, and the courts- particularly the federal courts-in Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam, and the Northern Mariana Islands. Western Legal History is sent to members of the NJCHS as well as members of affiliated legal historical societies in the Ninth Circuit. Membership is open to all. Membership dues (individuals and institutions): Patron, $1,000 or more; Steward, $750-$999; Sponsor, $500-$749; Grantor, $250-$499; Sustaining, $100- $249; Advocate, $50-$99; Subscribing (nonmembers of the bench and bar, lawyers in practice fewer than five years, libraries, and academic institutions), $25-$49; Membership dues (law firms and corporations): Founder, $3,000 or more; Patron, $1,000-$2,999; Steward, $750-$999; Sponsor, $500-$749; Grantor, $250-$499. For information regarding membership, back issues of Western Legal History, and other society publications and programs, please write or telephone the editor. POSTMASTER: Please send change of address to: Editor Western Legal History 125 S. Grand Avenue Pasadena, California 91105 Western Legal History disclaims responsibility for statements made by authors and for accuracy of endnotes. Copyright, @1999, Ninth Judicial Circuit Historical Society ISSN 0896-2189 The Editorial Board welcomes unsolicited manuscripts, books for review, and recommendations for the journal. -

National Register of Historic Places Registration Form
NPS Form 10-900 OMB No. 1024-0018 United States Department of the Interior National Park Service National Register of Historic Places Registration Form This form is for use in nominating or requesting determinations for individual properties and districts. See instructions in National Register Bulletin, How to Complete the National Register of Historic Places Registration Form. If any item does not apply to the property being documented, enter "N/A" for "not applicable." For functions, architectural classification, materials, and areas of significance, enter only categories and subcategories from the instructions. Place additional certification comments, entries, and narrative items on continuation sheets if needed (NPS Form 10-900a). 1. Name of Property historic name Fratt, Charles & Idalia House other names/site number Fratt Mansion 2. Location street & number 1725 Grand Avenue not for publication city or town Everett vicinity state Washington code WA county Snohomish code 061 zip code 98201 3. State/Federal Agency Certification As the designated authority under the National Historic Preservation Act, as amended, I hereby certify that this X nomination request for determination of eligibility meets the documentation standards for registering properties in the National Register of Historic Places and meets the procedural and professional requirements set forth in 36 CFR Part 60. In my opinion, the property X_ meets _ does not meet the National Register Criteria. I recommend that this property be considered significant at the following level(s) of significance: national statewide X local Applicable National Register Criteria A X B X C D Signature of certifying official/Title Date WASHINGTON SHPO State or Federal agency/bureau or Tribal Government In my opinion, the property meets does not meet the National Register criteria. -

Vacancies and Representation in the US Senate
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Wisconsin-Milwaukee University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations May 2014 Golden Opportunities: Vacancies and Representation in the U.S. Senate Timothy Lynch University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Political Science Commons, and the Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons Recommended Citation Lynch, Timothy, "Golden Opportunities: Vacancies and Representation in the U.S. Senate" (2014). Theses and Dissertations. 503. https://dc.uwm.edu/etd/503 This Dissertation is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. ! GOLDEN OPPORTUNITIES: VACANCIES AND REPRESENTATION IN THE U.S. SENATE by Timothy Lynch A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science at The University of Wisconsin-Milwaukee May 2014 ABSTRACT GOLDEN OPPORTUNITIES: VACANCIES AND REPRESENTATION IN THE U.S. SENATE by Timothy Lynch The University of Wisconsin-Milwaukee, 2014 Under the Supervision of Professor Thomas M. Holbrook This dissertation examines how vacancies in the United States Senate are filled. Despite the ability of states to set the institution for naming replacements, gubernatorial appointment continues to be the dominant method of selecting successors. The popularity of gubernatorial appointment – which empowers a single individual to substitute his/her judgment for the decision of the state electorate – is curious given that one goal of the Seventeenth Amendment was to democratize the selection of senators. -

Timber Workers and the Making of Place in the Pacific Northwest, 1900-1964
Landscapes of Solidarity: Timber Workers and the Making of Place in the Pacific Northwest, 1900-1964 Steven C. Beda A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2014 Reading Committee: James N. Gregory, Chair Linda L. Nash Margaret Pugh O’Mara Program Authorized to Offer Degree: History © Copyright 2014 Steven C. Beda University of Washington Abstract Landscapes of Solidarity: Timber Workers and the Making of Place in the Pacific Northwest, 1900-1964 Steven C. Beda Chair of Supervisory Committee: Professor James N. Gregory Department of History This dissertation is an environmental history of Northwest timber workers. Looking at rural logging communities in Washington, Oregon, northern California, Idaho, and British Columbia between 1900 and 1964, it examines how timber-working communities interacted with the physical environment through work, subsistence, and recreation and explores how nature shaped working-class culture, community, and the politics of one union, the International Woodworkers of America (IWA). This study identifies an ethic of place as a critical part of working-class experience in the Northwest woods. Timber- working communities developed their identities through their relationship with the forest, and while they believed in the work they did, as well as in the lumber industry’s important economic place in the rural Northwest, they also believed that changes to the landscape brought about by industrial logging needed to be carefully considered and at times constrained. In the postwar period, timber workers belonging to the IWA began putting political pressure on the lumber industry to try to force their employers to follow more responsible harvesting guidelines and later supported forest preservation and attempts to expand Northwestern wilderness areas.