Valentina Mignosa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cv Europeo Italiano
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome GIOCONDA LAMAGNA Indirizzo Telefono Fax E-mail ***************************** Nazionalità ********** Data di nascita ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Dal 04/11/2013 ad oggi • Nome e indirizzo del datore di Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – Dipartimento Beni lavoro culturali e Identità siciliana, via delle Croci, n. 8 - Palermo • Tipo di impiego Dirigente responsabile del S. 51 Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi - Siracusa Conferimento incarico con D.D.G. n. 6190 del 24/10/2013, giusto contratto individuale Rep. n. 2147 del 22/10/2014, successivamente approvato con D.D.G. n. 7138 del 03/11/2014 registrato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S.al n. 1986 del 13.11.2014 • Principali mansioni e Capo d’istituto e funzionario delegato. Nell’ambito di tale incarico ha svolto le responsabilità funzioni istituzionali di coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnatele, con le quali ha condotto le seguenti, principali, attività: Gestione tecnica amministrativa e contabile dell’ufficio, anche attraverso i portali informatici GECORS (adempimenti consegnatario); SI-GTS (attività contabile inerente i vari capp. di spesa); Prosecuzione attività URP; Utilizzo dei sistemi di rilevazione della cd. “customer satisfaction” nella riorganizzazione dei servizi all’utenza Attivazione sistema informatizzato presenze; Pagina 1- Curriculum vitae di [ LAMAGNA Gioconda ] Promozione attività di formazione del personale; Potenziamento e gestione comunicazione tramite social networks Rapporti con le organizzazioni sindacali; Rapporti con gli enti locali; Adempimenti ufficiale rogante; Adempimenti biglietteria ivi compresa attivazione di postazione con terminale POS; Acquisizione di un lotto di una collezione numismatica di importante interesse. Procedure di acquisizione di beni e servizi tramite strumenti CONSIP s.p.a. -

Atella/Aderl: Confronti Etimologici E Riscontri Geocartografici
GIOVANNI RECCIA ATELLA/ADERL: CONFRONTI ETIMOLOGICI E RISCONTRI GEOCARTOGRAFICI ISTITUTO DI STUDI ATELLANI NOVISSIMAE EDITIONES Collana diretta da Giacinto Libertini --------- 33 --------- GIOVANNI RECCIA ATELLA/ADERL: CONFRONTI ETIMOLOGICI E RISCONTRI GEOCARTOGRAFICI Febbraio 2014 ISTITUTO DI STUDI ATELLANI 1 Istituto di Studi Atellani (ISA) Edizione elettronica a cura di Giacinto Libertini http://www.iststudiatell.org Copyright ISA 2014 Tutti i diritti riservati Prima edizione: Febbraio 2014 2 INTRODUZIONE *L‟etimologia è sempre stata considerata una scienza imperfetta per la possibilità che hanno le lingue di trasformarsi nel corso del tempo, ma se, da un lato, ciò è plausibile quando discerniamo di lingue morte o sconosciute, dall‟altro, tale limite si riduce notevolmente in presenza di forme linguistiche/parole che si riscontrano in maniera multiforme nel corso dei secoli in ragione della possibilità di poterne ricostruire struttura e significato originari. Da tali ricostruzioni però, ad affermare principi ovvero ad evidenziare profili aventi diretti riflessi storici sul territorio o sulla società, credo passi molto, specialmente se non vi sono supporti derivanti dall‟applicazione di scienze ulteriori e diverse. La toponomastica antica quindi, come parte dell‟etimologia, può trovare fondamento soltanto se non viene enunciata in astratto, bensì poggi su elementi e dati riscontrabili sul territorio derivanti dallo studio comparato di altre discipline tra cui la geografia, la storia e l‟archeologia. Venendo dunque al nostro tema e premesso che la città antica di Atella(1), costituita da un *Lo studio riprende quanto accennato in G. RECCIA, Topografonomastica e descrizioni geocartografiche dei comuni atellano-napoletani di Grumo e Nevano, Firenze 2009. (1) Sulla città di Atella e la fabula atellana riporto la seguente bibliografia: D. -
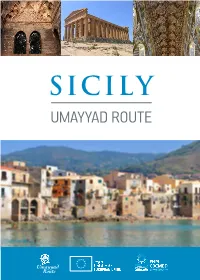
Sicily UMAYYAD ROUTE
SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route SICILY UMAYYAD ROUTE SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route Index Sicily. Umayyad Route 1st Edition, 2016 Edition Introduction Andalusian Public Foundation El legado andalusí Texts Maria Concetta Cimo’. Circuito Castelli e Borghi Medioevali in collaboration with local authorities. Graphic Design, layout and maps Umayyad Project (ENPI) 5 José Manuel Vargas Diosayuda. Diseño Editorial Free distribution Sicily 7 Legal Deposit Number: Gr-1518-2016 Umayyad Route 18 ISBN: 978-84-96395-87-9 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, nor transmitted or recorded by any information retrieval system in any form or by any means, either mechanical, photochemical, electronic, photocopying or otherwise without written permission of the editors. Itinerary 24 © of the edition: Andalusian Public Foundation El legado andalusí © of texts: their authors © of pictures: their authors Palermo 26 The Umayyad Route is a project funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and led by the Cefalù 48 Andalusian Public Foundation El legado andalusí. It gathers a network of partners in seven countries in the Mediterranean region: Spain, Portugal, Italy, Tunisia, Egypt, Lebanon and Jordan. Calatafimi 66 This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary (Fundación Pública Castellammare del Golfo 84 Andaluza El legado andalusí) and their Sicilian partner (Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali) and can under no Erice 100 circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme’s management structures. -

Dating the Monuments of Syracusan Imperialism
Syracuse in antiquity APPENDIX 4: DATING THE MONUMENTS OF SYRACUSAN IMPERIALISM Archaic Period Apollonion and Artemision on Ortygia Zeus Urios at Polichne Gelon Work starts on the temple of Athena (485-480) Temples to Demeter and Kore, and Demeter at Aetna (Katane) Tombs of the Deinomenids on the road to Polichne Ornamental Pool at Akragas, statuary at Hipponion Hieron I Theatre at Neapolis (after) 466 An altar to Zeus Eleutherios 450-415 Temenos of Apollo at Neapolis 415 Fortification of Neapolis and Temenites Garden at Syracuse Dionysius I Fortification of the Mole and Small Harbour Construction of acropoleis on Ortygia and the Mole Embellishment of the agora Completion of the northern wall on Epipolai, the Hexapylon and Pentapylon Foundation of Tyndaris Destruction of the tombs of Gelon and Demarete Completion of the circuit walls of the city Dionysius II Re-foundation of Rhegion as Phoebia Two colonies founded in Apulia Destruction of the acropoleis and fortifications of the Mole and Ortygia Timoleon Construction of the Timoleonteion Re-foundation of Gela, Akragas and Megara Hyblaia Gymnasium and Tomb of Timoleon near the agora Agathokles Fortifications of Gela A harbour at Hipponion The Eurialos Fort 150 Appendix A Banqueting Hall on Ortygia Refortification of Ortygia and the Partus Laccius Decoration of the interior of the Athenaion Re-foundation of Segesta as Dikaiopolis Hieron II Palace on Ortygia The Theatre at Neapolis Altar of Zeus Eleutherios renovated Olympieion in the agora Hieronymous Refinement of fortifications at Eurialos 151 Syracuse in antiquity APPENDIX 5: THE PROCONSULS OF SICILY (210-36 BC)1 211: M. -

Les Carnets De L'acost, 13
Les Carnets de l’ACoSt Association for Coroplastic Studies 13 | 2015 Varia Electronic version URL: http://journals.openedition.org/acost/566 DOI: 10.4000/acost.566 ISSN: 2431-8574 Publisher ACoSt Printed version Date of publication: 5 August 2015 Electronic reference Les Carnets de l’ACoSt, 13 | 2015 [Online], Online since 17 August 2015, connection on 23 September 2020. URL : http://journals.openedition.org/acost/566 ; DOI : https://doi.org/10.4000/acost.566 This text was automatically generated on 23 September 2020. Les Carnets de l'ACoSt est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. 1 TABLE OF CONTENTS Editorial Oliver Pilz Coroplastic Studies and the History of Religion: Figurines in Yehud and the Interdisciplinary Nature of the Study of Terracottas Izaak J. de Hulster Ein Affe spielt Tragödie. Zum Problem der Tiermaske bei vermeintlichen und tatsächlichen Schauspielerstatuetten Simone Voegtle Bust Thymiateria from Olbia Pontike Tetiana M. Shevchenko Les terres cuites figurées du sanctuaire de Kirrha (Delphes) : Bilan des premières recherches Stéphanie Huysecom-Haxhi Chroniques Entre la Mésopotamie et l’Indus. Réflexions sur les figurines de terre cuite d’Asie Centrale aux 4e et 3e millénaires Annie Caubet Painted Gallo-Roman Figurines in Vendeuil-Caply Adrien Bossard Travaux en cours A Catalogue of the Greek and Roman Terracottas in the Aydın Archaeological Museum Murat Çekіlmez A Survey of Terracotta Figurines from Domestic Contexts in South Italy in the 6th and 5th Centuries B.C.E. Aura Piccioni Two Collaborative Projects for Coroplastic Research, II. -

Sicily and the Imperialism of Mid-Republican Rome : (289-191BC)
SICILY AND THE IMPERIALISM OF MID- REPUBLICAN ROME : (289-191BC) John Serrati A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2001 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/11102 This item is protected by original copyright L Sicily and the Imperialism of mid-Republican Rome (289-191 BC) John Serrati Ph.D. Ancient History 19 January 2001 i) I, John Serrati, hereby certify that this thesis, which is approximately 96,000 words in length, has been written by me, that it is the record of work carried out by me and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. Signature of Candidate ii) I was admitted as a research student in October 1995 and as a candidate for the degreeofPh.D. in Ancient History in October 1996; the higher study for which this is a record was carried out in the University of St. Andrews between 1995 and 2001. iii) I hereby certify that the candidate has fulfilled the conditions of the Resolution and Regulations appropriate for the degree ofPh.D. in the University of St. Andrews and that the candidate is qualified to submit this thesis in application for that degree. F:-·;T,',,:.-~TD Signature of Supervisor ... .tt,"·.· .:.:.~~::;.L~~J Date ..I.'1.b.J~.~ .. "'"-...... .,r-'" In submitting this thesis to the University of St. Andrews I understand that I am giving permission for it to be made available for use in accordance with the regulations of the University Library for the time being in force, subject to any copyright vested in the work not being affected thereby. -

Builder of the Cities. Dionysius and Sicels1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prace Historyczne 142, z. 1 (2015), s. 13–24 doi: 10.4467/20844069PH.15.002.3498 www.ejournals.eu/Prace-Historyczne BUILDER OF THE CITIES. DIONYSIUS AND SICELS1 Ryszard Tokarczuk Uniwersytet Jagielloński ABSTRACT BUILDER OF THE CITIES. DIONYSIUS AND SICELS In 400 BC, Dionysius the Elder founded a city called Adranos, after an important Sicel sanc- tuary. This deed marked an important phase in relations between the indigenous people and the Greek population. It can be argued that the tyrant’s decision was dictated by practical reasons, yet his policy of subjecting a Sicel divinity under the Greek city-state structure resulted from previous Greek experiences and practices. On the other hand, after the era of Dionysius, the cult of Adranos not only did not disappear, but also gained a wider recognition and never lost political importance to the Greeks, who by the end of fourth century exerted signifi cant infl uence over former Sicel lands. In the effect native people did not vanish from the island but were practically absorbed into the Greek world. Keywords: Dionysius, Adranos, Sicily, Sicels, religion Throughout his reign, the most famous tyrant of Syracuse, Dionysius the Elder, was able to extend and keep his authority over a large portion of Sicily. Such outcome is certainly connected with the results of his military campaigns and never ending confl ict with Carthaginians, yet to concentrate on such a reason means also to follow eagerly the Ancient Greek tradition of seeing in a fi gure of tyrant mainly an instigator of armed confl ict2. -

Explanatory Or More Detailed References (Where There Are Many), Or References to Places Where an Artist’S Work Is Best Represented, Are Given in Bold
550 Index Explanatory or more detailed references (where there are many), or references to places where an artist’s work is best represented, are given in bold. Numbers in italics are picture references. Dates are given for all artists, architects and sculptors with works referenced in this guide. Ancient names are rendered in italics, as are works of art. Abakainon, ancient city 474 Agrigento contd Acate 326 Grotta Fragapane 201 Accommodation 515 Hellenistic and Roman district 212 Aci Castello 426 Kolymbethra Garden 208 Acireale 424 Living Museum of the Almond Tree 213 Acitrezza 426 Lower agora 206 Acquaviva Platani 254 Museo Civico 215 Acquedolci 482 Museo Diocesano 216 Addaura Caves 73; (finds from) 64 Oratory of Phalaris 211 Adelaide, wife of Roger I 300, 481, 482 Pezzino Necropolis 214 (tomb of) 477 Pinacoteca Palazzo dei Filippini 215 Adrano 419; (finds from) 360 S. Biagio 212 Adranon, ancient city 223 S. Maria dei Greci 215 Aegadian Islands 180ff S. Nicola 211 Aeneas, legends concerning 136, 143, 144, Sanctuary of Asklepios 213 147 Sanctuary of Demeter 212 Aeolian Islands 484 Sanctuary of the Chthonic Divinities 207 Aeschylus 256, 257, 344, 364, 400, 415 Temple of Castor and Pollux 207 Agatha, St 409, 410, 411 (reliquaries of) Temple of Concord 198, 201, 204 404 Temple of Hephaistos 214 Agathocles, tyrant of Syracuse 11, 95, 100, Temple of Hera 200 147, 173, 259, 344, 448 Temple of Herakles 205 Agira 294 Temple of Zeus 205, 207, 209 Agrigento 199ff; (finds from) 208, 360 Tomb of Theron 213 Aqueduct of Phaiax 208, 215 Upper agora -

Copyright by Giuseppe Carlo Castellano II 2016
Copyright by Giuseppe Carlo Castellano II 2016 The Report committee for Giuseppe Carlo Castellano II certifies that this is the approved version of the following report: SILVER AND BRONZE: CROSS-CULTURAL CURRENCIES IN ITALY AND SICILY Approved by supervising committee: Andrew M. Riggsby, Supervisor D. Alex Walthall SILVER AND BRONZE: CROSS-CULTURAL CURRENCIES IN ITALY AND SICILY by Giuseppe Carlo Castellano II, B.A. Master’s Report Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts The University of Texas at Austin May 2016 Matri et patri ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I would like to thank my committee, Andrew M. Riggsby and D. Alex Walthall, for their tireless help, guidance, and support. I would also like to thank Beth Chichester, Elizabeth Fentress, Ingrid M. Edlund-Berry, Karl Galinsky, William R. Nethercut, Adam T. Rabinowitz, and Rabun M. Taylor for their contributions to the success of this project. Finally, I thank my wife Chantel, the wind in my sails, lux ex tenebris. v SILVER AND BRONZE: CROSS-CULTURAL CURRENCIES IN ITALY AND SICILY by Giuseppe Carlo Castellano II, M.A. The University of Texas at Austin, 2016 Supervisor: Andrew M. Riggsby The monetization of Sicily took the form of an integration of native and Greek traditions of wealth and exchange. The Bronze and Iron Age indigeni of Italy and Sicily used weighed bronze – raw, ingots, and objects – as proto-monetary currency. When the Greeks arrived in the eighth century B.C., they introduced Greek weight standards, and were in turn introduced to native ones. -

Book of Abstracts
copertonaOK_Layout 1 20/06/2018 07:52 Pagina 1 Under the patronage and financial support of: Società Botanica International Symposium Italiana onlus Botany at the intersection of Nature, Culture, Art and Sciences Archaeological Park of Selinunte, Sicily, 28-30 June 2018 Book of abstracts Other sponsors: Lectures, Oral presentations, Posters Organized by: Bias Institute Financial support by: International Symposium Botany at the intersection of Nature, Culture, Art and Sciences Archaeological Park of Selinunte, Sicily, 28-30 June 2018 Book of abstracts Lectures, Oral presentations, Posters International Symposium Botany at the intersection of Nature, Culture, Art and Science Archaeological Park of Selinunte (SW Sicily), 28-30 June 2018 Book of abstracts Lectures, Oral presentations, Posters Editors: Cristina Salmeri, Gianniantonio Domina, Francesco M. Raimondo Technical Editing: Gianniantonio Domina Logo and Design: Vincenzo Magro June 2018 Printed by Cultural Association “Amici del libro e della stampa”, via Principe di Villafranca, 48a - Palermo, Italy. Copyright © OPTIMA 2018. Edited by OPTIMA Secretriat, Palermo, Italy. ISBN 978-88-943667-0-9 Hosting Institution Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa E. Caruso [Director] Organizing Commitee C. Salmeri, Italy [President] P. Campisi, Italy G. Domina, Italy M. L. Gargano, Italy A.M. Mannino, Italy P. Mazzola, Italy C. Modìca Donà dalle Rose, France / U.K. / Italy F. M. Raimondo, Italy Scientific Commitee V. H. Heywood, U.K. [President] E. Caruso, Italy G. Domina, Italy F. Ehrendorfer, Austria E. Gabrielian, Armenia F. Garbari, Italy W. Greuter, Germany S. Knapp, U.K. K. Marhold, Slovakia C. Modìca Donà dalle Rose, France / U.K. / Italy G. Moggi, Italy G. -

Routes4u Grant | Phoenicians' Route for EUSAIR Report on Activities Carried Out
Routes4U Grant | Phoenicians' Route for EUSAIR Report on activities carried out 1 Phoenicians' Route EUSAIR Smart Way The objectives of the project “Phoenicians’ Route EUSAIR Smart Way” was: - strengthening the trans-national and inter-regional co-operation, increase the knowledge of the tangible and intangible cultural heritage of the areas involved, in particular Italy, Croatia and Greece by working together with the cultural sector; - increase the knowledge of the tangible and intangible cultural heritage of the areas involved, in particular Italy, Croatia and Greece; - revitalizing tourism attractions and destinations, and diversifying transnational tourism experiences; - working on transnational products linked to cultural and tourist thematic itineraries which, due to their nature, cross national borders and respond better to the needs of the market and the trade. This means becoming part of a wider context, as we are on a path of excellence that guarantees the modern traveler standard and quality, hospitality and sense of belonging, according to a view which is more sensitive to the immaterial offers of tourism and consequently bringing the most satisfaction and fulfillment to the traveler. Putting together cultural and tourist realities of the Eusair area countries involved in the Phoenicians' Route, it will give life to an Adriatic Smart Way very competitive on the market and of great charm and attraction especially for tour operators, travel decision makers and travelers. The project will contribute to the objectives of the -

Map 47 Sicilia Compiled by R.J.A
Map 47 Sicilia Compiled by R.J.A. Wilson, 1997 Introduction The island of Sicily has a long tradition of antiquarian interest, and books and articles have been written on its topography since the sixteenth century. Some of the older works, such as Fazello (1558), Cluverius (1619), D’Orville (1764), and especially Houel (1782), still repay study. In more recent times, Sicily is fortunate to have had published, in Manni (1981), a systematic listing of all place names and other toponyms which occur in the ancient sources, although his identification with modern sites on the ground is not always reliable (cf. Wilson 1985). Another invaluable tool of research is Nenci and Vallet’s BTCGI (1977- ). In the last fifty years especially, there has been an explosion of archaeological research, the results of which can be followed in the quadrennial reports to the Palermo conferences appearing in Kokalos, as well as in other important conference volumes such as those on the area of the Elymi in western Sicily (Nenci 1992; 1997), or through the periodic reviews of Sicilian archaeological work published in ArchRep (most recently Wilson 1987; 1995). Also very useful are two volumes reporting on recent work by the Palermo Soprintendenza (Di Stefano 1993b; 1997). Yet despite all this scholarly interest and activity, many topographical questions remain unanswered. With regard to physical geography, coastline changes since antiquity are believed to have been minor, but little geomorphological work has been undertaken, with the exception of a pioneering survey of the south-east coastline (Basile 1988; Lena 1988). This has demonstrated a rise in sea level since antiquity affecting, among other places, the coastal topography of Syracuse itself.