This Must Be the Place
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Tangle of It
Reid MacDonald 109,300 words 553 Valim Way Author’s personal draft Sacramento, CA 95831 Printed on 11/5/14 (626) 354-0679 [email protected] THE TANGLE OF IT by Reid McFarland THE TANGLE of IT by Reid McFarland ⁂ For Vickie We’ve been apart for some time now I don’t know how to navigate these waters I love you and hope we can find some calm harbor ⁂ Herein tells a story where not all times and places match Forgive me those who are in the know So goes the way of memory and invention ⁂ McFarland / The Tangle of It Chapter 1. FRANNY'S CANDIES “I roll the Kettledrum candy in my mouth.” Franny pictures herself chewing on Boston Fruit Slices and her jaw flexes automatically. “Chewy wedges taste lemon and lime and go BOOM-bah-BOOM when I bite into one.” She adds, “When I unwrap a second Kettledrum out of its tight parchment, I examine the sour and sugar-copper rind. They are better enjoyed in pairs. Tomás, why aren’t Kettledrum candies hard? Like Lifesavers or Butterscotches? When they clink against your teeth, they could sound like a snare or a top hat. I can hear a soft bass rumble a tympani symphony deep within me. I swear, the Kettledrums make my voice go baritone when I sing BOOM-bah-BOOM after eating one. It’s true: I’ve tried it!” Franny confesses this to me under her gummy-bear breath and I agree unconditionally the way a best friend must. We come here because most of her schoolmates do not make their way down the block to Doña Dolce. -

The Music of the Goth Subculture: Postmodernism and Aesthetics Charles Allen Mueller
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2008 The Music of the Goth Subculture: Postmodernism and Aesthetics Charles Allen Mueller Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC THE MUSIC OF THE GOTH SUBCULTURE: POSTMODERNISM AND AESTHETICS By CHARLES ALLEN MUELLER A Dissertation submitted to the College of Music In partial fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Summer Semester, 2008 Copyright 2008 Charles Mueller All Rights Reserved The members of the Committee approve the dissertation of Charles Allen Mueller defended on June 12, 2008. __________________________ Charles E. Brewer Professor Directing Dissertation __________________________ Barry Faulk Outside Committee Member __________________________ Denise Von Glahn Committee Member __________________________ Douglass Seaton Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii ACKNOLEDGEMENTS I would like to extend my most sincere gratitude to the Presser Foundation who funded my research in Great Britain. I would also like to thank journalist Mick Mercer and the staff at Rough Trade in London who provided me with important insights into the development of goth music. All of the past and present goth participants and musicians who took the time to share with me their passion for music and life experiences also -

Sex Gang Children
http://www.lollipop.com/article.php3?text=2008/01jan/dvd-sexgangchil... GO Sex Gang Children Indie/Alternative Live At Ocean DVD (MVD) Stoner/Hard Rock by Ewan Wadharmi Punk/Power Pop Legend has it that The Cult’s Ian Astbury coined the phrase Metal/Hardcore "Goth" in reference to fans of Sex Gang Children. (Too bad Electro/Industrial The Cult didn’t bring them on tour instead of the silly Killers Compilations imitators, Action Action.) The gang were contemporaries of Joy Division, Sigue Sique Sputnik, and Sisters of Mercy. This incarnation contains Kevin Matthew on drums, Matthew Saw and Adrian Portas doing some fine work on guitar, Carl Magnusson on bass, and Martin Olofsson adding mysticism by violin. Longtime guitarist and collaborator Terry MacLeavy is absent. This 2002 London performance would've been great to witness: A generous 21 songs over an hour and a half, dramatic lighting, and impassioned delivery by the artists. Leader Andi Sexgang is fascinating to watch, creeping around the stage like some creature from the netherworld. But being there is a far cry from watching this grainy footage "Shot from the audience’s point of view," as the What is disc portrays. That means bootleg. Whether commissioned RSS? by the band, or sanctioned after the fact, this is a bootleg with substandard sound and shaky footage. If you can get past that, it’s pretty enjoyable. Ranging from Subscribe to our cold Euro-dance numbers to quasi-cabaret theatre and bass-driven tales of darkness, the pieces RSS feed constantly reveal their influences and point to their followers. -

Borghesia Corvus Corax
edition January - March 2015 free of charge, not for sale 16 quarterly published music magazine BORGHESIA CORVUS CORAX SEX GANG CHILDREN ELUVEITIE + RASTABAN SHE PAST AWAY + COCKSURE EMPUSAE + SAIGON BLUE RAIN CUÉLEBRE + 2ND CIVILIZATION - 1 - WOOL-E-TOP 10 WOOL-E-TOP 10 Best Selling Releases Best Selling Releases (Oct/Nov/Dec 2014) (January – December 2014) 1. MAN WITHOUT WORLD 1. THE KLINIK And Then It Ends (MC) Box (8CD) 2. VARIOUS ARTISTS 2. TRANSFIGURE The 15th (MC) Transfigure (MC) 3. FACTICE FACTORY 3. LUMINANCE The White Days (MC/CD/LP) Icons And Dead Fears (MC) 4. TRUE ZEBRA 4. UNIDENTIFIED MAN Adoremotion (CD) Remedy For Melancholy (MC) 5. SONAR 5. MAN WITHOUT WORLD Shadow Dancers (CD) And Then It Ends (MC) 6. SEBASTIEN CRUSENER 6. LUMINANCE / ACAPULCO CITY Dwaalspoor (MC) HUNTERS 7. WOODBENDER, CINEMA The Cold Rush (MC) PERDU, THE [LAW-RAH] 7. L’AVENIR COLLECTIVE The Wait (LP/CD) Blue Ruins Under Yellow Skies (MC) 8. PAS DE DEUX 8. NINE CIRCLES Cardiocleptomanie (LP) Alice (CD/LP) 9. SIMI NAH 9. NEUTRAL Be My Guest (CD) Grå Våg Gamlestaden (LP/MC) 10. VARIOUS ARTISTS 10. KIRLIAN CAMERA The 15th (MC) One (LP+7”) The Wool-E Shop - Emiel Lossystraat 17 - 9040 Ghent - Belgium VAT BE 0642.425.654 - [email protected] - 32(0)476.81.87.64 www.peek-a-boo-magazine.be - 2 - contents 04 CD reviews 22 Interview CUÉLEBRE 06 Interview SAIGON BLUE RAIN 24 MOVIE reviews 08 Interview RASTABAN 26 Interview SEX GANG CHILDREN 10 Interview EMPUSAE 28 CD reviews 12 CD reviews 30 Interview COCKSURE 14 Interview CORVUS CORAX 34 CD reviews 16 Interview -
Music-Week-1983-12-2
".. a new step in transcontinental A Cnrislmas Sons? "Noir Et Blanc" fyP" the major new W A album from vfe n HECTOR ZAZOU & BONI BIKAYE > iecfflfdls Presents VJ: (CRAM 025) '? Christmas Crammed Discs Cong &tstributed by Pinnacle 'phone: 0689 73144 CAT. NO. .IPR2 Distributed bv Pinnacle _ „0689 73144 TOP 5tiaMi THIS CHARMING MAN 22 HE'SREAD 1 1 8 The Smiths Rough Trade RT 136(1) 26 Red Lorry Yellow.Lorry Red Rhino RED 3911) 1 nryi'l PERVERTED BY LANGUAGERough Trade ROUGH 62 {» SUNBURST AND SNOWBLIND 23 TIME FLIES BUT AEROPLANES CRASH 2 1 5 SMELL OF FEMALE 2 2 4 Cocteau Twins 4AD BAD 314 (l/P) 27 Subhumans Bluurg FISH 511) Cramps Big Beat NED 6 IP) MUTINY 1983 27 3 CRAFTY FAG 3 2 8 HEAD OVER HEELS 3 4 4 The Birthday Party Mute MUTE 029(I/SP) 28 The Nighiingalos Ink/Red Flame INK 71 (l/RTI Cocteau Twins 4AD CAD 313 (I-'P) PUSH OUT THE BOAT MX AMERICA/SHADOW LOVE 4 8 3 LIFE'S A RIOT WITH SPY VS SPY 4 6 4 The Higsons Waapl WAAP4 (IDS) 29013 Vibrators Ram RM 7005 IP) Billy Bragg Go! Discs/Utility UT1L1 (IDS) 25 ZULU BEAT C 3 4 LIVE 5 5 5 THEConflict SERENDADE IS DEAD EPMortar Hate MORT 1 (IDS) 30 King Kurt Thin Sliced TSR2II) O The Meteors Wreckin* WRECK 10) 37 3 CRY HAVOC 6 4 35 HIGH LAND, HARD RAIN 6 15 2 DischargePRICE OFSILENCE Clay CLAY 29 (P) 31 Destructors Criminal Damage CR112104IBK/I) Aztec Camera Rough Trade ROUGH 47 IWOSl 24 3 MAURITIA MAYER BAB,ES REVENGE 7 7 5 RedFACTS Guitars SeK Drive SD 007(1) 32 Sex Gang Children Clay CLAY 27 IP) 7 HSZl GBF^ Clay CLAYLP 8 (PI O-J 33. -

Indie Top 50BLITZ MOORE NEW SINGLE Mind up Tonight 1012 E.T
M ELBADisco Top 50 Indie Top 50BLITZ MOORE NEW SINGLE mind up tonight 1012 E.T. BOOGIE 26 26 5 BAD BOY/HAVING A PARTY 4 2 FAT MAN 26 22 7 SHAKE UP THE CITY (EP) A A U.K. SUBS ABSTRACT ABS 012 PINNACLE EXTRA TS (SUNNYVIEW) IMPORT LUTHER VANDROSS EPIC EPC A(13)2776 CBS SOUTHERN DEATH CULT SITUATION 2 SIT 19 THE NEW SINGLE PINNACLE/CARTEL 27 25 6 JUST A GIRL NEW AGE 2 1 5 FRIENDS 27 28 9 YOU'VE SAID ENOUGH PALE FOUNTAINS OPERATION TWILIGHT OPT AVAILABLE IN SPECIAL BAG 2 1 7 SAVE YOUR LOVE SHALAMAR SOLAR CHUM 1(T) WEA CENTRAL LINE MERCURY MER(X) 117 RENEEAND RENATO HOLLYWOOD HWD 003 9 PINNACLE/CARTEL ON 7"AND 4 TRACK 12" POLYGRAM PINNACLE 28 35 7 THAT'S WHAT GOOD A 8 a BUFFALO GALS MIND UP TONIGHT MALCOLM MCLAREN CHARISMA MALC(T) 28 2713 ROCK AT YOUR OWN RISK 3 3 6 HEARTACHE AVENUE FRIENDS ARE FOR (Full lengthversion: 1(12) POLYGRAM PLANET PATROL (POLYDOR POS P(X)535 MAISONETTES READY STEADY GO RSG(T) 1 BRILLIANT LIMELIGHT LIME 7001 ROUGH AVAILABLE JANUARY 14 MIND UP TONIGHT IDS TRADE/CARTEL 4 3 7 LIUL 29 29 11 I DON'T WANNA DANCE (Instrumental) 10 2 HALLOWEEN NEW 1 LIONELRICH IE MOTOWN TMG 1284 RCA A A NO CONCERN EDDY GRANT ICE ICE(T) 56 RCA DEAD KENNEDYS STATIK/ALTERNATIVE MAU MAUS PAX PAX 8CAFiTEL PIECE OF THE ROCK TENTACLES STAT 27 ROUGH TRADE/CARTEL Future Records FS 1 5 2 7 HEAVY VIBES 30 24 9 KEEP THE FIRE BURNING 30 27 10 BABY TURNS BLUE THE OTHER SIDE MONTANA SEXTET VIRGIN VS 560(12) CBS GWEN MCCRAE ATLANTIC FLAM 1(T) WEA 5 5 6 FOR YOU VIRGIN PRUNES ROUGH TRADE RT 119(T) ANTI -NOWHERE LEAGUE WXYZ ABCD 6 ROUGH TRADE/CARTEL OF THE RAINBOW PINNACLE/FAULTY/CARTEL 6 4 10 YOUNG GUNS (GO FOR IT) DISTRIBUTION. -
Cambridge University Press 978-1-107-17689-8 — No Future Matthew Worley Index More Information
Cambridge University Press 978-1-107-17689-8 — No Future Matthew Worley Index More Information 381 Index Above the Ruins (band), 157 – 58 anarchist movement Abrasive Wheels (band), 24 – 25 , 96 – 97 mind- set of, 1 – 3 ACAB (All Coppers Are Bastards), 230 Sex Pistols’ referencing of, 10 academic studies of punk, 21 – 22 Anarchist Youth Federation, 163 – 64 A Certain Ratio (band), 73 – 76 anarcho- punk, 8 , 259n. 44 Action Pact (band), 24 – 25 , 117 – 18 activism of, 166 Acts of Defi ance (fanzine), 166 classifi cation of, 46 – 48 Adam and the Ants (band), 119 – 20 , gender politics and, 189 – 92 129 – 30 , 210 history of, 21 Adam Ant. See Goddard, Stuart homosexuality and, 201 – 2 The Adicts, 241 – 43 masculinity and, 203 – 4 Adorno, Theodor, 40 – 41 , 72 – 73 politics and evolution of, 158 – 71 , 231 , The Adventures of Sweet Gwendolyn 234 – 35 (Willie), 212 RAR and, 150 – 51 Advert, Gaye, 178 – 80 self- produced labels by, 72 – 73 advertising, punk’s critique of, 77 – 78 Stop the City campaign and, 167 – 68 The Adverts (band), 90 , 112 – 13 , 178 suburbia critiqued by, 119 – 20 The Affl icted (band), 156 – 58 Anarchy Collective, 168 Afghanistan, Soviet invasion of, 239 – 40 ‘Anarchy in the UK’ (Sex Pistols) After Hours (fanzine), 59 – 60 Northern Ireland violence and, 234 – 35 agency politics and lyrics of, 39 – 40 , 89 – 90 , media as tool for, 77 – 78 158 – 59 punk’s drive for, 46 – 48 , 55 – 57 , 74 – 76 , popularity of, 24 – 25 248 , 252 – 54 release of, 5 – 6 , 65 – 66 Albertine, Viv, 177 – 79 Anarchy in the UK fanzine, 253 – 54 Allen, Richard, 215 – 17 Anathema fanzine, 44 – 45 Allen, Ros, 179 – 80 Andi Sex Gang. -

'Infected by the Seed of Post- Industrial Punk Bohemia'
[PMH 3.2 (2008) 103-122] Popular Music History (print) ISSN 1740-7133 doi:10.1558/pomh.v3i2.103 Popular Music History (online) ISSN 1743-1646 Peter Webb ‘Infected by the seed of post- industrial punk bohemia’: Nick Cave and the milieu of the 1980s underground Peter Webb is a lecturer and researcher in Media Department of Sociology and Culture in the Department of Sociology at 32 Pritchatts Road, Edgbaston, the University of Birmingham. He has published Birmingham, B15 2TT work on the Internet and the music and fashion UK industries, music scenes or milieu, notions of [email protected] independence in the music industry, globaliza- tion and music and theories of music cultures. He also is a musician who has released several albums, singles and EPs under the name ‘Statik Sound System’. Abstract This article uses the concepts of cultural milieu and music genre to explore the work of Nick Cave in the 1980s and later. Milieu theory is derived from the work of phenomenologists Alfred Schutz and Jorg Durschmitt. The article analyses the transgressive milieu of Cave and such col- laborators as Blixa Bargeld and Lydia Lunch and considers the way in which the music genres of punk, post-punk, gothic and industrial have been implicated in Nick Cave’s recorded output. Keywords: genre, gothic, industrial, milieu, post-punk, punk, scenes There’s a real need for an intelligent but aggressive group in London. All the treasured groups are just so softcore. At one time there was a real upsurge of new young groups and incredible records like ‘She is beyond Good and Evil’, you know the Pop Group before they sacrificed the music for that soapbox, toilet-roll politics. -

Cob Records Porthmadog, Gwynedd, Wales
COB RECORDS PORTHMADOG, GWYNEDD, WALES. LL49 9NA Tel:01766-512170. Fax: 01766 513185 www.cobrecords.com e-mail [email protected] CD RELEASES & RE-ISSUES JANUARY 2001 – DECEMBER 2003 “OUR 8,000 BEST SELLERS” ABOUT THIS CATALOGUE This catalogue lists the most popular items we have sold over the past three years. For easier reading the three year compilation is in one A-Z artist and title formation. We have tried to avoid listing deletions, but as there are around 8,000 titles listed, it is inevitable that we may have inadvertently included some which may no longer be available. For obvious reasons, we do not actually stock all listed titles, but we can acquire them to order within days providing there are no stock problems at the manufacturers. There are obviously tens of thousands of other CDs currently available – most of them we can supply; so if what you require is not listed, you are welcome to enquire. Please read this catalogue in conjunction with our “CDs AT SPECIAL DISCOUNT PRICES” as some of the more mainstream titles may be available at cheaper prices in that feature. Please note that all items listed on this catalogue are of U.K. manufacture (apart from Imports denoted IM or IMP). Items listed on our Specials are a mix of U.K. and E.C. manufacture; we will supply you the items for the price/manufacturer you chose. ******* WHEN ORDERING FROM THIS CATALOGUE PLEASE QUOTE CAT 01/03 ******* the visitors r/m 8.50 live 7.50 ALCHEMY live at t’ fillmore east deluxe 16.50 tales of alibrarian coll’n+ DVD 20.00 10 CC voulez vous r/m 8.50 -

Take the Mick
THE MICK CHRIS & T OY Issue 58 AH PHO September 2014 T O: Dean S t ockings CHRIS LIMB Author of I Was A Teenage Toyah Fan We’re back!!! with DEEJAY JACK PHOENIX + FAUXCHISELS + FEAR INCORPORATED + FRIENDS OF ALICE IVY and 46 reviews EDITORIAL VOMIT Cute Edwardian murals we discovered beneath layers of old wallpaper when redecorating! Been a while, hasn’t it? Life intrudes, like a great liner crashing 14. SEX GANG CHILDREN - Die Traube through some mental cliff, and no matter how much time I 13. UK DECAY - All the Faces in History thought I had any hope of planning and executing the 12. THE MARCH VIOLETS - Road Of Bones magazine simply didn’t come into it. 11. ATARAXIA - Donc, Je Dois Etre Morte! 10. IVORIES - Kill By Silence It’s nice that things are coming back into shape. Thanks to 9. LES PANTIES - L’Arrivee Lynda I am now doing a weekly online radio show you can 8. THE BLACK AND BLUE ORKESTRE - Nervous Laughter listen to – details on the back cover. Great new sounds flirt 7. THE ILLUSION FADES - We Are The Same with delectable oldies. It’s a heavenly mixture. Details are on 6. LIVE NOT ON EVIL - Nothing’s Wrong my facebook page(s) as and when details occur to me during 5. MOLDIG - E.S.P. Red Light” the week. Hopefully you will stop by and have a listen. 4. FLOOD OF TEARS - The World In the Summer I did my Top 30 of the year, which may give a 3. THE DARK SHADOWS - Eisbär decent hint as to what bands may be coming through over the 2. -

Culture Club – Primary Wave Music
CULTURE CLUB facebook.com/BoyGeorgeOfficial instagram.com/cultureclubofficial twitter.com/RealCultureClub Imageyoutube.com/channel/UCdfnMLE8x991WuXK- not found or type unknown 3SRgNQ boygeorgeandcultureclub.net en.wikipedia.org/wiki/Culture_Club open.spotify.com/artist/6kz53iCdBSqhQCZ21CoLcc Few new wave groups were as popular as Culture Club. During the early ’80s, the group racked up seven straight Top Ten hits in the U.K. and six Top Ten singles in the U.S. with their light, infectious pop-soul. Though their music was radio-ready, what brought the band stardom was Boy George, the group’s charismatic, cross- dressing lead singer. George dressed in flamboyant dresses and wore heavy makeup, creating a disarmingly androgynous appearance that created a sensation on early MTV. George also had a biting wit and frequently came up with cutting quips that won Culture Club heavy media exposure in both America and Britain. Although closely aligned with the new romantics — they were both inspired by Northern soul and fashion — Culture Club had a sharper pop sense than their peers, and consequently had a broader appeal. However, their time in the spotlight was brief. Not only could they not withstand the changing fashions of MTV, but the group was fraught with personal tensions, including Boy George’s drug addiction. By 1986, the group had broken up, leaving behind several singles that rank as classics of the new wave era. The son of a boxing club manager, Boy George (b. George O’Dowd, June 14, 1961), found himself attracted to the glam rock of T. Rex and David Bowie as a teenager. -
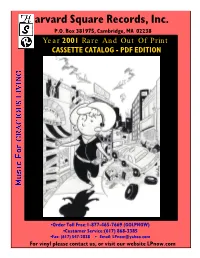
Cassette Catalog - Pdf Edition
arvard Square Records, Inc. P.O. Box 381975, Cambridge, MA 02238 Year 2001 Rare And Out Of Print CASSETTE CATALOG - PDF EDITION •Order Toll Free:1-877-465-7669 (GOLPNOW) •Customer Service:(617) 868-3385 •Fax: (617) 547-2838 • Email: [email protected] For vinyl please contact us, or visit our website LPnow.com arvard Square Records, Inc. P.O. Box 381975, Cambridge, MA 02238 Year 2001 Rare And Out Of Print CASSETTE CATALOG - PDF EDITION •Order Toll Free:1-877-465-7669 (GOLPNOW) •Customer Service:(617) 868-3385 •Fax: (617) 547-2838 • Email: [email protected] For vinyl please contact us, or visit our website LPnow.com Special Note on Reserving Stock and Song Titles: Customer Info We do not reserve any stock nor do we have the song titles of any title available to us. Please do not call or email to see if something is in stock or Please read this before calling with questions. what songs are on any title. Everything in this catalog is available to us at press time, but we cannot guarantee the availability of any title on the HI! HI! phone. Placing an order is the best and fastest way to insure you get the Welcome to our year 2001 Sealed Cassette Catalog. titles you want. Orders begin only when payment or credit card # is received. We had no 1999/2000 Cassette catalog (sorry) so this is our 1st cassette The sooner you order, the sooner you will get your order. catalog since our 1998 one, which is now void. This catalog will be good We have many sources for most of the titles listed, but some titles have no until the end of 2001.