NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2.II Sardegna E Sicilia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Coinage of Akragas C
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Numismatica Upsaliensia 6:1 STUDIA NUMISMATICA UPSALIENSIA 6:1 The Coinage of Akragas c. 510–406 BC Text and Plates ULLA WESTERMARK I STUDIA NUMISMATICA UPSALIENSIA Editors: Harald Nilsson, Hendrik Mäkeler and Ragnar Hedlund 1. Uppsala University Coin Cabinet. Anglo-Saxon and later British Coins. By Elsa Lindberger. 2006. 2. Münzkabinett der Universität Uppsala. Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und späten Mittelalters. By Peter Berghaus and Hendrik Mäkeler. 2006. 3. Uppsala universitets myntkabinett. Svenska vikingatida och medeltida mynt präglade på fastlandet. By Jonas Rundberg and Kjell Holmberg. 2008. 4. Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala universitets myntkabinett. 2009. 5. ”…achieved nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260–295. By Ragnar Hedlund. 2008. 6:1–2. The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. By Ulla Westermark. 2018 7. Musik på medaljer, mynt och jetonger i Nils Uno Fornanders samling. By Eva Wiséhn. 2015. 8. Erik Wallers samling av medicinhistoriska medaljer. By Harald Nilsson. 2013. © Ulla Westermark, 2018 Database right Uppsala University ISSN 1652-7232 ISBN 978-91-513-0269-0 urn:nbn:se:uu:diva-345876 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-345876) Typeset in Times New Roman by Elin Klingstedt and Magnus Wijk, Uppsala Printed in Sweden on acid-free paper by DanagårdLiTHO AB, Ödeshög 2018 Distributor: Uppsala University Library, Box 510, SE-751 20 Uppsala www.uu.se, [email protected] The publication of this volume has been assisted by generous grants from Uppsala University, Uppsala Sven Svenssons stiftelse för numismatik, Stockholm Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning, Stockholm Faith and Fred Sandstrom, Haverford, PA, USA CONTENTS FOREWORDS ......................................................................................... -

Sakraler Raum – Sakrale Räume“, FS 2012 Agrigent A
Bibliographie Seminar „Sakraler Raum – Sakrale Räume“, FS 2012 Agrigent A. Bellia, Music and Rite. Musical Instruments in the Sanctuary of the Chthonic Divinities in Akragas (6th Century BC), in: R. Eichmann – E. Hickmann – L.-Ch. Koch (Hrsg.), Studien zur Musikarchäologie VII. Musikalische Wahrnehmung in Vergangenheit und Gegenwart. Ethnographische Analogien in der Musikarchäologie. Vorträge des 6. Symposiums der Internationalen Studiengruppe Musikarchäologie in Berlin, 9.-13. September 2008 (Rahden 2010) 3-8. P. Meli, Asklepieion di Agrigento: Restauro e ricostituzione del bosco sacro, in: E. De Miro – G. Sfameni Gasparro – V. Calì (Hrsg.), Il culto di Asclepio nell’area mediterranea. Atti del Convegno Internazionale, Agrigento 20-22 novembre 2005 (Rom 2009) 175- 177. C. Zoppi, La lavorazione del crepidoma e il problema della datazione del tempio di Asclepio di Agrigento, SicA 39, 2006, 47-54. G. Arnone, L’Asklepieion akragantino, Archivio storico siciliano 31, 2005, 251-256. V. Calì, I santuari ctoni di Agrigento e Siracusa, in: P. Minà (Hrsg.), Urbanistica e architettura nella Sicilia greca. Ausstellungskatalog Agrigent (Palermo 2005) 178-181. G. Fiorentini, Agrigento. La nuova area sacra sulle pendici dell’Acropoli, in: R. Gigli (Hrsg.), ΜΕΓΑΛΑΙ ΝΗΣΟΙ. Studi dedicati a Giovanni Rizza per il suo ottantesimo compleanno 2 (Palermo 2005) 147-165. G. Ortolani, La valle dei templi di Agrigento (Rom 2004). C. Zoppi, Le fasi costruttive del cosidetto santuario rupestre di San Biagio ad Agrigento: Alcune osservazioni, SicAnt 1, 2004, 41-79. E. De Miro, Agrigento II. I santuari extraurbani. L’Asklepieion (Rom 2003). J. de Waele, La standardizzazione dei blocchi nei templi „gemelli“ di Agrigento, in: G. Fiorentini – M. -

ANCIENT TERRACOTTAS from SOUTH ITALY and SICILY in the J
ANCIENT TERRACOTTAS FROM SOUTH ITALY AND SICILY in the j. paul getty museum The free, online edition of this catalogue, available at http://www.getty.edu/publications/terracottas, includes zoomable high-resolution photography and a select number of 360° rotations; the ability to filter the catalogue by location, typology, and date; and an interactive map drawn from the Ancient World Mapping Center and linked to the Getty’s Thesaurus of Geographic Names and Pleiades. Also available are free PDF, EPUB, and MOBI downloads of the book; CSV and JSON downloads of the object data from the catalogue and the accompanying Guide to the Collection; and JPG and PPT downloads of the main catalogue images. © 2016 J. Paul Getty Trust This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042. First edition, 2016 Last updated, December 19, 2017 https://www.github.com/gettypubs/terracottas Published by the J. Paul Getty Museum, Los Angeles Getty Publications 1200 Getty Center Drive, Suite 500 Los Angeles, California 90049-1682 www.getty.edu/publications Ruth Evans Lane, Benedicte Gilman, and Marina Belozerskaya, Project Editors Robin H. Ray and Mary Christian, Copy Editors Antony Shugaar, Translator Elizabeth Chapin Kahn, Production Stephanie Grimes, Digital Researcher Eric Gardner, Designer & Developer Greg Albers, Project Manager Distributed in the United States and Canada by the University of Chicago Press Distributed outside the United States and Canada by Yale University Press, London Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: J. -

Iconography of the Gorgons on Temple Decoration in Sicily and Western Greece
ICONOGRAPHY OF THE GORGONS ON TEMPLE DECORATION IN SICILY AND WESTERN GREECE By Katrina Marie Heller Submitted to the Faculty of The Archaeological Studies Program Department of Sociology and Archaeology In partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science University of Wisconsin-La Crosse 2010 Copyright 2010 by Katrina Marie Heller All Rights Reserved ii ICONOGRAPHY OF THE GORGONS ON TEMPLE DECORATION IN SICILY AND WESTERN GREECE Katrina Marie Heller, B.S. University of Wisconsin - La Crosse, 2010 This paper provides a concise analysis of the Gorgon image as it has been featured on temples throughout the Greek world. The Gorgons, also known as Medusa and her two sisters, were common decorative motifs on temples beginning in the eighth century B.C. and reaching their peak of popularity in the sixth century B.C. Their image has been found to decorate various parts of the temple across Sicily, Southern Italy, Crete, and the Greek mainland. By analyzing the city in which the image was found, where on the temple the Gorgon was depicted, as well as stylistic variations, significant differences in these images were identified. While many of the Gorgon icons were used simply as decoration, others, such as those used as antefixes or in pediments may have been utilized as apotropaic devices to ward off evil. iii Acknowledgements I would first like to thank my family and friends for all of their encouragement throughout this project. A special thanks to my parents, Kathy and Gary Heller, who constantly support me in all I do. I need to thank Dr Jim Theler and Dr Christine Hippert for all of the assistance they have provided over the past year, not only for this project but also for their help and interest in my academic future. -

Provincia Di AGRIGENTO Provincia Di CALTANISSETTA Provincia Di
REPUBBLICA ITALIANA CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA a l o v a o t l o a c d o i i l c n o a i i REGIONE SICILIANA a v a o s g m o n l o c s u i s o o t v o o i l l c a i c l e o r t i c a o e o r i o f f s Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea i a s v c f e c i i e b n m i o r o p a i v t v / t u i i - o p p t e l r e m a o Servizio III - U.O. S3.01 d t u V g m e r e O r o n C l t o S o A F a l a e c i t F s P o M e l r o o c i F t Elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31/12/2020 (D.D.G. n. 4129 del 29/06/2015) t u r F Numero di accreditamento Titolare Denominazione Ubicazione Comune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Provincia di AGRIGENTO Società Semplice Agricola Fattoria 1 Società Semplice Agricola Fattoria Vassallo C/da Volpara Licata X X X X X X Vassallo 13 Vetro Antonino Azienda Didattica Casa Portulano C/da Gasena Agrigento X X X 21 Reina Lorenzo Fattoria Didattica "Rocca Reina" C/da Rocca Santo Stefano Quisquina X X X X 24 Leto Serena Azienda Didattica Leto Serena C/da Feudo San Giovanni San Biagio Platani X X X X Azienda Didattica "Case laboratorio 31 Tomasino Marcella C/da S.Giacomo Sambuca di Sicilia X X S.Giacomo" 53 Giambrone Marco Fattoria didattica "Giambrone Fattoria" C/da Passo del Barbiere Cammarata X X X 72 Sciortino Nicolò Antonio Maurizio Fattoria Didattica "Sicilia è ….gusto" C/da Sabuci - Safarella Licata X X X X 78 Mangiapane Maria Giuseppa Fattoria Didattica "Le Vacche Rosse" C/da Casalicchio Cammarata X 79 Loria Francesco Fattoria Didattica "Quartararu" -

Ancient Stones Book.Indb
Ancient Stones The Dolmen Culture in Prehistoric South-eastern Sicily ANCIENT STONES The Dolmen Culture in Prehistoric South-eastern Sicily Salvatore Piccolo Introduction by Timothy Darvill OBE Brazen Head Publishing Brazen Head Publishing Lombardy House, Thornham, Norfolk, PE36 6LX, United Kingdom www.brazenheadpublishing.co.uk Published in the United Kingdom by Brazen Head Publishing 2013 First published in Italian in 2007 by Morrone Editore as ‘Antiche Pietre. La Cultura dei Dolmen nella Preistoria della Sicilia Sud-Orientale’ Copyright © Salvatore Piccolo 2013 Translation copyright © Jean Woodhouse 2013 Preface copyright © Timothy Darvill 2013 All images are copyright © of the author unless otherwise stated. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of Brazen Head Publishing. Within the UK, exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright, Design and Patents Act, 1988, or in the case of reprographic reproduction in accordance with the terms of licenses issued by the Copyright Licensing Agency. Enquiries concerning reproduction outside those terms in other countries should be sent to the Rights Department, Brazen Head Publishing, at the address above. This book is sold subject to the conditions that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. -
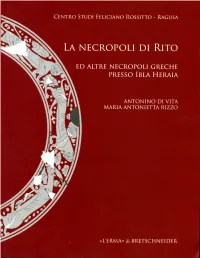
Rizzo 2015, 9, Rito 2.Pdf
C S F R - R LA NECROPOLI DI RITO ED ALTRE NECROPOLI GRECHE PRESSO IBLA HERAIA Antonino Di Vita e Maria Antonietta Rizzo «L’Erma» di Bretschneider 01-Premessa.indd 3 24/03/2015 12:33:38 Volume edito grazie al contributo di Cora Banche e Cora Industria Antonino D! V!"#, M#$!# A%"&%!'""# R!((& La necropoli di Rito ed altre necropoli greche presso Ibla Heraia, Bibliotheca Archaeologica, 51 © Copyright 2015 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER via Cassiodoro 11 - 00193 Roma www.lerma.it Progetto gra+co di Monica Livadiotti Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore. ISBN 978-88-913-0800-9 ISBN digitale 978-88-913-0796-5 In copertina: kotyle corinzia della Tomba 58/1 (dis. di C.W. Nee) (nel testo, alla g. 404). 01-Premessa.indd 4 24/03/2015 12:33:38 SOMMARIO p. 7 G. C, Presentazione 9 A. D V!, M.A. R""#, La necropoli di Rito 11 A. D V!, Premessa 13 A. D V!, La necropoli 13 Lo scavo 15 Organizzazione della necropoli 18 Tipologia delle sepolture 22 La popolazione 23 Il corredo 27 A. D V!, M.A. R""#, Le tombe e i corredi 29 A. D V!, Premessa al Catalogo 31 M.A. R""#, Catalogo 181 M.A. R""#, Tipologie dei materiali e cronologia delle tombe 221 A. D V!, Le altre necropoli greco-arcaiche di Ragusa 239 Appendici 241 A. D V!, Appendice 1: 1959. Tabuna Petrulli, tombe tardo-antiche 243 A. D V!, Appendice 2: Sir John D. -

Conference Programme
conference programme EUROPEAN ARCHITECTURAL HISTORY NETWORK EAHN SECOND INTERNATIONAL MEETING PALAIS DES ACADEMIES BRUSSELS, BELGIUM 31 MAY - 3 JUNE 2012 ORGANIZING COMMITTEE Thomas Coomans, K.U.Leuven Dirk De Meyer, UGent Els De Vos, Artesis Hogeschool Antwerpen Rika Devos, UGent Jean-Louis Genard, ULB, Faculté d’architecture La Cambre-Horta SCIENTIFIC COMMITTEE Janina Gosseye, K.U.Leuven Jorge Correia, University of Minho Hilde Heynen, K.U.Leuven Krista De Jonge, K.U.Leuven Ruth Hommelen, St. Lucas Adrian Forty, UCLondon Bernard Kormoss, Université de Liège Hilde Heynen, K.U.Leuven Judith le Maire, ULB, Mari Hvattum, AHO Oslo Faculté d’architecture La Cambre-Horta Susan Klaiber, independent scholar Piet Lombaerde, Universiteit Antwerpen Dietrich Neumann, Brown University Anne-Françoise Morel, UGent Edoardo Piccoli, Politecnico di Torino Sven Sterken, St. Lucas Belgin Turan, METU Ankara Francis Strauven, UGent David Vanderburgh, UCLouvain Koenraad Van Cleempoel, UHasselt THURSDAY, 31 MAY 2012 FRIDAY, 1 JUNE 2012 SATURDAY, 2 JUNE 2012 EUROPEAN ARCHITECTURAL HISTORY NETWORK EAHN SECOND INTERNATIONAL MEETING PALAIS DES ACADEMIES BRUSSELS, BELGIUM 31 MAY - 3 JUNE 2012 9 9.00 - 11.45 9.00 - 11.45 Across Geographies: Shifting Boundaries of Siege Views and the Representation of Cities in Early Modern Europe ■ Renaissance Architectural Historiography ■ New Ideas, new models? Communicating Architecture: Working with Documents in Construction ● Architectural Representation and its Objects in the Twentieth Century ● 10 Giorgio Ciucci lecture in BOZAR Clerical ties: Architectural Networks and Networking Architecture and Territoriality in Medieval Europe ▲ ▲ thursday, 31 may 2012 (20.00 - 22.00) in the Colonial Mission field, 1500-1900 Neither "Modernism" nor avant-garde: A Roundtable Discussion Giorgio Ciucci Memory, Identity, and Community in Architecture and Urbanism ♠ ♠ in honour of the ninetieth birthday of Alan Colquhoun *Title of lecture - to be confirmed* 11 "Development" from the Periphery. -

WER--,-B REGIONE SICILTANA ASSESSORATO BENT CULTURALI AMBIENTALT E P.I
V ; WER--,-b REGIONE SICILTANA ASSESSORATO BENT CULTURALI AMBIENTALT E P.I. SOPRINTENDENZA BENT CULTURALT ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO UNIVERSITA DEGLT STUDI DT MESSINA I I (I) !iIfl STUDI IN ONORE DI ERNESTO DE MIRO Fiorentini G., Caltabiano M., Calderone A. (edd.) <<L'ERMA di BRETSCIUNEIDER Archeologia del Mediterraneo Studi in onore di Ernesto De Miro Fiorentini G., Caltabiano M., Calderone A. (edd.) © Copyright 2003 <L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER Via Cassiodoro, 19— 00193 Roma © Copyright 2003 Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione Tutti i diritti riservati E vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza ii permesso scritto dell'editore. ISBN 88-8265-134-7 Archeologia del Mediterraneo Studi in onore di Ernesto De Miro. - Palermo Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei beni culturali ambientali e deIl'educazione permanente : Roma: L'Erma di Bretschneider, 2003 1. De Miro, Ernesto 930.1 CDD-20 SBNPa1O194417 CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana INDICE Presentazione di A. Calderone, M. Caltabiano, G. Fiorentini ............................................................. 9 Bibliografiadi Ernesto De Miro ......................................................................................................... 17 PER UN PORTOLANO FENICIO, di ENRICO ACQUARO ..................................................................... 21 ANFORE COMMERCIALI DAL CENTRO INDIGENO DELLA MONTAGNA DI RAMACCA (CATANIA), di ROSA MARIA ALBANESE PROCELLI ........................................................................... 37 IL GRUPPO DI SCILLA DI SPERLONGA RICOMPOSTO, di BERNARD ANDREAE .......................... 51 LA CE1AMICA GRECA TRA IL V E IL IV SEC. A.C. RINVENUTA IN ITALIA, di P. E. ARIAS t.. 61 NOTE SULLA COROPLASTICA RINVENUTA NELL'AREA INDIGENA DELL'ANTICA BASI- LICATA (VT-Ill SEC. A.C.), di M. BARRA BAGNASCO ..................................................................... 69 DEDALO E ICARO A HIMERA, di N. -

Aus: Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik 128 (1999) 115–123
GIACOMO MANGANARO LA SYRAKOSION DEKATE, CAMARINA E MORGANTINA NEL 424 A.C. aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 128 (1999) 115–123 © Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 115 LA SYRAKOSION DEKATE, CAMARINA E MORGANTINA NEL 424 A.C. Lo studioso di storia antica deve lavorare quasi sempre con poche o tardive fonti letterarie, nel caso migliore storiografiche, sulla base delle quali, secondo un corretto metodo filologico, può offrire ricostruzioni ipotetiche, anche se possono trovare riscontro in analoghi fenomeni moderni, conosciuti nei particolari. Solo per alcune aree ed epoche meno arcaiche può avere modo di integrare le fonti letterarie con altre epigrafiche (o papirologiche) e numismatiche, e volgersi alla lettura storica del materiale archeologico. Il fenomeno della colonizzazione greca nei secoli VIII–VI a.C., recentemente rivangato senza sosta, per l’area occidentale è tramandato in una tradizione laconica, riproposta da Tucidide secondo una griglia cronologica chiaramente costruita, e comunque da accogliere come la più sicura, e con elementi etnici e geopolitici ridottissimi. Lo storico ateniese ebbe a desumerla verosimilmente dal siracusano Antioco, attivo alla fine del V sec. a.C.1 Questa tradizione era stata già modellata accogliendo anche elementi intesi a esaltare il ruolo del Santuario di Delfi, assurto ormai a livello panellenico. Antioco appunto conosce l’intervento dell’oracolo delfico a proposito della fondazione di Crotone, ad opera di Miscello, che avrebbe richiesto per la sua apoikia un territorio fertile (quello di Sibari gli era parso il migliore) e afferma la contemporaneità della fondazione di Crotone e di Siracusa, il cui ecista Archia si sarebbe incontrato a Delfi con Miscello, col quale avrebbe collaborato2. -

The Deinomenids of Sicily: the Appearance and Representation of a Greek Dynastic Tyranny in the Western Colonies
THE DEINOMENIDS OF SICILY THE DEINOMENIDS OF SICILY: THE APPEARANCE AND REPRESENTATION OF A GREEK DYNASTIC TYRANNY IN THE WESTERN COLONIES By: LOUISE MARY SAVOCCHIA, B.A. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree Master of Arts McMaster University © Copyright by Louise Mary Savocchia, September 2012. MASTER OF ARTS (2012) McMaster University (Classics) Hamilton, Ontario TITLE: The Deinomenids of Sicily: The Appearance And Representation of a Greek Dynastic Tyranny in the Western Colonies AUTHOR: Louise Mary Savocchia, B.A. (McMaster University) SUPERVISOR: Professor Spencer Pope NUMBER OF PAGES: viii, 175 ii Abstract The aim of this thesis has been to investigate and analyze the tyranny of the Deinomenids (491 – 466 BC), a family who controlled several Greek colonies located on the island of Sicily. Modern classical scholarship has often ignored the history and contributions this family has made to the Greek world or has taken a limited view of the family. I intend to present a comprehensive account of the Deinomenids and to demonstrate how this family, which has received little attention, played a major role in the Greek world. I will look into several aspects regarding their tyranny that have often been overlooked, including the ways in which they invented claims about themselves and manipulated their identities in order to elevate their status as rulers in Sicily. In addition to this, I will use the Deinomenids as a case study to illustrate the tension felt between the mainland and the Greek colonies in Sicily, as well as demonstrating how the West influenced and informed many of the advancements seen on the mainland in later generations. -

Überschrift 1
Sanctuaries and the Power of Consumption Networking and the Formation of Elites in the Archaic Western Mediterranean World Proceedings of the International Conference in Innsbruck, 20th–23rd March 2012 Edited by Erich Kistler, Birgit Öhlinger, Martin Mohr and Matthias Hoernes 2015 Harrassowitz Verlag . Wiesbaden KKistler.inddistler.indd AAbs13bs13 221.10.20151.10.2015 114:40:224:40:22 P H I L I P P I K A Altertumswissenschaftliche Abhandlungen Contributions to the Study of Ancient World Cultures Herausgegeben von/Edited by Joachim Hengstl, Elizabeth Irwin, Andrea Jördens, Torsten Mattern, Robert Rollinger, Kai Ruffi ng, Orell Witthuhn 92 2015 Harrassowitz Verlag . Wiesbaden KKistler.inddistler.indd AAbs12bs12 221.10.20151.10.2015 114:40:224:40:22 Bis Band 60: Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen. The publication of this volume was funded by the Provinces of the Tyrol and Vorarlberg, the Hypo Tirol Bank, the Aktion D. Swarovski KG as well as the research area “Cultural Encounters – Cultural Confl icts” and the Italien-Zen- trum at Innsbruck University. Bibliografi sche Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografi e; detailed bibliographic data are available on the internet at http://dnb.dnb.de. For further information about our publishing program consult our website http://www.harrassowitz-verlag.de © Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2015 This work, including all of its parts, is protected by copyright.