I Testi Della Paura E Dell'incubo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

American Abstract Expressionism
American Abstract Expressionism Cross-Curricular – Art and Social Studies Grades 7–12 Lesson plan and artwork by Edwin Leary, Art Consultant, Florida Description Directions This project deals with the infusion between Art History Teacher preparation: and Art Making through American Abstract Expressionism. Gather examples of artists that dominated this movement, American Abstract Expressionism is truly a U.S. movement that display them in the Art Room with questions of: Who uses emphasizes the act of painting, inherent in the color, texture, organic forms? Dripped and splashed work? Why the highly action, style and the interaction of the artist. It may have been colored work of Kandinsky? Why the figurative aspects of inspired by Hans Hofmann, Arshile Gorky and further developed DeKooning? by the convergence of such artists as Jackson Pollack, William With the students: DeKooning, Franz Kline, Mark Rothko and Wassily Kandinsky. 1 Discuss the emotions, color and structure of the displayed Objectives artists’ work. Discuss why American Abstract Expressionism is less about • Students can interactively apply an art movement to an art 2 process-painting. style than attitude. • This art-infused activity strengthens their observation and 3 Discuss why these artists have such an attachment of self awareness of a specific artist’s expression. expression as found in their paintings yet not necessarily found in more academic work? Lesson Plan Extensions 4 Gather the materials and explain why the vivid colors of Apply this same concept of investigation, application and art Fluorescent Acrylics were used, and what they do within a making to other movements or schools of art. -
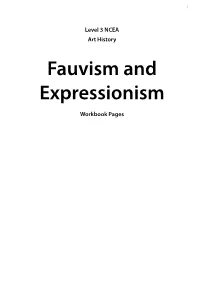
Fauvism and Expressionism
Level 3 NCEA Art History Fauvism and Expressionism Workbook Pages Fauvism and Expressionism What this is: Acknowledgements These pages are part of a framework for students studying This workbook was made possible: NCEA Level 3 Art History. It is by no means a definitive • by the suggestions of Art History students at Christchurch document, but a work in progress that is intended to sit Girls’ High School, alongside internet resources and all the other things we • in consultation with Diane Dacre normally do in class. • using the layout and printing skills of Chris Brodrick of Unfortunately, illustrations have had to be taken out in Verve Digital, Christchurch order to ensure that copyright is not infringed. Students could download and print their own images by doing a Google image search. While every attempt has been made to reference sources, many of the resources used in this workbook were assembled How to use it: as teaching notes and their original source has been difficult to All tasks and information are geared to the three external find. Should you become aware of any unacknowledged source, Achievement Standards. I have found that repeated use of the please contact me and I will happily rectify the situation. charts reinforces the skills required for the external standards Sylvia Dixon and gives students confidence in using the language. [email protected] It is up to you how you use what is here. You can print pages off as they are, or use the format idea and the templates to create your own pages. More information: You will find pages on: If you find this useful, you might be interested in the full • the Blaue Reiter workbook. -

13 19 21 23 31 37 45 51 63 69 75 Indice Prima Che S'apra Il Sipario Rincorrendo Ricordi Con Educata, Civile Insistenza Giorgio A
Indice LE VOCI DEL TEATRO 13 Prima che s'apra il sipario 19 Rincorrendo ricordi 21 Con educata, civile insistenza 23 Giorgio Albertazzi Shakespeare, Riccardo III - 1983 31 Edda Albertini Goldoni, II Campiello - 1984 37 Adriana Asti Goldoni, La Vedova scaltra - 1983 45 Marcello Bartoli Angelo Beolco detto Ruzante, La Piovana - 1987 51 Carmelo Bene Hamlet Suite - 1994 63 Paola Borboni Premio Renato Simoni 1968 69 Giulio Bosetti Goldoni, La bottega del caffè - 1989 75 Franco Branciaroli Shakespeare, Riccardo III - 1997 81 Peter Brook Shakespeare, La Tempète - 1991 7 89 Tino Buazzelli Shakespeare, Le allegre comari di Windsor - 1976 95 Ernesto Calindri Premio Renato Simoni 1991 101 Fiorenzo Carpi Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni - 1973 105 Tino Carraro Premio Renato Simoni 1973 111 Pina Cei Shakespeare, I due gentiluomini di Verona - 1989 117 Giancarlo Cobelli Shakespeare, Antonio e Cleopatra - 1988 125 Orazio Costa Giovangigli Premio Renato Simoni 1976 129 Maddalena Crippa Shakespeare, Otello - 1985 137 Gianfranco De Bosio Carlo Goldoni, La bottega del caffè - 1989 143 Luca De Filippo Premio Renato Simoni 2014 149 Donatello Falchi Goldoni, La cameriera brillante - 2002 155 Rossella Falk Premio Renato Simoni 2008 163 Sergio Fantoni Shakesperare, La Tempesta - 1975 169 Sarah Ferrati Premio Renato Simoni 1970 175 Dario Fo Premio Renato Simoni 1990 183 Pietro Garinei Premio Renato Simoni 2003 189 Vittorio Gassman Shakespeare, Macbeth - 1983 199 Carlo Giuffré Premio Renato Simoni 1999 207 Carla Gravina Shakespeare, La bisbetica domata -

JUDITH MERRIL-PDF-Sep23-07.Pdf (368.7Kb)
JUDITH MERRIL: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY AND GUIDE Compiled by Elizabeth Cummins Department of English and Technical Communication University of Missouri-Rolla Rolla, MO 65409-0560 College Station, TX The Center for the Bibliography of Science Fiction and Fantasy December 2006 Table of Contents Preface Judith Merril Chronology A. Books B. Short Fiction C. Nonfiction D. Poetry E. Other Media F. Editorial Credits G. Secondary Sources About Elizabeth Cummins PREFACE Scope and Purpose This Judith Merril bibliography includes both primary and secondary works, arranged in categories that are suitable for her career and that are, generally, common to the other bibliographies in the Center for Bibliographic Studies in Science Fiction. Works by Merril include a variety of types and modes—pieces she wrote at Morris High School in the Bronx, newsletters and fanzines she edited; sports, westerns, and detective fiction and non-fiction published in pulp magazines up to 1950; science fiction stories, novellas, and novels; book reviews; critical essays; edited anthologies; and both audio and video recordings of her fiction and non-fiction. Works about Merill cover over six decades, beginning shortly after her first science fiction story appeared (1948) and continuing after her death (1997), and in several modes— biography, news, critical commentary, tribute, visual and audio records. This new online bibliography updates and expands the primary bibliography I published in 2001 (Elizabeth Cummins, “Bibliography of Works by Judith Merril,” Extrapolation, vol. 42, 2001). It also adds a secondary bibliography. However, the reasons for producing a research- based Merril bibliography have been the same for both publications. Published bibliographies of Merril’s work have been incomplete and often inaccurate. -

Pdf Ennio Flaiano Y Rafael Azcona: Historia De Un Universo Compartido / Giovanna Zanella Leer Obra
Università degli Studi di Udine Ennio Flaiano y Rafael Azcona Historia de un universo compartido Giovanna Zanella Memoria de Licenciatura Facultad: Lengua y Literatura extranjera Directora: Dott. Renata Londero 2000-2001 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Tesi di Laurea ENNIO FLAIANO Y RAFAEL AZCONA HISTORIA DE UN UNIVERSO COMPARTIDO Relatore: Laureanda: Dott. Renata Londero Giovanna Zanella ANNO ACCADEMICO 2000-2001 AGRADECIMIENTOS Durante la realización del presente trabajo he estado principalmente en la Universidad de Alicante, donde he podido contar en todo momento con la valiosa colaboración y los imprescindibles consejos de Juan Antonio Ríos, y con la disponibilidad de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que precisamente este año ha abierto un portal de autor dedicado a Rafael Azcona (consultable en cervantesvirtual.com), cuyo material ha sido fundamental para mi estudio. Asimismo, por lo que concierne el material sobre Ennio Flaiano, he utilizado las numerosas publicaciones de la “Associazione Culturale Ennio Flaiano” de Pescara, cuyos volúmenes siempre han sido el apoyo más valioso en toda investigación sobre la figura y la obra del italiano. Por lo que respecta a la difícil labor de conseguir películas de los años 50, 60 y 70, tengo que agradecer a Cristina Ros de la Universidad de Alicante por haberme ofrecido la oportunidad de ver El Anacoreta, de Juan Esterlich; a la “Cineteca del Friuli”, que me ha facilitado la visión de La cagna de Marco Ferreri; al “Laboratorio Cinema e Multimedia” de la Universidad de Udine y a la “Filmoteca del Museo” de la Universidad de Alicante. -

1 April 2012 DEAD by DAWN 29 March - 1 April 2012 All Screenings in Cinema One
29 March - 1 April 2012 DEAD BY DAWN 29 March - 1 April 2012 All screenings in Cinema One Thursday THE FIELDS 2330 – 0115 Friday RED TEARS 1200 – 1335 What You Make It short film programme 1415 – 1515 THE OMEN 1600 – 1800 Long Shorts short film programme 1900 – 2035 BELOW ZERO + Q&A with Signe Olynyk and Bob Schultz 2115 – 2315 THE PUPPET MONSTER MASSACRE 0015 – 0130 Saturday DELIVERANCE 1245 – 1445 Cutting Edge short film programme 1530 – 1715 NIGHTMARE FACTORY 1815 – 1950 LOBOS DE ARGA + Q&A with Juan Martinez Moreno 2045 – 2250 Late Night Triple Bill Bear + JUAN DE LOS MUERTOS 0000 – 0155 Infernal Nuns + DEMONS 0230 – 0405 MACABRE 0425 – 0600 Sunday CREEPSHOW 1345 – 1550 2D & Deranged short animation programme 1630 – 1740 RED NIGHTS 1830 – 2015 HAUNTERS 2100 – 2245 Freebies, Blethering, Shit Film Amnesty 2330 – 2350 THE CABIN IN THE WOODS 2350 – 0140 Some times may be subject to slight change. Welcome to Dead by Dawn! It’s sound advice to be more afraid of the living than the dead. Sure, the dead can kill you, but at least they’re easy to spot. In this year’s programme too many of the monsters will smile when they meet you, and will still be smiling when they lock you in a meat freezer. Or encourage you onto a ledge. Or offer to share their martini. You could try politely declining their kind offer, see how that works out... Dead by Dawn is a discovery festival which exists to showcase potential and vibrant emerging talent, but also aims to screen the widest possible range of what can be described as horror both in feature and short form. -

Neri Parenti
Luigi e Aurelio De Laurentiis presentano regia di NERI PARENTI prodotto da AURELIO DE LAURENTIIS & LUIGI DE LAURENTIIS Distribuzione www.filmauro.it www.amicimieicometuttoebbeinizio.it AMICI MIEI come tutto ebbe inizio PERSONAGGI E INTERPRETI (in ordine di apparizione) Duccio Villani di Maso Michele Placido Cecco Alemari Giorgio Panariello Margarita Barbara Enrichi Jacopo Paolo Hendel Manfredo Alemanni Massimo Ghini Piccarda Pamela Villoresi Madonna Isabetta Alessandra Acciai Filippo Christian De Sica Alderighi Massimo Ceccherini Tessa Chiara Francini Lorenzo il Magnifico Alessandro Benvenuti Messer Adunchi Eros Pagni CAST TECNICO Regia Neri Parenti Soggetto Piero De Bernardi, Leo Benvenuti, Tullio Pinelli, Neri Parenti Sceneggiatura Piero De Bernardi, Neri Parenti, Fausto Brizzi, Marco Martani Fotografia Luciano Tovoli Scenografia Francesco Frigeri Costumista Alfonsina Lettieri Make Up & Hair Vincenzo Mastrantonio e Ferdinando Merolla Montaggio Luca Montanari Musiche Andrea Guerra Produttore esecutivo Maurizio Amati Prodotto da Aurelio De Laurentiis & Luigi De Laurentiis Distribuzione FILMAURO Durata 108’ Uscita 16 marzo 2011 Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Filmauro Ufficio Stampa Rosa Esposito Giulia Martinez Tel. 06.69958442 Cell. 335.7189949 e-mail [email protected] e-mail [email protected] 2 AMICI MIEI come tutto ebbe inizio SINOSSI Continua la saga di “Amici Miei”, ma le avventure della compagnia di “toscanacci” si spostano questa volta nella Firenze di fine ’400, alla corte di Lorenzo De’ Medici. Duccio (MICHELE PLACIDO), Cecco (GIORGIO PANARIELLO), Jacopo (PAOLO HENDEL), Manfredo (MASSIMO GHINI) e Filippo (CHRISTIAN DE SICA) sono protagonisti di scherzi e vicende vissute nell’intento di prolungare lo stato felice della giovinezza e fuggire dalle responsabilità della vita adulta. Neanche la peste li fa desistere dalle loro “zingarate”. -

Festa Del Cinema Di Roma FESTA DEL CINEMA DI ROMA 13/23 OTTOBRE 2016
11A Festa del Cinema di Roma FESTA DEL CINEMA DI ROMA 13/23 OTTOBRE 2016 FONDATORI PRESIDENTE Roma Capitale Piera Detassis Regione Lazio Città Metropolitana di Roma Capitale Camera di Commercio di Roma DIRETTORE GENERALE Fondazione Musica per Roma Francesca Via Istituto Luce Cinecittà S.r.l DIRETTORE ARTISTICO COLLEGIO DEI FONDATORI Antonio Monda Presidente Lorenzo Tagliavanti Presidente della Camera di Commercio di Roma COMITATO DI SELEZIONE Virginia Raggi Mario Sesti, Coordinatore Sindaca di Roma Capitale Valerio Carocci e della Città Metropolitana Alberto Crespi Giovanna Fulvi Nicola Zingaretti Richard Peña Presidente della Regione Lazio Francesco Zippel Aurelio Regina Presidente della Fondazione Musica per Roma Roberto Cicutto Presidente dell’Istituto Luce Cinecittà CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE UFFICIO CINEMA Piera Detassis, Presidente Alessandra Fontemaggi Laura Delli Colli Lorenzo Tagliavanti José Ramón Dosal Noriega Roberto Cicutto COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Roberto Mengoni, Presidente Massimo Gentile, Revisore Effettivo Giovanni Sapia, Revisore Effettivo Maurizio Branco, Revisore Supplente Marco Buttarelli, Revisore Supplente A FESTA 13-23 DEL CINEMA OTTOBRE 11 DI ROMA 2016 Prodotto da Main Partner Promosso da Partner Istituzionali Con il supporto di In collaborazione con Official sponsor Partner Tecnico Eco Mobility Partner Sponsor di Servizi Media Partner Partner Culturali Sponsor2.1 Invicta institutional logo “Since” 2.1.1 Dimensions, proportions and colour references The Invicta corporate logo is made up of 2 colours, blue and red. The Invicta corporate logo must never be modified or reconstructed. FOOD PROMOTION & EVENTS MANAGEMENT 26x 8x 87x 1x 15x 31x 2x 3x 5x 3x 1x Pantone 33xCMYK Pantone RGB 2x Textile 20x Invicta red C: 0 4852x C P. -

RICCARDO FREDA, UN MAESTRO DI CINEMA POPOLARE Riccardo Freda, Master of Popular Cinema
RICCARDO FREDA, UN MAESTRO DI CINEMA POPOLARE Riccardo Freda, Master of Popular Cinema Programma e note a cura di / Programme and notes curated by Emiliano Morreale 244 La grande stagione di Riccardo Freda comincia nell’imme- Riccardo Freda’s great period began immediately after the war diato dopoguerra, con i film d’avventura girati per la Lux di with the adventure films he made for Riccardo Gualino’s Lux Riccardo Gualino, e termina negli anni Sessanta inoltrati, and ended in the 1960s with Lo spettro. During that time the diciamo con Lo spettro. Anni in cui il regista si muove tra director worked on high-end productions and second-rate ones produzioni più ricche e altre di serie B, ma sempre secondo but always according to his creed of energy and speed. Film is un suo credo di energia e velocità. Il cinema è un’arte che si an art to be done in a hurry, as the director often said: “When fa in fretta: “Quando la lavorazione di un film dura troppo the production of a film takes too long, enthusiasm drags, and si perde d’entusiasmo, e il ritmo del film ne risente. L’ideale the film’s rhythm is affected by it. Ideally, you put a reel in the sarebbe di mettere la bobina nella macchina da presa, dare il camera, call action and never stop”. via all’azione, e non fermarsi più”. Averse to the quintessential Italian film genre, comedy, and a Lontano dal genere fondamentale del cinema italiano, sworn enemy of Neorealism, Freda always presented himself as la commedia, nemico giurato del neorealismo, Freda si è an ‘American-style’ director, a master of action movies, a creator sempre presentato come regista ‘all’americana’, maestro del of grand melodramas and even a pioneer of Italian horror film. -

Auch Die Körper Von Jago Und Othello. Eine Lange Fahrt Mit Subjektiver
Auch die Körper von Jago und Othello. angeht, die 'Sittenkomödie' mit ihrer opportunistischen Korrum- Eine lange Fahrt mit subjektiver Kamera, die Erde, Himmel und piertheit, auch wenn diese zum Schein hinter Denunziationspro Müllhalde schwindelerregend sich drehen läßt, aus der Sicht der blemen verborgen ist. beiden Körper, die schreiend vor Entsetzen hinunterrollem Bis Diese Unterscheidung und diese Bevorzugung decken sich mit un das Objektiv, unbewegt, nach oben gerichtet ist, gegen den un serer eigenen Beurteilung. Das Totb-Revival ist also nicht nur An endlichen blauen Himmel, über den weiße Wolken eilen. laß zur Freude. Aber gerade deshalb ist es notwendig, den Punkt In dem aufgeplatzten, geschwollenen Gesicht Othellos leuchten auf das i zu setzen, bevor man uneingeschränkte Genugtuung die Augen vor brennender Neugier und nicht unterdrückbarer äußert oder die neue Vorliebe gänzlich und ausschließlich positiv Freude. interpretiert. Tatsächlich geht die subproletarische Komik oft und Auch Jagos Augen betrachten höchst verblüfft oder in Ekstase gern in die unpolitische Haltung des kleinen Mannes über und hat wesentliche Beiührungspunkte mit der kleinbürgerlichen Komik. dieses nie gesehene Schauspiel von Himmel und Welt. Da es ihr an einer genau bestimmten Verwurzelung in einer Klasse Othello: Was ist denn das? und an expliziten Widersprüchen mangelt, ist die Ideologie, die sie Jago: Das sind ... das sind ... die Wolken ... zum Ausdruck bringt, die Frucht einer verzweifelten Lebensangst, Othello: Und was sind Wolken? die im täglichen -

Westerns…All'italiana
Issue #70 Featuring: TURN I’ll KILL YOU, THE FAR SIDE OF JERICHO, Spaghetti Western Poster Art, Spaghetti Western Film Locations in the U.S.A., Tim Lucas interview, DVD reviews WAI! #70 The Swingin’ Doors Welcome to another on-line edition of Westerns…All’Italiana! kicking off 2008. Several things are happening for the fanzine. We have found a host or I should say two hosts for the zine. Jamie Edwards and his Drive-In Connection are hosting the zine for most of our U.S. readers (www.thedriveinconnection.com) and Sebastian Haselbeck is hosting it at his Spaghetti Westerns Database for the European readers (www.spaghetti- western.net). Our own Kim August is working on a new website (here’s her current blog site http://gunsmudblood.blogspot.com/ ) that will archive all editions of the zine starting with issue #1. This of course will take quite a while to complete with Kim still in college. Thankfully she’s very young as she’ll be working on this project until her retirement 60 years from now. Anyway you can visit these sites and read or download your copy of the fanzine whenever you feel the urge. Several new DVD and CD releases have been issued since the last edition of WAI! and co-editor Lee Broughton has covered the DVDs as always. The CDs will be featured on the last page of each issue so you will be made aware of what is available. We have completed several interviews of interest in recent months. One with author Tim Lucas, who has just recently released his huge volume on Mario Bava, appears in this issue. -

Fangoria 345(2015)
IT'S ALIVE—AND IT'S ANGRY! CANADA U.S.& $11.99 Hus: JERUZALEM • Larry Fessenden • Fabio Frizzi • Clu Gulager www.fangoria.com Wrestling HoiTor • THE HALLOW • CONDEMNED • Much more! NOW IN THEATERS f- & ON DEMAND CONTRACTED itHORROR PHASE 2 IN THEATERS & [ NOW ON DEMAND I DEMANOffc’^ . I 11/20 LEARN BY DOING. sFACTORY Digital Filmmaking Program at Douglas DOUGLASEducation Center 1 30 Seventh Street • Monessen, PA 1 5062 Financial aid is available to those who qualify. For more information about graduation rates, median debt of students who completed the program, and consumer information, please visit www.dec.edu/df Housing is available through Boss Development, Inc. DEC.EDU 1.800.413.6013 THIS SCHOOL IS AUTHORIZED UNDER FEDERAL LAWTO ENROLL NONIMMIGRANT ALIEN STUDENTS. 1 6 PREVIEW: “KRAMPUS” The “anti-Claus” gets the major movie vehicle he’s long deserved, thanks to 54 ON SET: “THE HALLOW” Irish forest dwellers are director Michael Dougherty. no longer confined to legend in Corin Hardy’s mythological chiller. 20 PREVIEW: “JERUZALEM” Israeli filmmaking brothers Doron and Yoev Paz spread unholy evil 58 DN SET: “CHARLIE’S FARM” Do you dare join us across sacred ground. to trespass on the grounds of Chris Sun’s huge, savage psychopath? 22 ONSET: “CONDEMNED” 64 INTERVIEW: CLU GULAGER From “Return of the In Eli Morgan Living Dead” to “Feast,” something’s always been Gesner’s infection eating at the veteran actor. opus, catching the murderous rage 68 FEATURE: “MEXICD BARBARD” Director/producer doesn’t mean Lex Drtega et al. are seeing their ambitious anthology you lose your head north of the border.