IRPPS Working Paper Series
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Solano Et Al. Laborest 18 2019 Layout 1
Local Development: Urban Space, Rural Space, Inner Areas Sviluppo Locale: Spazio Urbano, Spazio Rurale, Aree Interne GIS and Remote Sensing Techniques for the Assessment of Biomass Resources for energy Uses in Rome Metropolitan Area ANALISI GEOSPAZIALI PER LA VALUTAZIONE DELLA BIOMASSA ALL’INTERNO DI UN AREA PROTETTA NEL CONTESTO DELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA* Francesco Solanoa, Nicola Colonnab, Massimiliano Maranib, Maurizio Pollinob aDipartimento di AGRARIA, Università Mediterranea, Via dell'Università 25, 89124 - Reggio Calabria, Italia bENEA, Centro Ricerche Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 - Roma, Italia [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Abstract The Metropolitan city of Roma Capitale (Italy) represents a vast area, including many municipalities with the purpose to strength the promotion and coordination of economic and social development. Natural Parks included in the Metropolitan area are able to provide ecosystem services and resources such as agricultural and forest products as well as biomass resources that could be an opportunity to replace fossil fuels, make the city more climate friendly and, at the same time, to relaunch the sustainable management of forest that are often abandoned and prone to degradation risk. The goal of this paper is to investigate and update the actual distribution of the main forest types of the Bracciano-Martignano Regional Natural Park, through GIS and Remote Sensing techniques, in order to assess the biomass potential present in the forest areas. Results showed that there are about 20,000 t of woody biomass per year available and confirmed the importance of Sentinel-2 satellite data for vegetation applications, reaching a high overall accuracy. -
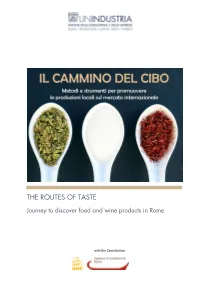
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization. -

A Large Ongoing Outbreak of Hepatitis a Predominantly Affecting Young Males in Lazio, Italy; August 2016 - March 2017
RESEARCH ARTICLE A large ongoing outbreak of hepatitis A predominantly affecting young males in Lazio, Italy; August 2016 - March 2017 Simone Lanini1☯, Claudia Minosse1☯, Francesco Vairo1, Annarosa Garbuglia1, Virginia Di Bari1, Alessandro Agresta1, Giovanni Rezza2, Vincenzo Puro1, Alessio Pendenza3, Maria Rosaria Loffredo4, Paola Scognamiglio1, Alimuddin Zumla5, Vincenzo Panella6, Giuseppe Ippolito1*, Maria Rosaria Capobianchi1, Gruppo Laziale Sorveglianza Epatiti Virali (GLaSEV)¶ a1111111111 a1111111111 1 Dipartimento di Epidemiologia Ricerca Pre-Clinica e Diagnostica Avanzata, National Institute for Infectious diseases Lazzaro Spallanzani, Rome, Italy, 2 Department of Infectious Diseases, Istituto Superiore di Sanità, a1111111111 Rome, Italy, 3 Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Dipartimento di PrevenzioneÐU.O.S. Controllo Malattie e a1111111111 Gestione Flussi Informativi, Rome, Italy, 4 Azienda Sanitaria Locale Roma 3 Servizio di Igiene e Sanità a1111111111 Pubblica Profilassi delle malattie infettive e parassitarie, Rome, Italy, 5 Division of Infection and Immunity, University College London and NIHR Biomedical Research Centre, UCL Hospitals NHS Foundation Trust, London, United Kingdom, 6 Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Regione Lazio, Rome, Italy ☯ These authors contributed equally to this work. ¶ Membership of Gruppo Laziale Sorveglianza Epatiti Virali (GLaSEV) is provided in the Acknowledgments. OPEN ACCESS * [email protected] Citation: Lanini S, Minosse C, Vairo F, Garbuglia A, Di Bari V, Agresta A, et al. -

Measuring Urban Subsidence in the Rome Metropolitan Area (Italy) with Sentinel-1 SNAP-Stamps Persistent Scatterer Interferometry
remote sensing Article Measuring Urban Subsidence in the Rome Metropolitan Area (Italy) with Sentinel-1 SNAP-StaMPS Persistent Scatterer Interferometry José Manuel Delgado Blasco 1,*, Michael Foumelis 2, Chris Stewart 3 and Andrew Hooper 4 1 Grupo de Investigación Microgeodesia Jaén (PAIDI RNM-282), Universidad de Jaén, 23071 Jaén, Spain 2 BRGM–French Geological Survey, 45060 Orleans, France; [email protected] 3 Future Systems Department, Earth Observation Programmes, European Space Agency (ESA), 00044 Frascati, Italy; [email protected] 4 Institute of Geophysics and Tectonics, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 30 November 2018; Accepted: 8 January 2019; Published: 11 January 2019 Abstract: Land subsidence in urban environments is an increasingly prominent aspect in the monitoring and maintenance of urban infrastructures. In this study we update the subsidence information over Rome and its surroundings (already the subject of past research with other sensors) for the first time using Copernicus Sentinel-1 data and open source tools. With this aim, we have developed a fully automatic processing chain for land deformation monitoring using the European Space Agency (ESA) SentiNel Application Platform (SNAP) and Stanford Method for Persistent Scatterers (StaMPS). We have applied this automatic processing chain to more than 160 Sentinel-1A images over ascending and descending orbits to depict primarily the Line-Of-Sight ground deformation rates. Results of both geometries were then combined to compute the actual vertical motion component, which resulted in more than 2 million point targets, over their common area. Deformation measurements are in agreement with past studies over the city of Rome, identifying main subsidence areas in: (i) Fiumicino; (ii) along the Tiber River; (iii) Ostia and coastal area; (iv) Ostiense quarter; and (v) Tivoli area. -

Roma in Transizione
R O M A I N TRANSIZIONE G o v e r n o , s t r a t e g i e , m e t a b o l i s m i e q u a d r i d i v i t a di una metropoli a cura di Alessandro Coppola Gabriella Punziano PLANUM PUBLISHER | www.planum.net Roma-Milano ISBN 9788899237110 Volume pubblicato digitalmente nel mese di novembre 2018 Pubblicazione disponibile su www.planum.net | Planum Publisher R O M A I N TRANSIZIONE G o v e r n o , s t r a t e g i e , m e t a b o l i s m i e q u a d r i d i v i t a di una metropoli a cura di Alessandro Coppola Gabriella Punziano VOLUME 1 PLANUM PUBLISHER | www.planum.net A Sandra Annunziata, che aveva fatto di Roma la sua città. E che a Roma aveva studiato e lottato per città più giuste e dignitose. Continueremo, ancor più di prima, ad avere bisogno di tutto il tuo entusiasmo. Roma in Transizione. Governo, strategie, metabolismi e quadri di vita di una metropoli A cura di Alessandro Coppola e Gabriella Punziano Seconda edizione riveduta e corretta febbraio 2019 Prima edizione novembre 2018 Pubblicazione disponibile su www.planum.net, Planum Publisher Foto di copertina: © Francesca Cozzi ISBN 9788899237134 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic mechanical, photocopying, recording or other wise, without the prior written permission of the Publisher. -

Urban Shrinkage, Land Consumption and Regional Planning in a Mediterranean Metropolitan Area
Sustainability 2015, 7, 11980-11997; doi:10.3390/su70911980 OPEN ACCESS sustainability ISSN 2071-1050 www.mdpi.com/journal/sustainability Case Report Desperately Seeking Sustainability: Urban Shrinkage, Land Consumption and Regional Planning in a Mediterranean Metropolitan Area Luca Salvati 1, Agostino Ferrara 2, Ilaria Tombolini 1,*, Roberta Gemmiti 3, Andrea Colantoni 4, and Luigi Perini 5 1 Italian Council of Agricultural Research and Economics (CREA), Via della Navicella 2, I-00184 Rome, Italy; E-Mail: [email protected] 2 School of Agricultural, Forest, Food and Environmental Sciences, University of Basilicata, Via dell'Ateneo Lucano 10, I-85100 Potenza, Italy; E-Mail: [email protected] 3 Department of Methods and Models for Territory, Economy and Finance, Sapienza University of Rome, Via del Castro Laurenziano 9, I-00161 Rome, Italy; E-Mail: [email protected] 4 Department of Agriculture, Forest, Nature and Energy (DAFNE), University of Tuscia, Via S. Camillo de Lellis snc Viterbo, Italy; E-Mail: [email protected] 5 Italian Council of Agricultural Research and Economics (CREA), Via del Caravita 7a, I-00186 Rome, Italy; E-Mail: [email protected] * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +39-06-700-5413; Fax: +39-06-700-5711. Academic Editor: Marc A. Rosen Received: 5 July 2015 / Accepted: 20 August 2015 / Published: 28 August 2015 Abstract: Land degradation has expanded in the Mediterranean region as a result of a variety of factors, including economic and population growth, land-use changes and climate variations. The level of land vulnerability to degradation and its growth over time are distributed heterogeneously over space, concentrating on landscapes exposed to high human pressure. -

From Global to Local : Human Mobility in the Rome Coastal Area in The
Belgeo Revue belge de géographie 3-4 | 2011 Human mobility and housing market during a period of global recession • Miscellaneous From global to local : Human mobility in the Rome coastal area in the context of the global economic crisis* Du global au local : la mobilité humaine dans la zone côtière de Rome sur fond de crise économique mondiale Armando Montanari and Barbara Staniscia Electronic version URL: http://journals.openedition.org/belgeo/6300 DOI: 10.4000/belgeo.6300 ISSN: 2294-9135 Publisher: National Committee of Geography of Belgium, Société Royale Belge de Géographie Printed version Date of publication: 31 December 2011 Number of pages: 187-200 ISSN: 1377-2368 Electronic reference Armando Montanari and Barbara Staniscia, « From global to local : Human mobility in the Rome coastal area in the context of the global economic crisis* », Belgeo [Online], 3-4 | 2011, Online since 15 December 2012, connection on 01 May 2019. URL : http://journals.openedition.org/belgeo/6300 ; DOI : 10.4000/belgeo.6300 This text was automatically generated on 1 May 2019. Belgeo est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International. From global to local : Human mobility in the Rome coastal area in the context... 1 From global to local : Human mobility in the Rome coastal area in the context of the global economic crisis* Du global au local : la mobilité humaine dans la zone côtière de Rome sur fond de crise économique mondiale Armando Montanari and Barbara Staniscia Introduction 1 Two apparently unrelated phenomena – human mobility and the economic crisis – began to overlap in certain areas of the world towards the end of the first decade of the third millennium. -

RESEARCH ARTICLE Blending Adaptive Governance and Institutional Theory to Explore Urban Resilience and Sustainability Strategies
RESEARCH ARTICLE Blending adaptive governance and institutional theory to explore urban resilience and sustainability strategies in the Rome Metropolitan Area, Italy Paula Vandergert*1a, Marcus Collierb, Stephan Kampelmannc and Darryl Newportd a Sustainability Research Institute, University of East London, London, UK b School of Geography, Planning and Environmental Policy, University College Dublin, Dublin, Ireland c SBS-EM (DULBEA, CEB), Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium d Sustainability Research Institute, University of East London, London, UK Acknowledgements The authors acknowledge the financial support by the European Union FP7-ENV.2011.2.1.5-1 (TURAS Project) Grant Agreement no. 282834. The authors would also like to acknowledge the assistance of the following people in the preparation of this paper, Mariella Iunessi, Luca Polizzano, Ilaria Corsi, Massimo Felicetti, Patrick van den Abeele, Jo Sinclair. Abstract Adaptive governance is an emerging theory in natural resource management. This paper addresses a gap in the literature by exploring the potential of adaptive governance for delivering resilience and sustainability in the urban context. We explore emerging challenges to transitioning to urban resilience and sustainability: bringing together multiple scales and institutions; facilitating a social-ecological- systems approach and; embedding social and environmental equity into visions of urban sustainability and resilience. Current approaches to adaptive governance could be helpful for addressing these first two challenges but not in addressing the third. Therefore, this paper proposes strengthening the institutional foundations of adaptive governance by engaging with institutional theory. We explore this through empirical 1 Corresponding author. Email: [email protected] research in the Rome Metropolitan Area, Italy. -

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2011/0301835 A1 Bongiorno (43) Pub
US 2011 03 01835A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2011/0301835 A1 Bongiorno (43) Pub. Date: Dec. 8, 2011 (54) PORTABLE VACATION/TRAVEL PLANNER, (52) U.S. Cl. ....... 701/201: 705/5: 707/705; 707/E17.044 AND FAMILY TOUR GUIDE DEVICE (57) ABSTRACT (76) Inventor: James Bongiorno, Huntington, NY A portable device for planning a vacation/business travel (US) itinerary, which begins with customizable itinerary templates that utilize a stored database of destination information, including a country's regions/cities, tourist sites, and other (21) Appl. No.: 12/910,790 sites of interest located therein, and a corresponding photo graphic library. One Such template returns itineraries based (22) Filed: Oct. 23, 2010 upon: duration, arrival/departure cities, total number of cities to be visited, and intensity of touring. The Software assists users during travel by providing cueing of itinerary segments, Rel ated U.S. Application Data along with directions, and on-demand pre-recorded audio (60) Provisional application No. 61/397,104, filed on Jun. tours to enhance site tour experiences. En route detours from 7, 2010. planned sites are Supported for spontaneous additions/Substi tutions. Country-specific information includes city/regional maps, public transportation information, key word/phrase Publication Classification language translation capability, and yellow/white page phone listings. Password protected device-to-device linking permits (51) Int. C. family members to track each other by GPS location of the G06O 10/00 (2006.01) other's device. Internet capability permits inclusion, within G06F 7/30 (2006.01) itineraries, of reservation-specific information for air-travel, GOIC 2L/00 (2006.01) hotels, and events. -

Prati Della Vittoria
IS PRATI VOGUE? An Evaluation of Prati’s Suitability for Vogue Nikita Barai • Claire Fabian • Adeline Kooi • Laura Tarbox • Ryan Weggler Mr. Charles Churchward International Design Director Vogue Magazine International 810 Seventh Avenue New York City, New York 10019 Dear Mr. Churchward, Thank you for choosing POSH International Consultants to evaluate the advantages and disadvantages of locating Vogue’s European Design and Layout headquarters in the Roman neighborhood of Prati. Since being invited to explore this exciting project in January of 2005, our consultants have thoroughly considered the impact of Vogue’s location into Prati on both the company and the neighborhood. We are pleased to inform you that our research and analysis is now complete. Enclosed is our final evaluation of Vogue’s location into Prati for your consideration. In addition to the final report, we have included each of our previous reports on policy issues, economic development, transportation, and quality of life as technical appendices for your reference. We are confident that this report will guide Vogue towards an informed business location decision. We have truly enjoyed working on this project and look forward to working with you and other members of the Vogue team in the future. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact our team. Sincerely, Ryan Weggler Executive Director POSH International Consultants IS PRATI VOGUE? AN EVALUATION OF PRATI’S SUITABILITY FOR VOGUE EXECUTIVE SUMMARY MAY 2, 2005 In January of 2005, Vouge International commissioned a study to evaluate the advantages and potential disadvantages of locating Vogue’s European Design and Layout headquarters in the Roman neighborhood of Prati. -

Green Bond Report 2020
2020 GREEN BOND REPORT GREEN BOND REPORT 2020 Green Bond Report 2020 Since 2018, Terna issued four green bonds as part of its €9,000,000,000 Euro Medium Term Notes (EMTN) programme: • on 16 July 2018, Terna successfully launched its first green bond issue, worth €750 million and having a 5-year term; • on 10 January 2019, the Company launched a fixed-rate green bond issue in the form of a private placement, amounting to €250 million, having reopened the bond issue announced to the market on 16 July 2018; • on 3 April 2019, the Company launched an issue of euro-denominated green bonds with a total nominal value of €500 million and a 7-year term; • on 17 July 2020, Terna successfully placed a new green bond amounting to €500 million and having a 12-year term. The net proceeds from the issues are being used to fund the Company’s Eligible Green Projects, selected on the basis of the “Green Bond Principles 2018” published by the ICMA – International Capital Market Association. At 31 December 2020, Terna drew up and published two Green Bond Frameworks in order to enhance the transparency and the quality of the green bonds issued. The first was adopted on 16 July 2018, whilst the second was published on 15 July 2020. These Frameworks and the second party opinions provided by the independent advisor, Vigeo Eiris, are available to the public on the Company’s website (www.terna.it). In this regard, it should be noted that the first three bond issues are covered by the Green Bond Framework drawn up in 2018, whilst the bonds dated 17 July 2020 were issued in accordance with the new Green Bond Framework, updated in July 2020. -

Simulation of Urban Development in the City of Rome Framework, Methodology, and Problem Solving
http://jtlu.org . 3 . 2 [Summer 2010] pp. 85–105 doi: 10.5198/jtlu.v3i2.154 Simulation of urban development in the City of Rome Framework, methodology, and problem solving Simone Di Zio Armando Montanari Chieti-Pescara G. d’Annunzio University a Rome Sapienza University b Barbara Staniscia Rome Sapienza University c Abstract: In Italy’s case, the implementation of the UrbanSIM model involved the territory of Rome, including the municipalities of Rome and Fiumicino. e main goal was to build scenarios regarding the future of economic deconcentration. Rome is the largest municipality in Europe, with an inhabited surface area only slightly smaller than that of Greater London and almost double that of the inner Paris suburbs (the Petite Couronne). e spatial distribution of buildings within the municipality is distinctive. Unbuilt areas comprise 73 percent of the territory. ese voids are oen farmland (paradoxically, Rome is the largest rural municipality in Italy) or areas with high environmental, historic or cultural value. Fiumicino, previously part of the municipality of Rome, became an independent municipality in 1991. Its autonomy, made all the more signicant because Fiumicino hosts the international airport, marked the start of an extensive process of economic deconcentration along the route connecting Rome to the airport. In Italy’s case, the implementation of the UrbanSIM model posed several challenges, notably the availability, homogeneity and completeness of data. is paper uses four specic cases (land use, travel times, accessibility, and residential land values) to propose a general methodology to solve problems related to missing or non-homogeneous data. For the land use, we simply combine two different land use data sources, while for accessibility and travel time data, we propose the use of geostatistical methods in order to estimate missing and unavailable data, calculating also the accuracy of the predictions.