Torrente Impero
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Episodio Di Frazione Conio, Borgomaro, 29.12.1944 I.STORIA
Episodio di Frazione Conio, Borgomaro, 29.12.1944 Nome del Compilatore: Sabina Giribaldi I.STORIA Località Comune Provincia Regione Frazione Conio Borgomaro Imperia Liguria Data iniziale: 29.12.1944 Data finale: 29.12.1944 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ign bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 5 5 1 4 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 4 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito 1 Elenco delle vittime decedute Bertagnoni Giacomo (nome di battaglia “Ele”), partigiano (non riconosciuto), trucidato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Bonavico Raffaele (nome di battaglia “Orso”), partigiano (non riconosciuto), infermiere del 6° distaccamento, 2° battaglione, IV Brigata, II Div. “F. Cascione”, fucilato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Gerini Armando (nome di battaglia “Armando”), fu Pietro, nato a Potendassio il 25.05.1916, anni 38, contadino, partigiano II Divisione Iv Brigata dal 17.06.1944 al 29.12.1944, n. dichiaraz. Integrativa 3248, fucilato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Scipione Vincenzo (nome di battaglia “Africano”) partigiano (non riconosciuto), infermiere del 6° distaccamento, 2° battaglione, IV Brigata, II Div. “F. Cascione”, fucilato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Giovane di Badalucco ? senza identità, fucilato lungo la strada a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 (come riportato nel vol. III della “Storia della Resistenza Imperiese” di F. -

Allegato 5 : Elenco Scarichi Da Pubbliche Fognature E Produttivi (2002)
Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia – ALLEGATO N. 5 ALLEGATO 5 : ELENCO SCARICHI DA PUBBLICHE FOGNATURE E PRODUTTIVI (2002) 843 Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia – ALLEGATO N. 5 N° ID classe scarico (tipo di COMUNE Denominazione scarico - Località Corpo ricettore bacino idrografico sulla carta depuratore) AIROLE Fognatura Com.le Airole 6 F. Roja Roja 8 AIROLE Fognatura Com.le Collabassa 7 T. Bevera Roja 7 AIROLE Scarico centrale ENEL -Ponte Giauma (Airole) 8 F. Roja Roja AIROLE Scarico centrale ENEL -Ponte Giauma (Airole) 9 F. Roja Roja AIROLE Scarico centrale ENEL -Ponte Giauma (Airole) 10 F. Roja Roja APRICALE Fognatura Com.le Apricale 38 Rio Merdanzo Nervia 8 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Aquila d'Arroscia 264 Rio Galli Arroscia 7 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Montà 265 Rio Grande Arroscia 7 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Mugno 266 Rio Antica Arroscia 7 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Salino 267 Rio Bernarda Arroscia 7 ARMO Fognatura Com.le Armo 298 Rio della Pissa Arroscia 8 AURIGO Fognatura Com.le Aurigo 230 Rio Banco Impero 8 AURIGO Fognatura Com.le Poggialto 232 Rio Garbi Impero 7 diretto BADALUCCO Fognatura Com.le Badalucco 115 T. Argentina Argentina (in progetto collegamento con dep.Riva Ligure) BADALUCCO Fognatura Com.le Ciabaudo 337 Terreno Argentina 7 BAIARDO Fognatura Com.le Baiardo 32 Terreno Nervia 7 BAIARDO Fognatura Com.le Baiardo 35 Rio Marin Nervia 8 BAIARDO Fognatura Com.le Vignai 34 Nervia diretto Mare a 1000 mt. dalla BORDIGHERA Fognatura Com.le al largo di Bordighera 57 1 costa BORGHETTO D'ARROSCIA Fognatura Com.le Borghetto d'Arroscia 268 T. -

Torrente Impero
AUTORITÀ D I BACINO REGIONALE TORRENTE IMPERO Ambito di Bacino n.6 - IMPERO PIANO DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) PIANO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO APPROVAZIONE Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia n. 88 del 15/10/2002 ULTIMA MODIFICA DELL'ELABORATO Decreto del Direttore Generale n.100 del 13/04/2017 ENTRATA IN VIGORE BURL n.19 del 10/05/2017 – parte II Piano di Bacino – Impero Piano degli interventi 5. Piano di interventi di mitigazione del rischio Premessa In ordine alle criticità e situazioni di rischio descritte nei Capitoli 3 e 4, sono stati individuati interventi in grado di ridurre il rischio, con gradualità e a stadi successivi. Gli interventi sono riferiti alle criticità evidenziate nella pericolosità mentre le priorità è determinata dal rischio. Il Piano ha previsto misure sia di tipo strutturale che non strutturale , tra loro complementari e sono: -interventi strutturali puntuali -interventi strutturali areali -manutenzione ordinaria degli alvei e dei versanti -delocalizzazione Generalmente si considerano quell’ insieme di opere realizzate attraverso strutture permanenti che condizionano lo sviluppo e l’evoluzione dell’evento in maniera fisica; interventi non strutturali: sistema di provvedimenti di tipo amministrativo, normativo, urbanistico. Dei provvedimenti non strutturali fanno parte la disciplina dell’uso del territorio, la predisposizione e attuazione di piani di protezione civile e di emergenza per la salvaguardia delle popolazioni e dei beni. Le due impostazioni sono differenti ma complementari, infatti, si ritiene che una riduzione del rischio sia attuabile attraverso una riduzione e della pericolosità e del danno potenziale. -
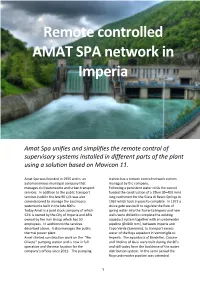
Remote Controlled AMAT SPA Network in Imperia
Success Stories: soluzioni nel telecontrollo Remote controlled AMAT SPA network in Imperia Amat Spa unifies and simplifies the remote control of supervisory systems installed in different parts of the plant using a solution based on Movicon 11. Amat Spa was founded in 1955 and is an station has a remote control network system automonomous municipal company that managed by the company. manages civil waterworks and urban transport Following a persistent water crisis the council services. In addition to the public transport funded the construction of a 35km (Ø=400 mm) services (sold in the late 90’s) it was also long catchment for the Giara di Rezzo Springs in commissioned to manage the Lascinasco 1967 which took 3 years to complete. In 1972 a waterworks built in the late 800’s. sluice gate was built to regulate the flow of Today Amat is a joint stock company of which spring water into the Torrente Impero and new 52% is owned by the City of Imperia and 48% wells were drilled to complete the existing owned by the Iren Group which has 50 aquaduct system together with an underwater employees. In addition to the services pipeline (Ø=800 mm), between Imperia and described above, it also manages the public Capo Verde (Sanremo), to transport excess thermal power plant. water of the Roja aquaduct in Ventimiglia to Amat started construction work on the “Rio Imperia. The aquaducts of Bardellini, Cascine Oliveto” pumping station and is now in full and Molino of Guisi were built during the 80’s operation and the new location for the and still today form the backbone of the water company’s offices since 2011. -

Curriculum Vitae Massimiliano Mela
Curriculum Vitae Massimiliano Mela Data di nascita: 03/11/1971 Luogo di nascita: Sanremo Nazionalità: Italiana Stato civile: celibe Residenza: Via Santuario, 18021 Borgomaro (Imperia) Tel. +39 0183 54130 Mobile: +39 338 8371274 E-mail: [email protected] Curriculum scolastico 2003 Abilitazione alla professione di Ingegnere Conseguita nel 2003 c/o Università degli Studi di Genova. Votazione 152/200 2002 Laurea in Ingegneria Informatica Titolo della Tesi : ”Un sistema per la definizione del workflow applicato alla gestione della supply chain di aziende produttive manifatturiere” Relatori : M. Paolucci, A. Boccalatte, R. Sacile Conseguita nel 2002 c/o Università degli Studi di Genova. Votazione 94/110 1990 Diploma di Ragioniere Perito commerciale e Programmatore c/o I.T.C. “G.Ruffini” di Imperia. Votazione: 40/60 Conoscenze linguistiche Francese : discreto scritto e parlato Inglese : buono scritto e parlato Conoscenze informatiche Sistemi operativi: Dos, Windows 3.11, Windows 9X, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux (livello base) Applicativi Windows: Suite MSOffice, StarOffice, OpenOffice, OrCAD Sviluppo in ambito web: HTML, DHTML, Javascript, Java, PHP, VBscript Applicativi in ambito web: Client FTP, Suite Macromedia,Telnet Linguaggi di programmazione: C++, Cobol, Fortran, Pascal, SQL Basi dati: Ms-SQLServer, MySQL, Oracle, MsAccess Networking: Gestione reti Microsoft, Reti Wireless, Windows Server Update Services, Microsoft Software Update Services, protocolli (TCP/IP, WAP, ecc.), cablaggi, apparati di rete (hub, switch, router, ecc.), Tecnologia Citrix MetaFrame Hardware: Assemblaggio e riparazione PC, installazione periferiche, manutenzione Server, realizzazione cablaggi e interfacce elettroniche Grafica: Adobe Photoshop, Adobe PageMaker Corel Draw, Suite Acrobat Esperienze di lavoro Grafico presso il Centro Stampa Offset Ottobre 2002 – Novembre 2003 Grafiche Amadeo di Chiusanico . -

Orario Estivo 2018 Per Biglietteria
RIVIERA TRASPORTI S.p.A. ORARIO ESTIVO 2018 LINEE VALLE IMPERO DI IMPERIA in vigore dal 13 giugno 2018 LINEA 28 : IMPERIA ONEGLIA - PONTEDASSIO ° ° ° ° ° + ° ° ° ° + ° ° Imperia Oneglia 05.40 05.50 06.00 06.30 07.20 08.00 08.30 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 12.45 12.50 13.05 Pontedassio 05.55 06.05 06.15 06.45 07.35 08.20 08.45 10.20 11.15 11.45 12.20 12.45 13.00 13.05 13.20 ° ° + ° ° ° Imperia Oneglia 13.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 Pontedassio 13.45 15.20 16.20 17.20 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 LINEA 28 : PONTEDASSIO - IMPERIA ONEGLIA ° ° ° + ° ° ° ° + ° + ° ° ° Pontedassio 07.00 07.15 07.25 08.20 08.45 09.15 10.20 12.15 12.20 13.30 14.15 14.30 14.40 15.15 15.20 Imperia Oneglia 07.15 07.30 07.40 08.37 09.00 09.32 10.37 12.30 12.37 13.45 14.30 14.45 14.55 15.30 15.37 + ° ° ° Pontedassio 16.20 17.20 18.20 19.30 19.35 20.15 20.45 Imperia Oneglia 16.37 17.37 18.37 19.45 19.50 20.30 21.00 LINEA 26 : IMPERIA ONEGLIA - PONTEDASSIO - BESTAGNO - VILLA VIANI ( solo feriale ) ° ° ° ° ° Imperia Oneglia 06.30 08.30 11.30 12.45 18.45 Pontedassio 06.45 08.45 11.45 13.00 19.00 Bestagno 06.55 08.55 11.55 13.10 19.10 Villa Viani 07.05 09.05 12.05 13.20 19.20 Pontedassio 07.15 09.15 12.15 13.30 19.30 Imperia Oneglia 07.30 09.30 12.30 13.45 19.45 LINEA 28 : IMPERIA ONEGLIA - PONTEDASSIO - LUCINASCO ( solo feriale ) ° ° ° ° ° °sl Imperia Oneglia 06.00 12.30 18.30 Lucinasco 06.40 13.10 19.05 Pontedassio 06.15 12.45 18.45 Chiusavecchia 06.55 13.25 19.20 Chiusavecchia 06.20 12.50 18.50 San Lazzaro Reale - - 19.25 Lucinasco 06.35 13.05 19.05 Pontedassio 07.00 13.30 - ( sl ) = A San Lazzaro Reale effettua coincidenza per Imperia Imperia Oneglia 07.15 13.45 - LINEA 27-28 : IMPERIA ONEGLIA - PONTEDASSIO - CARAVONICA - CESIO - TORRIA - GAZZELLI - CHIUSANICO ° ° + ° ° + ° + sl Imperia Oneglia 05.50 12.50 12.50 18.15 Cartari 06.40 13.53 - Pontedassio 06.05 13.05 13.05 18.30 Colla San Bartolomeo 06.47 14.00 13.45 19.05 19.05 Gazzelli - 13.15 13.15 18.40 San Bart. -

Relazione Monografica N. A11 IMPERO
Relazione monografica n. A11 IMPERO IDENTIFICAZIONE BACINO Elenco dei Comuni appartenenti al bacino e relativa % di territorio interessato Codice ISTAT Superficie occupata dal % superficie Bacino Provincia e Nome del Comune Comune nel Bacino 2 occupata dal Comune Comune (km ) 008005 AURIGO 8,76 9,16% 008010 BORGOMARO 23,12 24,18% 008012 CARAVONICA 4,53 4,74% 008018 CESIO 5,07 5,30% 008019 CHIUSANICO 13,69 14,31% 008020 CHIUSAVECCHIA 3,16 3,31% 008031 IMPERIA 14,39 15,05% 008033 LUCINASCO 8,11 8,48% 008045 PONTEDASSIO 14,60 15,26% Elenco corpi idrici tipizzati afferenti al bacino Denominazione Corpo Categoria Corpo Natura Corpo Idrico Tipologia Codice Corpo Idrico Idrico Idrico T. IMPERO 09SS2T 6951li corso d'acqua NATURALE T. IMPERO 09SS2T 6952li corso d'acqua NATURALE T. IMPERO 09IN8T 6953li corso d'acqua NATURALE T. IMPERO 09IN8T 6954li corso d'acqua NATURALE T. IMPERO 09IN8T 6955li corso d'acqua HMBW IMPERO AV 1.1 CI_AIM05 acque sotterranee NATURALE Nota: HMWB = Altamente modificato Bacino Impero 1 A11 CARATTERISTICHE DEL BACINO Caratteristiche geografiche Il bacino del T. Impero ha una superficie di circa 95,6 Kmq e risulta ampio nella parte superiore per restringersi gradualmente a partire da S.Lazzaro Reale fino alla foce, dal punto in cui si restringe presenta una direzione perpendicolare rispetto alla linea di costa. Il principale nodo orografico è il Monte Grande, da questo si dipartono due crinali che delimitano la valle e degradano ad Est fino a Capo Berta e ad Ovest fino a Punta delle Forche Vecchie. Il crinale, che è disposto parallelamente alla costa partendo dal Monte Grande divide la valle dell’Impero da quella dell’Arroscia. -

Cesio È La Località in Gara Sulla Pagina Facebook Di “Ponente Ligure Fotosintesi”
1 Cesio è la località in gara sulla pagina Facebook di “Ponente ligure fotosintesi” di Elisa Colli – 25 Settembre 2017 – 12:06 Cesio. Questa settimana Cesio è la località in gara per il concorso gratuito “I Like” di “Ponente ligure fotosintesi” che mette in competizione i Comuni della provincia per il titolo di paese più ammirato. Il territorio di Cesio è situato nell’alta valle del torrente Impero, sul fianco sinistro del rio Tresenda, lungo la vecchia strada del colle di Nava, a 5 km dal valico di colle San Bartolomeo tra le vette del monte Arosio. L’antico toponimo di Cesio potrebbe essere identificato con il termine Céxeno, citato nel 1150 in merito alla riscossione delle decime religiose presso il territorio della valle del Maro. Intorno al XIV secolo il nome mutò in Cezio, così come attesterebbe un documento del 1346 indicante un certo Facius Ferrerius de Cezio. Secondo altri il nome deriverebbe dal dialettaleCexi (ceci), ancora oggi utilizzato per indicare il nome del paese, visto che prima della coltivazione intensiva dell’ulivo, quella dei ceci era la coltivazione più diffusa. Le prime testimonianze scritte sul borgo di Cesio compaiono comunque nel XII secolo quando il territorio, appartenente al vescovo della diocesi di Albenga, viene citato tra i borghi della valle di Oneglia e del Maro in merito alle riscossioni delle decime. Amministrativamente Cesio era stata inserita nella cosiddetta Castellania di Monte Arosio assieme alle località di Gazzelli, Chiusanico, Torria e Chiusavecchia e altri borghi della vicina val Merula. Nel XIII secolo tutta l’area cesiasca entrò a far parte dei territori feudali dei conti di Ventimiglia, nella valle del Maro e di Oneglia. -
SLL Areacomplessa Sllcandidatenoncomplesse
Tabella A Tabella B Tabella C SLL AreaComplessa SLLNonComplessaDgr961 SLLCandidateNonComplesse PROVINCIA DI IMPERIA Imperia Valle Arroscia AQUILA D'ARROSCIA AQUILA D'ARROSCIA Valle Arroscia ARMO ARMO Valle Impero E VALLE MARO AURIGO AURIGO Valle Arroscia BORGHETTO D'ARROSCIA BORGHETTO D'ARROSCIA Valle Impero E VALLE MARO BORGOMARO BORGOMARO Valle Impero E VALLE MARO CARAVONICA CARAVONICA CESIO CHIUSANICO CHIUSANICO Valle Impero E VALLE MARO CHIUSAVECCHIA CHIUSAVECCHIA CIPRESSA CIVEZZA Valle Arroscia COSIO D'ARROSCIA COSIO D'ARROSCIA COSTARAINERA Valle Prino DOLCEDO DOLCEDO IMPERIA Valle Impero E VALLE MARO LUCINASCO LUCINASCO Valle Arroscia MENDATICA MENDATICA Valle Arroscia MONTEGROSSO PIAN LATTE MONTEGROSSO PIAN LATTE PIETRABRUNA Valle Arroscia PIEVE DI TECO PIEVE DI TECO Valle Impero E VALLE MARO PONTEDASSIO PONTEDASSIO Valle Arroscia PORNASSIO PORNASSIO Valle Prino PRELÀ PRELÀ Valle Arroscia REZZO REZZO SAN LORENZO AL MARE Valle Prino VASIA VASIA Valle Arroscia VESSALICO VESSALICO PROVINCIA DI SAVONA Albenga Valle Arroscia RANZO Albenga VILLANOVA D'ALBENGA Cairo Montenotte ALTARE BARDINETO BORMIDA CAIRO MONTENOTTE CALIZZANO CARCARE CENGIO COSSERIA DEGO GIUSVALLA MALLARE MILLESIMO MURIALDO OSIGLIA PALLARE PIANA CRIXIA PLODIO ROCCAVIGNALE Savona Vado Ligure Savona Quiliano PROVINCIA DI GENOVA Genova Aree portuali Parte della Val Polcevera Cornigliano Erzelli Entroterra di Voltri Genova Val Fontanabuona LUMARZO Chiavari BORZONASCA Val Fontanabuona CARASCO CARASCO CHIAVARI CHIAVARI Val Fontanabuona CICAGNA CICAGNA Val Fontanabuona COGORNO -

ALL 1-Schede Delle Risorse
PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE ALLEGATO 1 – SCHEDE DELLE RISORSE ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE IMPERO E DEL MARO ALLEGATO 1 – Schede delle Risorse INDICE 1. Elenco delle risorse interne all’Associazione A.1 Referenti istituzionali A.2 Personale dipendente dall’Associazione A.3 Materiali dell’Associazione A.4 Edifici pubblici A.5 Aree di emergenza 2. Elenco delle risorse esterne all’Associazione B.1 Elenco volontari Gruppo di Protezione Civile B.2 Elenco volontari C.R.I. di Protezione Civile B.3 Elenco imprese disponibili B.4 Elenco associazioni 3. Edifici ed Aree significative C.1 Elenco edifici strategici ubicati nella Carta degli Edifici Strategici C.2 Elenco punti critici da monitorare PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE ALLEGATO 1 – SCHEDE DELLE RISORSE ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE IMPERO E DEL MARO A.1 Referenti istituzionali SINDACO Comune Nome e Cognome Recapito Aurigo Luigino DELLERBA 3351325862 / 3204320965 Borgomaro Mela MASSIMILIANO 3388371274 Caravonica Fernando GANDOLFI 3351215275 Chiusavecchia Luca VASSALLO 3282427932 Lucinasco Domenico ABBO 3385451910 / 0183297734 Pontedassio Franco ARDISSONE 3356063820 VICESINDACO Comune Nome e Cognome Recapito Aurigo Pier Carlo GANDOLFO 3290551122 Borgomaro Stefano ALESSIO 3332688914 Caravonica Giuseppe MARVALDI 3395618224 Chiusavecchia Giovanna LOSNO 3493788253 Lucinasco Pietro DEVIA 3293936695 Pontedassio Fulvio PEZZUTO 3384774771 ASSESSORE DI P.C. / REFERENTE DI P.C. Comune Nome e Cognome Recapito Aurigo XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Borgomaro XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Caravonica XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Chiusavecchia XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Lucinasco XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Pontedassio XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE ALLEGATO 1 – SCHEDE DELLE RISORSE ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE IMPERO E DEL MARO A.2 Personale dipendente dall’Associazione Indicare il personale che in caso di necessità deve poter essere attivato. -

Chiusavecchia (Im) Itinerario
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 IN 119 CITTÀ ITALIANE WWW.CAMMINATATRAGLIOLIVI.IT CHIUSAVECCHIA (IM) ITINERARIO TEMPO DI PERCORRENZA 2h LUNGHEZZA DEL PERCORSO 4km DIFFICOLTÀ Non è insensato pensare che Chiusavecchia sia stata un caposaldo Facile limitaneo bizantino. Una “chiusa” nel luogo più stretto dove le valli dell’Impero e del Maro si congiungono.Un esempio simile lo abbiamo LUOGO DI PARTENZA anche in Cisano (un tempo Clusanum) anch’esso posto alla confluenza Frazione Olivastri Piazza della delle valli Neva e Pennavaira. In ambo i casi la chiusa era a guardia Chiesa della direttrice viaria verso il Piemonte. Un’ipotesi suffragata anche dalla collocazione dei borghi: Torria, Chiusanico e Lucinasco formano una linea trasversale sulla valle. Nel basso medioevo Chiusavecchia era, ORARIO DI PARTENZA per questi paesi, il centro industriale e commerciale di fondovalle; ciò 9.30 grazie alla collocazione lungo l’Impero, che permise lo sfruttamento dell’energia idraulica. Olivastri e Sarola sono le due ville di INFO Chiusavecchia; nuclei agricoli, sviluppatisi dopo il XV secolo con la [email protected]. coltivazione intensiva dell’ulivo. I due borghi trassero vantaggio anche it dalla posizione lungo la principale via di collegamento alla strada Marenca, che risaliva il crinale occidentale della valle Impero. Il benessere portato dal commercio e dalla produzione dell’olio, tra il XVI TELEFONO e il XIX secolo, è visibile nelle chiese, simboli della collettività. All’inizio 0183 52406 del XVI secolo fu ristrutturato a Chiusavecchia il santuario della Madonna dell’Uliveto, pochi decenni dopo fu ricostruita la Chiesa di San Vincenzo a Sarola, dove oggi si può ammirare una tela del Borzone – pittore genovese del XVI secolo – che ritrae, con insolita iconografia, Cristo e S. -

Imperia Testo Ingl
VARIED, UNEXPECTED AND ENJOYABLE HOLIDAYS IN THE FRAGRANT AIR OF LIGURIA, SURROUNDED BY THE MOUNTAINS THAT SEEM TO SINK INTO THE SEA IMPERIA E VALLE IMPERO O n eglia, together with Po r to Maurizio, forms the city of Imperia. Its hinterland is dotted with small villages perched on the slopes, also known for the genuine cuisine with excellent olive oil and good wine he promontory of Parasio hosts the ancient hamlet of Po rto Maurizio, with its characteristic winding roads and n a r r ow lanes that lead to the top scenic viewpoint, where you can enjoy the sight of the gulf and the old hamlets Tof Marina and Foce, their parks, the villas and the well equipped lidos. It was the Impero River itself to determ i- ne the tow n ’s history. In fact its course divides Po rto Maurizio from Oneglia, making them rival villages in past time: Po rto Maurizio was faithful to the Republic of Genoa while Oneglia, at first, was a domain of the Bishop of A l b e n ga , then it was sold to the Doria fa m i ly until it was transferred under the Savoia's dominion in 1576. It was only in 1923 that these two villages reconciled and were unified into the Commune of Imperia. In touch with nature, here tourists fi n d c o m f o r ts, entertainments and, if they wants, also tranquility. Imperia is the ideal place to go sailing, windsurfing or cano- eing. The hinterland can better be visited by bike or horse riding.