Tracce Della Tesaurizzazione Monetaria D'età
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From Amphipolis to Mosul, New Approaches to Cultural Heritage Preservation in the Eastern Mediterranean
THE FUTURE OF THE PAST: From Amphipolis to Mosul, New Approaches to Cultural Heritage Preservation in the Eastern Mediterranean Editors Konstantinos Chalikias, Maggie Beeler, Ariel Pearce, and Steve Renette http://futureofthepast.wix.com/culturalheritage HERITAGE, CONSERVATION & ARCHAEOLOGY ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA Contents 1. The Future of the Past: From Amphipolis to Mosul, New Approaches to Cultural Heritage Preservation in the Eastern Mediterranean .......................................................................................................................................................................................... 3 Konstantinos Chalikias, National and Kapodistrian University of Athens, Maggie Beeler, Bryn Mawr College, Ariel Pearce, Temple University, and Steve Renette, University of Pennsylvania 2. Go, Do Good! Responsibility and the Future of Cultural Heritage in the Eastern Mediterranean in the 21st Century ........... 5 Morag M. Kersel, DePaul University 3. Contested Antiquities, Contested Histories: The City of David as an Example ........................................................................... 11 Rannfrid I. Thelle, Wichita State University 4. Cultural Racketeering in Egypt—Predicting Patterns in Illicit Activity: Quantitative Tools of the 21st-Century Archaeologist .......................................................................................................................................................................................... 21 Katie A. Paul, The Antiquities Coalition -

Evaluation of the Role of Iran National Museum in the Cultural Tourism in Iran
EVALUATION OF THE ROLE OF IRAN NATIONAL MUSEUM IN THE CULTURAL TOURISM IN IRAN Omid Salek Farokhi Per citar o enllaçar aquest document: Para citar o enlazar este documento: Use this url to cite or link to this publication: http://hdl.handle.net/10803/667713 ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). -

Tunisie Tunisia
TUNISIETUNISIA ROUTEUMAYYAD DES OMEYYADES ROUTE Umayyad Route TUNISIA UMAYYAD ROUTE Umayyad Route Tunisia. Umayyad Route 1st Edition, 2016 Copyright …… Index Edition Andalusian Public Foundation El legado andalusí Introduction Texts Mohamed Lamine Chaabani (secrétaire général de l’Association Liaisons Méditerranéennes); Mustapha Ben Soyah; Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) Umayyad Project (ENPI) 5 Photographs Office National du Tourisme Tunisien; Fundación Pública Andaluza El legado andalusí; Tunisia. History and heritage 7 Association Environnement et Patrimoine d’El Jem; Inmaculada Cortés; Carmen Pozuelo; Shutterstock Umayyad and Modern Arab Food. Graphic Design, layout and maps José Manuel Vargas Diosayuda. Diseño Editorial Gastronomy in Tunis 25 Printing XXXXXX Itinerary Free distribution ISBN Kairouan 34 978-84-96395-84-8 El Jem 50 Legal Deposit Number XXXXX-2016 Monastir 60 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, nor transmitted or recorded by any information Sousse 74 retrieval system in any form or by any means, either mechanical, photochemical, electronic, photocopying or otherwise without written permission of the editors. Zaghouan 88 © of the edition: Andalusian Public Foundation El legado andalusí. Tunis 102 © of texts: their authors © of pictures: their authors Bibliography 138 The Umayyad Route is a project funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and led by the Andalusian Public Foundation El legado andalusí. It gathers a network of partners in seven countries -

The Old World Paleolithic and the Development of a National Collection
/i £\ The Old World Paleolithic and the Development of a National Collection MICHAEL PETRAGLIA and RICHARD POTTS ILLUSTRATIONS BY MARCIA BAKRY SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ANTHROPOLOGY • NUMBER 48 SERIES PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION Emphasis upon publication as a means of "diffusing knowledge" was expressed by the first Secretary of the Smithsonian. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry outlined a program that included the following statement; "It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge." This theme of basic research has been adhered to through the years by thousands of titles issued in series publications under the Smithsonian imprint, commencing with Smithsonian Contributions to Knowledge in 1848 and continuing with the following active series. Smithsonian Contributions to Anthropology Smithsonian Contributions to Botany Smithsonian Contributions to the Earth Sciences Smithsonian Contributions to the Marine Sciences Smithsonian Contributions to Paleobiology Smithsonian Contributions to Zoology Smithsonian Folklife Studies Smithsonian Studies in Air and Space Smithsonian Studies in History and Technology In these series, the institution publishes small papers and full-scale monographs that report the research and collections of its various museums and bureaux or of professional colleagues in the world of science and scholarship. The publications are distributed by mailing lists to libraries, universities, and similar institutions throughout the world. Papers or monographs submitted for series publication are received by the Smithsonian Institution Press, subject to its own review for format and style, only through departments of the various Smithsonian museums or bureaux, where the manuscripts are given substantive review. -

2 December 2020 – 28 February 2021) in Leiden and Elsewhere), See
This overview was made for the AfricaKnows! Conference (2 December 2020 – 28 February 2021) in Leiden and elsewhere), see www.africaknows.eu. “When in a museum, walk slowly but keep walking.” (Gertrude Stein) The pages below attempt to showcase collection items from, mainly, museums and galleries in 52 out of the 54 countries on the African continent. Finding good photos was not easy. Unsurprisingly, most searches resulted in excellent photos of African artefacts in museums everywhere on the globe, except Africa. While searching it became clear that many African countries have a range of (small) galleries for contemporary art, where talented African artists have the opportunity to exhibit and sell their work. The last two pages show a small collection of African street art. Maaike Westra African Studies Centre Leiden, Member of the LeidenASA Core Team Leiden, February 2021 Algeria National Museum of Antiquities and ancient National Museum of Antiquities and ancient 2 Islamic art1 Islamic art Musée National des beaux-arts d'Alger3 Angola 5 Museu da Moeda Museu Nacional de Antropologia4 1 Source: https://vymaps.com/DZ/National-Museum-of-Antiquities-and-ancient-Islamic-art-111136/ 2 Source: https://vymaps.com/DZ/National-Museum-of-Antiquities-and-ancient-Islamic-art-111136/ 3 Source: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Canal_du_Loing_in_Winter 4 Source: https://pamim.blogspot.com/2006/09/um-pouco-de-cultura-angolana-no-museu_17.html 5 Source: https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g293763-d10642209-Reviews-Museu_da_Moeda- Luanda_Luanda_Province.html -

Countering Illicit Traffic in Cultural Goods F
Countering Illicit Traffic in Cultural Goods F. Desmarais (Ed.) Desmarais F. The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage Cultural objects disappear every day, whether stolen from a museum or removed from an archaeological site, to embark on the well-beaten track of illicit antiquities. A track we have yet to map clearly. The need to understand that journey, to establish the routes, to identify the culprits, and to ultimately locate these sought-after objects, gave rise to the launch of the first International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods by the International Council of Museums (ICOM). This transdisciplinary publication concludes the initial phase of the Observatory project, by providing articles signed by researchers and academics, museum and heritage professionals, archaeologists, legal advisors, curators, and journalists. It includes case studies on looting in specific countries, with the primary aim of eliciting the nature of the antiquities trade, the sources of the traffic, and solutions at hand. Countering Illicit Traffic in in Cultural Goods Illicit Traffic Countering With the financial support of the Prevention and Fight against Crime Programme, European Commission Directorate-General Home Affairs Countering Illicit Traffic in Cultural Goods The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage Edited by France Desmarais This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible -
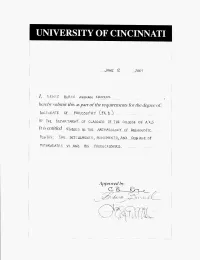
Studies in the Archaeology of Hellenistic Pontus: the Settlements, Monuments, and Coinage of Mithradates Vi and His Predecessors
STUDIES IN THE ARCHAEOLOGY OF HELLENISTIC PONTUS: THE SETTLEMENTS, MONUMENTS, AND COINAGE OF MITHRADATES VI AND HIS PREDECESSORS A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTORATE OF PHILOSOPHY (Ph.D.) In the Department of Classics of the College of Arts and Sciences 2001 by D. Burcu Arıkan Erciyas B.A. Bilkent University, 1994 M.A. University of Cincinnati, 1997 Committee Chair: Prof. Brian Rose ABSTRACT This dissertation is the first comprehensive study of the central Black Sea region in Turkey (ancient Pontus) during the Hellenistic period. It examines the environmental, archaeological, literary, and numismatic data in individual chapters. The focus of this examination is the central area of Pontus, with the goal of clarifying the Hellenistic kingdom's relationship to other parts of Asia Minor and to the east. I have concentrated on the reign of Mithradates VI (120-63 B.C.), but the archaeological and literary evidence for his royal predecessors, beginning in the third century B.C., has also been included. Pontic settlement patterns from the Chalcolithic through the Roman period have also been investigated in order to place Hellenistic occupation here in the broadest possible diachronic perspective. The examination of the coinage, in particular, has revealed a significant amount about royal propaganda during the reign of Mithradates, especially his claims to both eastern and western ancestry. One chapter deals with a newly discovered tomb at Amisos that was indicative of the aristocratic attitudes toward death. The tomb finds indicate a high level of commercial activity in the region as early as the late fourth/early third century B.C., as well as the significant role of Amisos in connecting the interior with the coast. -

Madi Phd 2018.Pdf
Bangor University DOCTOR OF PHILOSOPHY The social, cultural, and political impact of the British Military Administration on Libya, 1943-1951 Madi, Yousef Award date: 2018 Awarding institution: Bangor University Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 01. Oct. 2021 School of History, Welsh History & Archaeology The social, cultural, and political impact of the British Military Administration on Libya, 1943-1951 A thesis submitted to the University of Bangor partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy By Yousef Mohamed Ali Madi Supervisor Dr Peter Shapely April 2018 ABSTRACT This thesis examines the impact of the British Military Administration (BMA) on social- cultural and political organisations in Libya during the period 1943 to 1951. The thesis is grounded on a careful reading of secondary literature which has been integrated into available official documents available in both Arabic and English archival sources, in addition to new oral data generated from interviews. -

The Twentieth Legion and the History of the Antonine Wall Reconsidered1" Vivien G Swan*
Proc Soc Antiq Scot, 129 (1999), 399-480 The Twentieth Legion and the history of the Antonine Wall reconsidered1" Vivien G Swan* ABSTRACT A study of utilitarian pottery from the Antonine Wall has distinguished small numbers of locally made vessels with North African affinities at nine or 10 forts. Similar vessels at Chester and others made by Legio XX at the Holt works depot, one with a potter's graffito in neo-Punic, suggest the presence of North Africans. Detachments sent from Britain to Pius' Mauretanian war of AD 146-9 may have brought North Africans back with them Britainto (possibly including legionary recruits or transfers, and Moorish irregulars or levies). At the western sector of the Antonine Wall, changes in the legionary work-stints may be linked to troop reductions for the war, as the mural barrier and Bearsden and Duntocher fort interiors were still unfinished. After the conflict, Bearsden and Duntocher were each partitioned maketo annexean theirand internal buildings re-plannedand completed; programmea annexeof construction began otherat forts, secondaryand alterations were made to many existing fort interiors. All may be connected with changes in units or in the composition of the returning garrisons, now perhaps mixed and augmented with small numbers of North African troops. Possible relevant epigraphic evidence examined.is INTRODUCTION histor AntoninThe the yof e Wal bee subjeclhas nthe numbea of t bookrof articlesand s overthe past century. Most have been concerned wit structurale hth , epigraphi numismatid can c evidence (Macdonald 1911 & 1934; Steer 1964; Hanson & Maxwell 1983; Gillam 1976; Breeze 1976), though Brian Hartley's paper (1972) focused on the samian ware as a relative dating tool in a compariso occupatione th f no Hadrian'f so Antonine th d san e Walls purpose Th . -

Chapter 3 Looting of Cultural Property
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENTS OF ART HISTORY AND CLASSIC AND ANCIENT MEDITERRANEAN STUDIES INANIMATE CASUALTIES: AN ANALYSIS OF CULTURAL HERITAGE DESTRUCTION AND LOOTING DURING THE SYRIAN CIVIL WAR AND ITS REOCCURRING TIES IN CONFLICT REEMA R. PANGARKAR SPRING 2015 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for baccalaureate degrees in Art History, Classic and Ancient Mediterranean Studies, and International Politics with interdisciplinary honors in Art History and Classic and Ancient Mediterranean Studies Reviewed and approved* by the following: Ann E. Killebrew Associate Professor of Classic and Ancient Mediterranean Studies, Jewish Studies, and Anthropology Thesis Supervisor Brian Curran Professor of Art History Honors Advisor Mary Lou Zimmerman Munn Senior Lecturer in Classics and Ancient Mediterranean Studies Honors Advisor * Signatures are on file in the Schreyer Honors College. i ABSTRACT With the beginning of the Syrian Civil War, the world saw yet another conflict with high death rates, refugees, and destruction. However, that was not all that was destroyed in Syria. Destruction and looting of cultural heritage, both intentional and unintentional is a devastating reality of this conflict and many like it. The destruction and looting is funding and prolonging the fighting, encouraging destruction of cultures and people that are not the “correct faith”, and destroying thousands and thousands of years of important history. This area of the world is used to this kind of destruction, we saw similar occurrences beginning in 2003 in Iraq. What is concerning is the lack of action taken after these subsequent conflicts. Monument after monument is being looted and destroyed in the name of ideology and the world stays silent. -

List of Art Museums
List of art museums Contents Africa Asia Australia and Oceania Europe North America South America See also References Africa Algeria Algiers: Museum of Modern Art of Algiers, Museum of Popular Arts and Traditions, National Museum of Fine Arts of Algiers Oran: Ahmed Zabana National Museum Egypt Cairo: Egyptian Museum, Museum of Islamic Art, Gezira Center for Modern Art, Museum of Islamic Ceramics, Prince Amr Ibrahim Palace, The Townhouse Gallery, Mohamed Mahmoud Khalil Museum, Darb 1718 Algeria: The National Museum of Port Said: Museum of Modern Art in Egypt Fine Arts of Algiers. Ivory Coast Abidjan: Musée Municipal d'Art Contemporain de Cocody Madagascar Antananarivo: University of Madagascar's Museum of Art and Archaeology Morocco Egypt: The Egyptian Museum in Cairo. Tangier: Museum of Contemporary Art (Tangier), Musée de Carmen- Macein, Dar el Makhzen (Tangier) Namibia Windhoek: National Art Gallery of Namibia Nigeria Lagos: National Gallery of Art Lagos: National Gallery of Modern Art Oshogbo: Uli Beier Museum Rwanda Nyanza: Rwesero Art Museum Senegal Dakar: IFAN Museum of African Arts Egypt: Gezira Center for Modern Art in the Gezira district, central Cairo. South Africa Cape Town: South African National Gallery Johannesburg: MuseuMAfricA, Johannesburg Art Gallery, No Show Museum Kimberley: William Humphreys Art Gallery Nieu-Bethesda: The Owl House Port Elizabeth: Nelson Mandela Metropolitan Art Museum Pretoria: Pretoria Art Museum, Edoardo Villa Museum, Van Tilburg Collection, Van Wouw Museum Tunisia China: The Gate of Divine Might, the Kairouan: Raqqada northern gate. The lower tablet reads "The Palace Museum" (故宫博物院) Zimbabwe in Beijing. Harare: National Gallery of Zimbabwe Asia Bangladesh Dhaka: Zainul Gallery, National Art Gallery (Bangladesh), Jiraz Art Gallery China: The Shanghai Museum. -

The BMA in Libya
School of History, Welsh History & Archaeology The social, cultural, and political impact of the British Military Administration on Libya, 1943-1951 A thesis submitted to the University of Bangor partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy By Yousef Mohamed Ali Madi Supervisor Dr Peter Shapely April 2018 ABSTRACT This thesis examines the impact of the British Military Administration (BMA) on social- cultural and political organisations in Libya during the period 1943 to 1951. The thesis is grounded on a careful reading of secondary literature which has been integrated into available official documents available in both Arabic and English archival sources, in addition to new oral data generated from interviews. Its main claim to originality lies in the light that these documents throw on our understanding of the BMA’s impact on civil society in Libya. The thesis adopts a case study approach focusing on specific themes to examine the BMA’s impact on education, the press (specifically newspapers), and social, cultural and political organisations in Libya. These are viewed as key areas of concern in developing states since according to the secondary literature, including press debates at the time and available archival documentation, these organisations awakened people’s interest in the right to self determination. It is argued that in addition to the major political and economic changes that took place in Libya during this period, it was also a time of revitalisation of social, cultural and intellectual activities, both within Libya itself and in its émigré communities in Egypt and Tunisia. The BMA was characterised by remarkable developments in education, and also saw unprecedented growth in the press and in cultural and voluntary organisations.