BEVILACQUA (I,II) Incl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Opus 54. Eiermann, Wash, D
Edition Axel Menges GmbH Esslinger Straße 24 D-70736 Stuttgart-Fellbach tel. +49-711-574759 fax +49-711-574784 www.AxelMenges.de Opus 81 Carlo Scarpa, Museo di Castelvecchio, Verona With texts by Alba Di Lieto, Paola Marini and Valeria Carullo, and photographs by Richard Bryant. 52 pp. with ca. 45 illus., 280 x 300 mm, hard-cover, Italian/English ISBN 978-3-932565-81-6 Euro 36.00, £ 29.90, US$ 39.90, $A 59.00 During the 1960s Italy’s museum sector witnessed a fertile period of renewal. A generation of architects, working in partnership with the directors of museums, set about transforming into exhibition spaces a number of ancient monumental complexes located in the historic centres of some of the most important Italian cities. Among these was the brilliant and solitary Venetian architect Carlo Scarpa who re- vitalised the discipline of museography by sagaciously combining it with restoration. His lucid intervention at Verona’s Museo di Castel- vecchio is emblematic of this approach: the medieval castle, the museum of ancient art, and modern architecture all harmoniously coexisting in a monument located at the heart of a city designated a UNESCO World Heritage Site. The wise and far-sighted choice of Scarpa was owed to the then director of the museum, Licisco Magagnato, who tenaciously argued the case for the appointment of an architect specialising in this field to work on the city’s principal museum of ancient art. In his work on the Castelvecchio, carried out at a significant point in his career, Scarpa attained a remarkable balance between various aesthetic elements that is particularly evident in the sculpture gallery, where the renovations harmonise with the power of the 14th-century Distributors Veronese works exhibited in this section of the museum. -
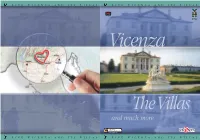
And Much More
L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS ENGLISH PROVINCIA DI VICENZA Vicenza TheVillas and much more L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS Vicenza... The Villas and much more This small structured guide to routes aims to be an instrument of easy consultation for those wishing to discover the Vicentine villas, combining their visit with the other offers of the rich territory: from museums to wine roads, from castles to typical productions. Here below you will not merely fi nd a list of villas since those which most represent the defi nition of tourist interest have been carefully selected. Every route is subdivided into two sections: “the villas” and “much more”, in order to indicate that besides the villas there are other attractions for the visitor. The villas in the fi rst section are generally usable, from the point of view of opening and accessibility to the visitor. 1 itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino Romano d'Ezzelino Pove del Grappa Mussolente 12 BASSANO The Villas DEL GRAPPA Santorso Lonedo MAROSTICA Zugliano 11 7 2 - VillaRosà Ghellini, Villaverla Description 6 10 Nove SCHIO BREGANZE CartiglianoBegun in 1664 designed by Pizzocaro, the works were in- 1 CALDOGNO - VILLA CALDOGNO Sarcedo 14 terrupted in 1679, date engraved in two places of the main 2 VILLAVERLA - VILLA GHELLINI THIENE 13 3 VILLAVERLA - VILLA VERLATO PUTIN 8 9 façade, and never restarted because of the death of the archi- 4 MOLINA DI MALO - VILLA PORTO THIENE 4 15 Longa tect. -

Italien 2005 3
Italien 2005 3 Italien 2005 Prolog Wie aus Jacobus Benedictus wurde Seit Jahren wollen wir einmal den berühmten Jakobs-Weg im Norden Spaniens mit dem Wohnmobil „erpilgern“. In diesem Jahr schien der Wunsch endlich Realität geworden zu sein – bis sich herausstellte, dass Günther zu sehr mit Arbeit eingedeckt war, um 3 ½ Wochen Urlaub zu machen. Eine Woche unseres Womo- Urlaubes musste dran glauben, und so blieb unsere fromme Pilgerreise wieder nur ein frommer Wunsch, denn für den Heiligen Jacobus hätten wir schon etwas mehr Zeit erübrigen müssen. So kam also unser geliebtes Italien mal wieder ins Spiel und dazu die Idee, einmal wirklich ins Blaue zu fahren. Das Blaue blieb auch ganz nebulös, bis es hieß: Habemus Papam. Josephus aus Bayern, der obendrein einige Jahre bei uns in Bonn am schönen Rhein lebte. Nach anfänglicher Ablehnung des bisher uns als Großinquisitor des Vatikans bekannten Kardinals kamen Zweifel auf: Der wirkt ja ganz sympathisch, was er sagt, gar nicht so fundamentalistisch wie gedacht… Von diesen Gedanken bis zu der Idee, ihn sich einmal von Nahem anzuschauen, war es kein weiter Weg. Und so wissen wir nun bei Antritt unserer Reise zumindest, dass wir in der letzten Urlaubswoche mittwochs in Rom sein wollen, um von 10.30 – 12.00 Uhr eine Generalaudienz auf dem Petersplatz mit Papst Benedikt XVI. zu erleben. So wurde also aus Jacobus Benedictus. Der eine ist schon heilig, der andere muss sich den Schein erst noch verdienen. 3 Italien 2005 25. Mai 2005 Günther: Noch schnell 'ne 40-seitige Statik produziert, die Mitarbeiter instruiert, mehrere Kundenbesuche gemacht, sich um die WEG Saynscher Hof gekümmert…. -

Sandford-Couch2014 Vol1.Pdf
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. IMAGES OF JUSTICE IN NORTHERN ITALY, 1250-1400 CLARE SANDFORD-COUCH VOLUME 1 THESIS PRESENTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 2014 TABLE OF CONTENTS VOLUME 1 Declaration Abstract Acknowledgments List of Illustrations Introduction 1 Chapter 1: Setting the scene: northern Italy, c. 1250-1400 Introduction 21 1.1 The geopolitics of ‘Italy’ 21 1.2 Political background 22 1.3 The city-states 25 1.4 Contemporary political philosophy 28 1.5 Justice in contemporary political philosophy 29 1.6 The Law 32 1.7 Law in theory - what was the law? 33 1.8 Law in practice – how justice was administered 37 1.9 Prosecution procedure 41 1.10 Legal professionals 45 Conclusion 48 Chapter 2: The intrusion of secular justice into imageries of the divine in northern Italy, c. -

Castelfranco Veneto, 11 Aprile 2017
Riflessi Veneti Castelfranco Veneto, 11 aprile 2017 brochure informativa Gemellaggio Enogastronomico di Arte e Cultura Indice Venezia - S. Pietroburgo (Russia) pag. 3 Vicenza - Washington D. C. (Stati Uniti D'America) pag. 7 Verona – Giacarta (Indonesia) pag. 11 Padova – Lisbona (Portogallo) pag. 15 Belluno – Carinzia (Austria) pag. 19 Rovigo Delta del Po – Camargue (Francia) pag. 22 Treviso – Espirito Santo Anchieta (Brasile) pag. 26 2 Venezia Venezia è una meraviglia di architettura, arte e ingegneria, con chiese di marmo costruite su fondamenta sottratte all'acqua della laguna. La verità è che questa città è edificata su un terreno instabile. Con la più alta densità di capolavori per kmq, Venezia non rinuncia agli affari e al commercio. Tra le strette calli, la città è piena di vita: si incontrano artigiani che realizzano scarpe che sembrano opere d'arte, cuochi capaci di servire i piatti migliori del mondo e musicisti in grado di passare dalla musica classica ai suoni duri del punk-rock. I suoi magnifici palazzi, come il Palazzo Ducale e il museo Correr, sono il teatro delle esposizioni più grandi dedicate al passato, ma anche dell'arte contemporanea. Senza contare che, dietro ai luoghi più illustri, come la Piazza San Marco con la sua Basilica, incontriamo vari stili architettonici, da quello barocco a quello arabo. Da non perdere sono le isole, Murano con la tradizione del vetro soffiato, Burano famosa per i merletti e Torcello con la sua atmosfera silenziosa. 3 San Pietroburgo San Pietroburgo è stata soprannominata la Venezia del Nord per i suoi canali costeggiati da sontuosi palazzi. La città conserva quasi intatta la splendida eredità dell'epoca zarista. -

Padova and the Birth of the Renaissance
Padova and the Birth of the Renaissance Travel Passports Baggage allowance Please ensure your 10 year British Passport is not We advise you to check the baggage allowances out of date and is valid for a full three months carefully as you are likely to be charged the excess beyond the duration of your visit. EU, Andorra, if you exceed the weight limit. Maximum weights Liechtenstein, Monaco, San Marino or Switzerland for single bags apply. valid national identification cards are also acceptable for travel to Italy. With British Airways your ticket includes one hold bag of up to 23kg plus one cabin bag no bigger than 56 x 45x 25cm including handles, pockets and Visas wheels, and a personal bag (handbag or computer British and EU passport holders are not required to case) no bigger than 45 x 36 x 20cm including have a visa. handles, pockets and wheels. For all other passport holders please check the visa requirements with the appropriate embassy. For more information please visit www.britishairways.com Italian Consulate-General: “Harp House”, 83/86 Farringdon Street, London EC4A 4BL. Tel: (0)20 7936 5900. Fax: (0)20 7583 9425. Labels Email: [email protected] Please use the luggage labels provided. It is useful Website: to have your home address located inside your http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra suitcase should the label go astray. Open Mon-Fri 0900-1200 Transfers On arrival in Verona, transfer by coach (approx. 1½ hours) to Padova, to NH Hotel, Padova. Tickets Included with your detailed itinerary is an e-ticket, which shows your flight reference number.