Veronica Gambara
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Veronica Gambara Undici Lettere Inedite Edited by Luigi Amaduzzi Guastalla: R
Veronica Gambara Undici lettere inedite Edited by Luigi Amaduzzi Guastalla: R. Pecorini [p. [5]] Cenni biografici di Veronica Gambara (1) Tre donne vennero in maggior fama di letterate nel secolo XVI; Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, e Veronica Gambara. Moltissime altre coltivarono le lettere in quel tempo; di esse alacremente oggi si studia richiamare la memoria onorevole e ridonarla al culto dei moderni. Dissi molte altre, ma le tre nominate tennero il primato su tutte. La data della loro nascita varia di pochi anni, quella della morte quasi coincide. La Gambara nacque il 30 Novembre 1485, nel novanta nascerà la Colonna, trentaquattro anni dopo, la Stampa. Nel 1550 morì la Gambara, tre anni dopo, la Colonna; nel cinquantaquattro si spense la Stampa. Erano adunque tre stelle che risplende. vano ad un tempo nel cielo letterario d'Italia. Un luogo assai popolato del territorio bresciano, detto Prato Alboino, che fu feudo della nobilissima Famiglia Gambara, diede i natali alla nostra Veronica. Suoi genitori furono il Conte Gianfrancesco Gambara e Alda Pia da Carpi, personaggi ragguardevolissimi, siccome le istorie mostrano. Veronica ebbe quattro fratelli e due sorelle; Camillo, Uberto, Brunoro, Ippolito, Violante ed Isotta, tutti non meno per azioni che per letteratura illustri. Aveva essa sortito da natura un ingegno assai vivace, penetrante, e molta inclinazione per le lettere, alle quali si diè fin [p. 6] da' più teneri anni. Chi fosse suo maestro negli studi non è chiaro; taluni affermano il Bembo, col quale fu in domestichezza, ma molti dubbî sorgono leggendo alcuni passi delle poesie di lui. Quello che più manifesto appare, si è che della guida e del patrocinio del Veneziano molto profittevolmente si valse la Gambara, come attesta il fatto che a lui per primo mandava ogni suo poetico componimento ed attenevasi al suo giudizio, come a quello che autorevole stimava. -
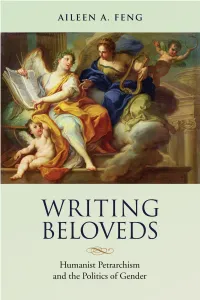
C9587233972dad1b9500b32c15
WRITING BELOVEDS Humanist Petrarchism and the Politics of Gender AILEEN A. FENG Writing Beloveds Humanist Petrarchism and the Politics of Gender UNIVERSITY OF TORONTO PRESS Toronto Buffalo London © University of Toronto Press 2017 Toronto Buffalo London www.utppublishing.com Printed in the U.S.A. ISBN 978-1-4875-0077-1 Printed on acid-free, 100% post-consumer recycled paper with vegetable-based inks. Toronto Italian Studies Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Feng Aileen A., author Writing beloveds : humanist Petrarchism and the politics of gender / Aileen A. Feng. (Toronto Italian studies) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-4875-0077-1 (cloth) 1. Petrarca, Francesco, 1304–1374 – Influence. 2. Italian poetry – 16th century – History and criticism. 3. Petrarchism. 4. Humanism in literature. 5. Politics in literature. 6. Sex roles in literature. I. Title II. Series: Toronto Italian studies PQ4103.F45 2016 851'409 C2016-904897-7 CC-BY-NC-ND This work is published subject to a Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivative License. For permission to publish commercial versions please contact University of Tor onto Press. This book has been published with the financial assistance of The Provost’s Author Support Fund at the University of Arizona, and a Book Subvention Award from the Medieval Academy of America. University of Toronto Press acknowledges the financial assistance to its publishing program of the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council, an agency of the Government -
Complete Poems: a Bilingual Edition
Complete Poems: A Bilingual Edition VERONICA GAMBARA • Critical introduction by MOLLY M. MARTIN Edited and translated by MOLLY M. MARTIN AND PAOLA UGOLINI Iter Inc. Centre for Reformation and Renaissance Studies Toronto 2014 Iter: Gateway to the Middle Ages and Renaissance Tel: 416/978–7074 Email: [email protected] Fax: 416/978–1668 Web: www.itergateway.org Centre for Reformation and Renaissance Studies Victoria University in the University of Toronto Tel: 416/585–4465 Email: [email protected] Fax: 416/585–4430 Web: www.crrs.ca © 2014 Iter Inc. & Centre for Reformation and Renaissance Studies All rights reserved. Printed in Canada. Iter and the Centre for Reformation and Renaissance Studies gratefully acknowledge the generous support of James E. Rabil, in memory of Scottie W. Rabil, toward the publication of this book. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Gàmbara, Veronica, 1485-1550 [Poems] Complete poems / Veronica Gambara ; critical introduction by Molly M. Martin ; edited and translated by Molly M. Martin and Paola Ugolini. — A bilingual edition. (The other voice in early modern Europe : The Toronto series ; 34) Includes bibliographical references and index. Issued in print and electronic formats. Poems in Italian with English translations; remaining text in English. ISBN 978-0-7727-2168-6 (pbk.) ISBN 978-0-7727-2169-3 (pdf) 1. Gàmbara, Veronica, 1485–1550—Translations into English. 2. Gàmbara, Veronica, 1485–1550—Criticism and interpretation. I. Ugolini, Paola, editor, translator II. Martin, Molly M., editor, translator, writer of added commentary III. Victoria University (Toronto, Ont.). Centre for Reformation and Renaissance Studies, issuing body IV. Iter Inc, issuing body V. -

The Poems and Letters of Tullia D'aragona and Others
The Poems and Letters of Tullia d’Aragona and Others A BILINGUAL EDITION • Edited and translated by JULIA L. HAIRSTON Iter Inc. Centre for Reformation and Renaissance Studies Toronto 2014 Iter: Gateway to the Middle Ages and Renaissance Tel: 416/978–7074 Email: [email protected] Fax: 416/978–1668 Web: www.itergateway.org Centre for Reformation and Renaissance Studies Victoria University in the University of Toronto Tel: 416/585–4465 Email: [email protected] Fax: 416/585–4430 Web: www.crrs.ca © 2014 Iter Inc. & Centre for Reformation and Renaissance Studies All rights reserved. Printed in Canada. Iter and the Centre for Reformation and Renaissance Studies gratefully acknowledge the generous support of James E. Rabil, in memory of Scottie W. Rabil, toward the publication of this book. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Aragona, Tullia d’, approximately 1510-1556, author The poems and letters of Tullia d’Aragona and others / edited and translated by Julia L. Hairston. — A bilingual edition. (Other voice in early modern Europe. The Toronto series ; 28) Includes poems by: Alessandro Arrighi (flourished 1544), Benedetto Arrighi (died July 1550), Ercole Bentivoglio (1507–1573), Lattanzio Benucci (1521–1598), Giulio Camillo Delminio (1485–1544), Simone Della Volta (1506–1554), Antonfrancesco Grazzini, (1504–1584), Camillo Malpigli (flourished 1546), Latino Giovenale de’ Manetti, (1485/6–1553), Ludovico Martelli (1500–1527/28), Niccolò Martelli (1498–1555), Ugolino Martelli, (1519–1592), Ippolito de’ Medici (1511–1535), Francesco Maria Molza (1489–1544), Girolamo Muzio (1496–1572), Simone Porzio, (1496–1554), Filippo Strozzi (1489–1538), Benedetto Varchi (1503–1565). Includes bibliographical references and indexes. -

The Poetry of Parmigianino's “Schiava Turca”
Iconic Painting is Newly Interpreted and Comes to the U.S. for the First Time THE POETRY OF PARMIGIANINO’S “SCHIAVA TURCA” The Frick Collection, New York May 13 through July 20, 2014 Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco July 26 through October 5, 2014 Francesco Mazzola (1503–1540), called Parmigianino after Parma, the Northern Italian city of his birth, was one of the most prolific and celebrated artists of the sixteenth century. Known as “Raphael reborn,” he mastered the arts of painting, drawing, and printmaking and was renowned for his portraits. Today his exquisite portrait of an unknown woman called the Schiava Turca (Turkish Slave) is an icon of Parma. The painting, which has rarely been seen outside its home institution, the Galleria Nazionale di Parma, travels to the United States for the first time for its presentation at The Frick Collection (and subsequently at the Legion of Honor, part of the Fine Arts Museums of San Francisco). The showing at the Frick marks the museum’s third collaboration with the Foundation for Italian Art & Culture (FIAC), a series of loans focused on the female portrait in the Renaissance. The collaboration previously featured Raphael’s La Fornarina (Rome, Parmigianino, Schiava Turca, c. 1531–34, oil on panel, Galleria Nazionale di Parma, photo: Scala/Art Resource, NY Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini) and Parmigianino’s Antea (Naples, Museo di Capodimonte). The Poetry of Parmigianino’s “Schiava Turca” will be accompanied by a catalogue and numerous public programs. The exhibition is curated by Aimee Ng, Research Associate at The Frick Collection and Lecturer in the Department of Art History and Archaeology at Columbia University, and is organized by 1 The Frick Collection with the Foundation for Italian Art & Culture. -

COMPLETE POEMS E Other Voice in Early Modern Europe
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321159125 Veronica Gambara. Complete Poems. Book · November 2014 CITATIONS READS 0 277 1 author: Paola Ugolini University at Buffalo, The State University of New York 8 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Encyclopedia of Renaissance Philosophy View project All content following this page was uploaded by Paola Ugolini on 06 August 2019. The user has requested enhancement of the downloaded file. COMPLETE POEMS !e Other Voice in Early Modern Europe: !e Toronto Series, xx The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series SERIES EDITORS Margaret L. King and Albert Rabil, Jr. SERIES EDITOR, ENGLISH TEXTS Elizabeth H. Hageman Previous Publications in the Series M!"#$ M!#í! R%&! P$#)$**$ "2 G2'11$* Journey of Five Capuchin Nuns Complete Poems: A Bilingual Edition Edited and translated by Sarah E. Edited by Karen Simroth James Owens Translated by Marta Rijn Finch Volume 1, 2009 Volume 6, 2010 G'%(!) B!**'&*! A)"#$')' A)*%)'! P21.' Love in the Mirror: A Bilingual Edition Saints’ Lives and Bible Stories for the Edited and translated by Jon R. Snyder Stage: A Bilingual Edition Volume 2, 2009 Edited by Elissa B. Weaver Translated by James Wyatt Cook R!+,%)" "$ S!-!)!. !)" Volume 7, 2010 S',%)$ Z!)!../' Two Women of the Great Schism: 0e V!1$#'! M'!)' Revelations of Constance de Rabastens Celinda, A Tragedy: A Bilingual by Raymond de Sabanac and Life of Edition the Blessed Ursulina of Parma by Edited by Valeria Finucci Simone Zanacchi Translated by Julia Kisacky Edited and translated by Renate Annotated by Valeria Finucci and Blumenfeld-Kosinski and Bruce L. -

{TEXTBOOK} La Fine Del Mondo Storto Kindle
LA FINE DEL MONDO STORTO Author: Mauro Corona Number of Pages: 160 pages Published Date: 22 Sep 2015 Publisher: Mondadori Publication Country: Milano, Italy Language: Italian ISBN: 9788804656630 DOWNLOAD: LA FINE DEL MONDO STORTO La fine del mondo storto PDF Book Excerpt from Storia della Grande Guerra d'Italia, Vol. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. (il Pistoia), Pandolfo Collenuccio, Lo renzo de' Medici, Girolamo Savonarola, Leonardo da Vinci, Angelo Poli ziano, Jacopo Sannazaro, Galeazzo di Tarsia, Niccolò Machiavelli, Pietro Bembo, Lodovico Ariosto, Giovanni Rucellai, Michelangiolo Buonarroti, Ja copo Nardi, Baldassarre Castiglione, Giangiorgio Trissino, Francesco Guic ciardini, Luca Della Robbia, Luigi da Porto, Matteo Bandello, Veronica Gambara, Francesco Maria Molza, Vittoria Colonna, Donato Giannotti Agnolo Firenzuola, Bernardo Tasso, Pier Francesco Giamhullari, Luig1 Alamanni, Girolamo Muzio, Francesco Berni, Giovan Batista Gelli, Pier Vettori, Giovanni Guidiccioni, Jacopo Bonfadio, Sperone Speroni, Benve nuto Cellini, Anton Francesco Grazzini (il Lasca), Giovanni Della Casa, Benedetto Varchi, Bernardo Segni, G. Perche non si smette di viaggiare quando si diventa genitori. Grazie alle innumerevoli tecniche descritte capirai che con i giusti metodi è possibile ritornare a stare bene e sconfiggere le situazioni difficili. Egli domani: si ritornerà al barca, dove dice, che la Reina dimorera tutto quest' altro mese, o in quel torno, a tua contezza. Lo amerai. The first part of the book focuses on the historical documentary study of the fortification existence phases from the first half of the XVII century up to 1799 and on the change from French dominion to the House of Savoy control. -

Gaspara Stampa's “Poetic Misprision” of Giovanni Boccaccio's
University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 3-22-2010 The Fiction of The Rime: Gaspara Stampa’s “Poetic Misprision” of Giovanni Boccaccio’s The Elegy of Lady Fiammetta Ellan B. Otero University of South Florida Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons Scholar Commons Citation Otero, Ellan B., "The Fiction of The Rime: Gaspara Stampa’s “Poetic Misprision” of Giovanni Boccaccio’s The Elegy of Lady Fiammetta" (2010). Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/1733 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. The Fiction of The Rime: Gaspara Stampa’s “Poetic Misprision” of Giovanni Boccaccio’s The Elegy of Lady Fiammetta by Ellan B. Otero A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of English College of Arts and Sciences University of South Florida Major Professor: Silvia R. Fiore, Ph.D. Giovanna Benadusi, Ph.D. Sara M. Deats, Ph.D. Patrizia La Trecchia, Ph.D. Date of Approval March 22, 2010 Keywords: Renaissance, Women, Petrarch, Bloom, Autobiography © Copyright 2010, Ellan B. Otero Table of Contents Abstract .............................................................................................................................