SIMBOLI E DIRITTI Uno Studio Sociologico-Giuridico Sul Burqa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

15, 1940 F O U R C E N T S
Are In Business Tell Them So Through The Times ^iuiinHiuiitM*»*«ruiuiiin»niunninmiiuntmuuvuiiisiiuitiiiiiuioiin'jiiinii(n ~ VOL. LXV. No. 46 ”OCEAN_GROVE, NEW: JERSEY, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1940 F O U R C E N T S Warns of Freezing A. D. Clark Feted at TWO GROVE POLICEMEN FLEE Armistice Day Celebrated At Shore With Parade, WHEN SKUNK GOES ON SPREE A s Winter Comes Patrolmen William Herbert Memorial Exercises Conducted at Churches, Parks Given to Women*s Club Board and Raymond Anderson will Automobile Club Sees Danger take anything within reason in jn Neglect of Minor, Yet Club Member Honored After the line ..of duty, but when a Important, Items; Important Moulton Named by Thousands In Line of March at Asbury Park, . skunk makes his . appearance, . P oints’ Given Eighteen Years Service To Ocean Grove that’s an entirely different Educational Group m a t t e r . *7. As a poetical'theifteT frost, may Include Soldiers From Forts Hancock and Unit; Mrs'. Paul J. Strassburger Hostess ; The two policemen Were at be all right on pumpkins, the Key Dr. Onsville J. Moulton, super Monmouth, Company G , Formerly of the booth'ati the Main avenue stone Automobile Club observes, vising; principal of the Neptune but frosty mornings can play ha A! tea to the executive board of gates Sunday morning, when Township. school system, was nam Asbury Park; Wreaths Placed By Groups voc with motor cars not: yet con ed to the office of vice; president the' Ocean Grove Woman’s club and Union Thanksgiving tiie animal was .noticed calmly ditioned for cold-weather driving. -

Family Handbook
2020-2021 Yu Ming Charter School Student - Family Handbook Alcatraz Site (Main Site): 1086 Alcatraz Ave Oakland, CA 94608 510-452-2063 MLK Site: 675 41st Street Oakland, CA 94609 510-922-8631 Website: http://www.yumingschool.org/ TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION Background on Yu Ming Charter School Location Mission Statement Core Values What is a charter school? Yu Ming Equity Statement OUR TEAM Administration Operations Lower School Alcatraz Campus Upper School MLK Campus Enrichment Team Student Support Team Teaching Assistants and Interns After School Program (ASP) Team COMMUNICATION GUIDELINES Communication with Families about Student Academic Progress GOVERNANCE Role of the Board of Directors PARTNERSHIP BETWEEN FAMILIES AND YU MING Student-School-Family Contract Yu Ming Family Support Organization (“FSO”) VOLUNTEERS & VISITORS Volunteer Responsibilities Volunteer Opportunities Parent Fundraising at Yu Ming Volunteer Requirements Volunteer Driver Requirement Classroom and School Volunteer, Visitation, and Removal Policy ATTENDANCE POLICIES School Calendars Updated September 8, 2020 Page 1 Excused Absences Unexcused Absences Consequences of Unexcused Absences Including Tardies over Thirty Minutes Late/Tardy Extended Absences during the School Year Independent Study Program (“ISP”) DROP-OFF AND PICK-UP PROCEDURES Early Pick-up Permission to Walk Home GENERAL POLICIES Authorization to Pick-Up and Emergency Contact Information Form Dress Code Birthdays Cumulative File Photographs and Videos of Students Electronic Devices Toys at School -

3096102Attachmenta
Division of Adult Institutions (DAI) RELIGIOUS PROPERTY CHART Attachment to DAI Policy 309.61.02 – Religious Property Effective: 10/01/21 INMATE PERSONAL RELIGIOUS PROPERTY: Any/all inmate personal religious property may be subject to review according to relevant DAI policies to assess potential prohibited content. Restriction/approval/denial shall include review by at least two “subject matter expert” employees (e.g. DAI Security Chief, DAI STG Committee Chair, DAI Religious Practices Coordinator, facility Security Director, facility Chaplain). Items containing religious symbols with potential dual meaning (e.g. STG identifiers) may be permitted on a case-by-case basis. For religious accommodation in the least restrictive means, DAI may require additional limitations (e.g. in-cell/room use only; not openly displayed) on a case-by-case basis above-and-beyond the generalized specifications established in this document. Any individualized accommodations established in this manner shall be documented in DOC-2075. *RESTRICTIVE HOUSING (RH) USE ITEMS: Personal religious property shall be allowed consistent with DAI 303.00.02 and 309.20.03. Least restrictive accommodation shall be assessed by the Chaplain/designee and Restrictive Housing supervisor, based upon the individual’s behavior and safety (to include clinical or medical observation). PASTORAL VISIT ITEMS: Inmates shall not take any personal property to pastoral visits. With prior approval, pastoral visitors may bring religious books/publications (including tarot cards) and other selected items (e.g., sacramental wine/beverage, sacramental bread, oil, etc.) for the purpose of providing spiritual counsel and rituals. All items are subject to security inspection. INMATES IN TEMPORARY STATUS (A&E/BARRACKS/DORMITORY/DCC HOLD): Facilities may limit total property, including religious property, due to space constraints and/or inmate transfer procedures. -

ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman
ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยบรมพิมาน ตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมาน ใชผายกไหมหรือยกทองมีเชิง หรือยกทองทั้งตัวก็ได ตัดติดกันกับตัวเสื้อ หรือเปนเสื้อ คนละทอนก็ได ซิ่นจีบหนามีชายพก ยาวจรดขอเทา ใชเข็มขัดไทยคาดเสื้อคอกลม ขอบตั้ง ผาดานหนาหรือดานหลังก็ได แขนยาว ใชสำหรับ งานพิธีตอนค่ำ เหมาะสำหรับงานพิธีเต็มยศและครึ่งยศ เชน งานอุทยานสโมสร งานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอยางเปนทางการ หรือเปนชุดเจาสาว Thai Boromphiman Thai Boromphiman, also a formal evening attire, comprises a long sleeved blouse which is either buttoned at the front or the back. The blouse is tucked beneath a Sinh with its front pleats. The fabric is brocaded to create a highly luxurious look and feel. The collar of the blouse is round-necked. The Sinh length runs about the ankle. The skirt and blouse are sewn together like a one piece dress of which style is suitable for a tall and slender wearer. It can be worn in either formal or semi-formal events such as the League Ceremony or royal functions. Royal decorations are also worn. ชุดไทยจักรี ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยอมรินทร ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยเรือนตน Thai Chakri Thai Boromphiman Thai Siwalai Thai Dusit Thai Chakraphad Thai Amarintra Thai Chitralada Thai Reun-ton www.qsds.go.th [email protected] ชุดไทยจักรี Thai Chakri ชุดไทยจักรี คือชุดไทยประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกขางหนา มีชายพกใชเข็มขัดไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอนเดียวกันหรือ จะมีผาสไบหมตางหากก็ได เปดบาขางหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยูที่เนื้อผาและการเย็บ -
![Arxiv:2105.03050V1 [Cs.CY] 7 May 2021 USD 352.58 Million in 2020 to USD 825.19 Million by the End of 2025](https://docslib.b-cdn.net/cover/9160/arxiv-2105-03050v1-cs-cy-7-may-2021-usd-352-58-million-in-2020-to-usd-825-19-million-by-the-end-of-2025-2819160.webp)
Arxiv:2105.03050V1 [Cs.CY] 7 May 2021 USD 352.58 Million in 2020 to USD 825.19 Million by the End of 2025
fAshIon after fashion: A Report of AI in Fashion Xingxing Zou, Waikeung Wong∗ The Hong Kong Polytechnic University Laboratory for Artificial Intelligence in Design (AiDLab) Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong [email protected], [email protected] Preface In this independent report - fAshIon after fashion, we examine the development of fAshIon (artificial intelligence (AI) in fashion) and explore its potentiality to become a major disruptor of the fashion industry in the near future. To do this, we investigate AI technologies used in the fashion industry – through several lenses. We summarise fAshIon studies conducted over the past decade and categorise them into seven groups: Overview, Evaluation, Basic Tech, Selling, Styling, Design, and Buying. The datasets mentioned in fAshIon research have been consolidated on one GitHub page for ease of use1. We analyse the authors’ backgrounds and the geographic regions treated in these studies to determine the landscape of fAshIon research. The results of our analysis are presented with an aim to provide researchers with a holistic view of research in fAshIon. As part of our primary research, we also review a wide range of cases of applied fAshIon in the fashion industry and analyse their impact on the industry, markets and individuals. We also identify the challenges presented by fAshIon and suggest that these may form the basis for future research. We finally exhibit that many potential opportunities exist for the use of AI in fashion which can transform the fashion industry embedded with AI technologies and boost profits. In Brief According to AI in Fashion Market Research Report 2021 [112], under the cumulative impact of COVID-19, global spending on AI in the fashion market is expected to grow from USD 229 million in 2019 to USD 1,260 million by 2024, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 40.8% during the forecast period. -

Shari'ah | Islamic Law | Religion
Ethics Theses 30 Ijtihād Maqāsidi The Interconnected Maslahah-Based Reconstruction of Islamic Laws A. Halil Thahir Interconnectedness The Prophet Muhammad | Aurat | al-Hadith | Monot Tradition | Jilbab | Muslimah Clothing | Al- Islamic Culture | Mujtahid | Khimār | Equality The Qur’an | Ijtihād | The Sunnah | In Hijāb | Judisprudence | Women | Hanafi | Justi Shari’ah | Islamic Law | Religion Ijtihād Maqāṣidi The Interconnected Maṣlaḥah-Based Reconstruction of Islamic Laws Ijtihād Maqāṣidi The Interconnected Maṣlaḥah-Based Reconstruction of Islamic Laws A. Halil Thahir Globethics.net Theses No. 30 Globethics.net Theses Director: Prof. Dr. Obiora Ike, Executive Director of Globethics.net in Geneva and Professor of Ethics at the Godfrey Okoye University Enugu/Nigeria. Series editor: Ignace Haaz, Ph.D Globethics.net Theses 30 A. Halil Thahir, Ijtihād Maqāṣidi: The Interconnected Maṣlaḥah-Based Reconstruction of Islamic Laws Geneva: Globethics.net, 2019 ISBN 978-2-88931-220-7 (online version) ISBN 978-2-88931-221-4 (print version) © 2019 Globethics.net Managing Editor: Ignace Haaz Assistant Editor: Samuel Davies English Translation: Maufur Globethics.net International Secretariat 150 route de Ferney 1211 Geneva 2, Switzerland Website: www.globethics.net/publications Email: [email protected] All web links in this text have been verified as of January 2019. This The electronic version of this book can be downloaded for free from the Globethics.net website: www.globethics.net. The electronic version of this book is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY- NC-ND 4.0). See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. This means that Globethics.net grants the right to download and print the electronic version, to distribute and to transmit the work for free, under the following conditions: Attribution: The user must attribute the bibliographical data as mentioned above and must make clear the license terms of this work; Non- commercial. -
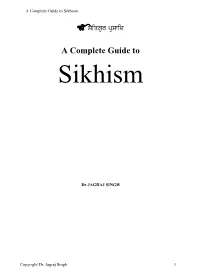
A Complete Guide to Sikhism
A Complete Guide to Sikhism <siqgur pRswid A Complete Guide to Sikhism Dr JAGRAJ SINGH Copyright Dr. Jagraj Singh 1 A Complete Guide to Sikhism < siqgur pRswid[[ “There is only one God, He is infinite, his existence cannot be denied, He is enlightener and gracious” (GGS, p1). “eyk ipqw eyks ky hMm bwrk qUM myrw gurhweI”[[ “He is our common father, we are all His children and he takes care of us all.” --Ibid, p. 611, Guru Nanak Deh shiva bar mohay ihay O, Lord these boons of thee I ask, Shub karman tay kabhoon na taroon I should never shun a righteous task, Na daroon arson jab jae laroon I should be fearless when I go to battle, Nischay kar apni jeet karoon Grant me conviction that victory will be mine with dead certainty, Ar Sikh haun apnay he mann ko As a Sikh may my mind be enshrined with your teachings, Ih laalach haun gun tau uchroon And my highest ambition should be to sing your praises, Jab av kee audh nidhan banay When the hour of reckoning comes At he ran mah tab joojh maroon I should die fighting for a righteous cause in the thick of battlefield. --Chandi Charitar, Guru Gobind Singh Copyright Dr. Jagraj Singh 2 A Complete Guide to Sikhism < siqgur pRswid A COMPLETE GUIDE TO SIKHISM Dr. JAGRAJ SINGH UNISTAR Copyright Dr. Jagraj Singh 3 A Complete Guide to Sikhism A COMPLETE GUIDE TO SIKHISM By Dr. Jagraj Singh Jagraj [email protected] 2011 Published by Unistar Books Pvt. Ltd. S.C.O.26-27, Sector 34A, Chandigarh-160022, India. -

The Daily Egyptian, October 19, 1978
Southern Illinois University Carbondale OpenSIUC October 1978 Daily Egyptian 1978 10-19-1978 The aiD ly Egyptian, October 19, 1978 Daily Egyptian Staff Follow this and additional works at: http://opensiuc.lib.siu.edu/de_October1978 Volume 60, Issue 44 Recommended Citation , . "The aiD ly Egyptian, October 19, 1978." (Oct 1978). This Article is brought to you for free and open access by the Daily Egyptian 1978 at OpenSIUC. It has been accepted for inclusion in October 1978 by an authorized administrator of OpenSIUC. For more information, please contact [email protected]. Circuit judge lets tax-lid proposition remain on ballot By Bob Sprin.~er A..sodaled PrPSII Writer SPRI;~GFIELD lAP) - A Circuit Court judge Wednesday allowed Gov. James R Thompson's battle-scarred tax lid proposition to remain ...-: the Nov. 7 ballot. apparently ending a ~a1 batik but reheating a months-illd political ~AJe. Judge Simon L. Friedman of Sangamon Cl'Unty ruled the prop«lSition was given II "fair and imr-artial hearing" by statl' elections officials, who certified it Stopt. 8 for lhe ballot. }o'riedman's ruling came on a suit filed by Rfop. David 1.. Roblllson, Do. Springfield. who sought to knock the proposition off the ballO(. Rutlmson said he would not appeal the ruling to L'le Illinois Supreme Court .•n part, because 01 the expense involved. I"rlt'dman's decision thus endf'd. apparr-ntly for good, weeks of legal maneuvering over the proposition, which is considered a key element of Rf'publican Thompson's re-election campaIgn. But the ruling set off a new round of politIcal charges and counler-<-harges involving the proposItion. -

The Future of Islamic Extremism in Pakistan
Volume 11, No. 2 2021 ISSN 2162-6421 (online) Summer 2021 EDITORIAL STAFF From the Editor ELIZABETH SKINNER Editor When most human beings perceive a threat, the natural reaction is to lash out with ELIZABETH ROBINSON Copy Editor whatever power is available to stop and, preferably, destroy the threat. In simplistic SALLY BAHO Copy Editor Darwinian terms, whoever is most successful at eliminating threats is the one most likely to spread its DNA into the next generation. And it is said that procreation is the primary motivator for life on earth, for all of us, from bacteria to humans. EDITORIAL REVIEW BOARD However, in a world as complex as the one we’ve developed for ourselves, the VICTOR ASAL meaning of “survival” has become increasingly complicated and ever more nu- University at Albany, SUNY anced. At eight billion and counting, our species is in no danger of dying out—that CHRISTOPHER C. HARMON is, unless we engineer our own demise, which we seem intent on doing. So why Marine Corps University does it seem like we’re still all fighting for survival all of the time? The evolutionary psychologist Robert Wright has suggested that some of the basic psychological-bio- TROELS HENNINGSEN logical imperatives that enabled our ancient forebears, such as aggression, desire for Royal Danish Defence College status and the accumulation of wealth, dread of losing status, even greed for fatty and sugary foods, may be the same impulses that are now impelling our destruction. PETER MCCABE Arguably, this means that the differences between Genghis Khan and Jeff Bezos are Joint Special Operations University more cultural than they are of kind. -
![Les Codes Cambodgiens / Cochinchine Française ; [Traduits Par Mr Cordier]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9045/les-codes-cambodgiens-cochinchine-fran%C3%A7aise-traduits-par-mr-cordier-3869045.webp)
Les Codes Cambodgiens / Cochinchine Française ; [Traduits Par Mr Cordier]
Les codes cambodgiens / Cochinchine française ; [traduits par Mr Cordier] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Les codes cambodgiens / Cochinchine française ; [traduits par Mr Cordier]. 1881. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. -

The World Is a Catwalk!
T@rget 14 | Passion for fashion It’sIntercultural still leisure Target time! Intercultural Target Hawai The traditional costume for women to wear is a coconut-shell top Japan PROFESSOR and a grass skirt or a flowery In Japan the Reading dress and, of most traditional outfit Como Thatividade de pré-leie- course, a colourful is the Kimono. It means tura, os alunos identificam e falam acerca das personali- headband made “a thing to wear”. It is dades das fotografias. Em of flowers. always combined with princípio, os alunos devem manifestar-se de forma wooden shoes. muito ativa relativamente C a algumaswo personalidades.rld B Este facto pode ser aprovei- Arab world tado para o professor siste- matizar melhor os gostos Women use a Hijab, dos alunos, que já foram a veil that covers the head enunciados anteriormente. is a and chest, and an Abaya, a long O professor explica que os cloak. In some Arabic countries textos que os alunos vão ler são posts que os seis adoles- women wear a Burqa, a type centes colocara no mural da of veil that covers all the body, rede social, agradecendo por terem sido adicionados à lis- even the eyes. ta de amigos/conhecidos.catwalk! Men use a Thawb, a long tunic, and a Kufiyawith a round black D piece of cloth called the Agaal, ÁudioRead – Track the 3 following to find to keep the Kufiya in place out more about traditional Israel on the head. Orthodox Jew F Animaçãocostumes all over the women can’t wear world. trousers. They can only wear skirts or dresses falling below the knees and in dark colours. -

Brownsville Female College. Sontbern Baptist
16 BAPTIST AlTD KBFIiECTOB, SEPT. 13,1900. TO SUFFERERS OF INDICES —Tbe month has gone. The first Attention, Brethren. the laud of the " Boxers," viz: a twiu TION AND DYSPEPSIA. Sunday I went to Shady Grove. Good Idol (Uoodah), made to serve as an opi- interest. The second to Leeviile. Held Tbe Convention year will soon close um pipe; large brass-rlmmed eye Have yoa ever tried the Bboflber and a large number of churches have Bare Care for ludlgeetion and dyepep- a few days good meeting in many re- glasses In case Inscribed with Chinese spects, despite the rain and meetings not taken a contribution for this fupd. characters; a pen for writing Chinese •ta? It U gamnteed to be a purely Now, brother pastor, let me Insist that vegeUble compound. Perfectly barm- all around us. Tbe third Bunday I characters; gentleman's finger ring of epeat at Big Springs. I left Bro. Car- you mention this Important matter Jade, to be worn on thumb; and a sec- leaa In any age, atage or condition In before September Is over. Now, breth- life. It allays all InflanLOiatlon of the ney and stayed with Bio. Clark at ond-band pair of ladles' slippers. Carter's Creek in a good meeting far a ren, do not forget this. If a hundred These articles I shall Eell to relic hunt- •tomaob and bowels, bea!« tbe Irrlta- pastors who have not yet mentioned tatlons, deatroye tbeunbealtbv mucua, few days. Upon my return I found ers, and send proceeds to Bro. Tatum Bro. Carney In a good meeting, but the this cause to their churches, will call for his work in Shanghai.