Da Città Fabbrica a Meta Turistica?*1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
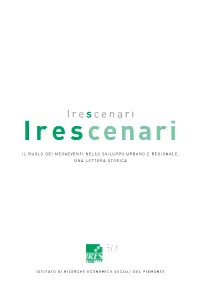
Irescenari. Il Ruolo Dei Megaeventi Nello Sviluppo Urbano E Regionale. Una Lettura Storica
I r e s c e n a r i I r e s c e n a r i IL RUOLO DEI MEGAEVENTI NELLO SVILUPPO URBANO E REGIONALE. UNA LETTURA STORICA ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE L’IRES PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d’indagine in campo socioeconomico e territoriale, fornendo un supporto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi. Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con la partecipazione di altri enti pubblici e privati, l’IRES ha visto successivamente l’adesione di tutte le Province piemontesi; dal 1991 l’Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte. L’IRES è un ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale n. 43 del 3 settembre 1991. Costituiscono oggetto dell’attività dell’Istituto: • la relazione annuale sull’andamento socioeconomico e territoriale della regione; • l’osservazione, la documentazione e l’analisi delle principali grandezze socioeconomiche e territoriali del Piemonte; • rassegne congiunturali sull’economia regionale; • ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo; • ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti e inoltre la collaborazione con la Giunta Regionale alla stesura del Documento di programmazione economico finanziaria (art. 5 l.r. n. 7/2001). CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Angelo Pichierri, Presidente Brunello Mantelli, Vicepresidente Paolo Accusani di Retorto e Portanova, Antonio Buzzigoli, Maria Luigia Gioria, -
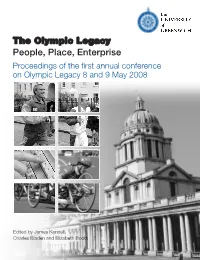
The Olympic Legacy People, Place, Enterprise Proceedings of the First Annual Conference on Olympic Legacy 8 and 9 May 2008
The Olympic Legacy People, Place, Enterprise Proceedings of the first annual conference on Olympic Legacy 8 and 9 May 2008 Edited by James Kennell, Charles Bladen and Elizabeth Booth The Olympic Legacy People, Place, Enterprise Proceedings of the first annual conference on Olympic Legacy 8 and 9 May 2008 Edited by James Kennell, Charles Bladen and Elizabeth Booth © University of Greenwich 2009 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission of the publisher. First published in 2009 by the University of Greenwich Tourism Management University of Greenwich Greenwich Campus Old Royal Naval College Greenwich London SE10 9LS United Kingdom ISBN 978-1-861-66-259-0 University of Greenwich, a charity and company limited by guarantee, registered in England (reg. no. 986729). Registered Office: Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich, London SE10 9LS Tourism Management at the University of Greenwich The study of tourism in the Business School at the University of Greenwich focuses on the management of destinations and regions and attractions. Our aim is to produce employable graduates who can go on to work in one of the UK’s major economic sectors. The university offers students the unique opportunity to study at the heart of the regeneration of East London and the 2012 Olympics, part of which will be hosted in Greenwich. We offer a BA Hons degree in Tourism Management, as well as an MA programme in International Tourism Management and supervision in postgraduate research degrees. -

10122 Torino, Italia +39 011 511 3589 / [email protected]
via Perrone 4 - 10122 Torino, Italia +39 011 511 3589 / [email protected] - www.civico13.it Progettare è un pensiero bello. CIVICO13 è uno studio di architettura fondato a Torino nel 2002. Christian Villa Alberto Daviso di Charvensod Andrea Lorenzon con Siamo cresciuti facendo architettura, allestimenti, interni Sara Ceraolo ma anche design, web design, grafica e comunicazione. Ray Coello Poi abbiamo capito che “architetti” non vuol dire tutto, Karla Palacios e che bastano 3 parole per dire chi siamo / cosa facciamo: Paola Atzori Gierdi Ahmetaga Enrico Lombardo SPECIAL Nicola Buccarano progettiamo per dare un valore speciale allo spazio Francesca Albera Michela Porta Massimo Oricchio OPEN Rossana Misuraca progettiamo l’utilizzo e il riutilizzo dello spazio nel tempo Martina Bunino Matilde Cembalaio Marina Mancini SOCIAL Michela Pellegrini progettiamo lo spazio, nel tempo, con le persone SPECIAL OPEN SOCIAL spazi commerciali IL SOGNO DEL NATALE un villaggio viaggiante per Babbo Natale 2016, Torino con TOimago, INGEMBP, Richi Ferrero Progettazione definitiva ed esecutiva di un villaggio-evento, temporaneo e itinerante, nato da un’idea di Carmelo Giammello, Paolo Quirico e Roberto Sabbi. Un percorso magico, in sei padiglioni: la galleria degli antenati, l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi, la stanza di Babbo Natale e il ricovero della slitta. 1.800mq coperti e riscaldati, 45gg di montaggio, 50 operai specializzati, 150 organizzatori, 3.000m di travi in abete, 2.200mq di scandole di legno, 80.000 viti e bulloni, -
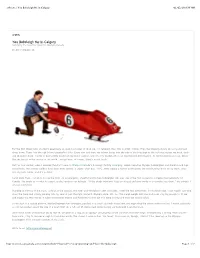
Jeff Funnekotter
enRoute | You Bobsleigh Me in Calgary 01/02/10 8:36 AM SPORTS You Bobsleigh Me in Calgary Satisfying the need for speed in Western Canada. BY JEFF FUNNEKOTTER For the first three turns on what’s essentially an open-top tunnel of thick ice, I’m relieved. Hey, this is great, I think. Then the intensity shoots up as my stomach drops down. Turns four through 14 are essentially a blur. Every now and then, my helmet bangs into the side of the bobsleigh as the velocity presses my head, neck and shoulders down. I seem to have pretty much lost my motor control, and I’m very thankful that our experienced driver hasn’t. At 120 kilometres an hour, this is like the fastest roller coaster in the world – except here, of course, there’s no set track. Half an hour earlier, when I entered the start house to WinSport Canada’s bobsleigh facility in Calgary, where Canadian Olympic bobsleighers and skeleton and luge racers train, the setting couldn’t have been more serene: a crystal-clear day, -10ºC. After signing a waiver (participants are sent hurtling down an icy track, after all), my turn comes, and it’s go time. Sarah Monk Paes – our pilot, to use the lingo – is an energetic, cheerful world-class bobsleigher who was one of the first women to compete internationally for Canada. She briefs us on what to expect as she hands us our helmets. “If the sleigh overturns, keep your head and arms inside or you might lose them,” she advises. -

Francesco Braghin · Federico Cheli Stefano Maldifassi · Stefano Melzi Edoardo Sabbioni Editors
Francesco Braghin · Federico Cheli Stefano Maldifassi · Stefano Melzi Edoardo Sabbioni Editors The Engineering Approach to Winter Sports The Engineering Approach to Winter Sports Francesco Braghin • Federico Cheli Stefano Maldifassi • Stefano Melzi Edoardo Sabbioni Editors The Engineering Approach to Winter Sports 123 Editors Francesco Braghin Federico Cheli Department of Mechanical Engineering Department of Mechanical Engineering Politecnico di Milano Politecnico di Milano Milano, Italy Milano, Italy Stefano Maldifassi Stefano Melzi AC Milan SpA Department of Mechanical Engineering Milano, Italy Politecnico di Milano Milano, Italy Edoardo Sabbioni Department of Mechanical Engineering Politecnico di Milano Milano, Italy ISBN 978-1-4939-3019-7 ISBN 978-1-4939-3020-3 (eBook) DOI 10.1007/978-1-4939-3020-3 Library of Congress Control Number: 2015950192 Springer New York Heidelberg Dordrecht London © The Editor 2016 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. -
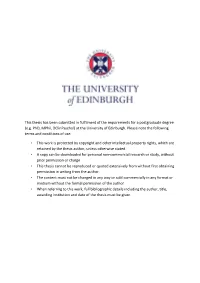
Roberts2013.Pdf (5.895Mb)
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. THE UNIVERSITY of EDINBURGH School of Engineering SKELETON BOBSLEIGH MECHANICS: ATHLETE-SLED INTERACTION Iain Roberts A thesis submitted to the University of Edinburgh For the degree of Doctor of Philosophy February 2013 DECLARATION DECLARATION I declare that this thesis has been composed by myself and is all my own work except where otherwise stated. Iain Roberts July 2012 ii ACKNOWLEDGEMENTS ACKNOWLEDGEMENTS So many have helped throughout this project and I thank you all. Firstly thank you to my supervisors, Dr Jane Blackford, Dr Tim Stratford and Dr Martin Gillie who made this project possible. Thank you also to everybody who helped with the electronics and the workshop. I have lost count of how many times I needed alterations to my sleds and you always did a great job even when I was due on a plane in a matter of hours. -
Pieghevole Cesana
5 597 n. T. R E C - 0 0 0 2 : 1 0 0 9 O S I N E I N U Come raggiungerci: Aereo Progettazione e gestione Aeroporto di Torino Caselle, 100 km D.O.C. s.c.s http: www.cooperativadoc.it Treno mail: [email protected] Stazione di Oulx, 20 km Auto Autostrada A32/E70 uscita Cesana, Claviere, Monginevro, seguire per la Strada Statale 24 del Monginevro - da Torino 80 km Organizzazione tecnica Keluar s.r.l. Cesana - Sansicario http: www.keluar.it How to reach us: mail: [email protected] Arriving by air in collaborazione con: Turin Airport, 100 km Arriving by train Oulx railway station 20 km Arriving by car http:www.torinolympicpark.org A32/E70 motorway exit Cesana, Claviere, Montgenevre, follow Sansicario direction on National Highway no. 24 - from Turin 80 km Per info e prenotazioni: Olympic Centre D.O.C. s.c.s Frazione Sansicario, 57 Via Assietta,16/b 10054 Cesana Torinese (TO) 10128 Torino (TO) Tel. +39.0122.81.19.23 - +39.0122.81.19.34 Tel. +39.011.516.20.38 fax +39.0122.81.14.89 fax + 39.011.517.54.86 http: www.olympicsansicario.it http: www.cooperativadoc.it mail: [email protected] mail: [email protected] Olympic Centre Cesana Sansicario Olympic Centre Hotel Sansicario - Cesana Nelle immediate vicinanze di Cesana, comune dell'Alta Val Susa sede delle Olympic Centre è un prestigioso albergo categoria tre stelle, con infrastrutture prestigiose Olimpiadi di Torino 2006, Sansicario si colloca al centro del grande all'avanguardia e con una spiccata attenzione ad ambiente e sostenibilità, impianto sciistico della Vialattea, moderno comprensorio che con i suoi 400 km grazie anche alla presenza di un importante impianto di pannelli fotovoltaici di piste entusiasma da sempre sciatori ed amanti della tavola, garantendo che godono di lunga esposizione al sole. -

News Dai Comprensori
INVERNO 2009-2010 PIEMONTE, UN PIENO DI OFFERTE E NOVITÀ Nuove tecnologie e risparmio per le famiglie La nuova stagione invernale sulla neve del Piemonte si apre all’insegna delle novità, promettendo ovunque, dai gradi comprensori alle piccole stazioni, un pieno di offerte, di manifestazioni, di innovazioni tecnologiche e divertimento garantito e in tutta tranquillità, grazie a nuove norme regionali che fanno del Piemonte l’area sciistica tra le più sicure d’Italia, con le sue 53 stazioni sciistiche, i 300 impianti tra cui 12 snowpark e i 1300 chilometri di piste tra i comprensori del Torinese e del Cuneese, Riserva Bianca e Mondolè, della Valsesia con Alagna, dell’Ossola con Macugnaga e del Biellese. ALAGNA VALSESIA, PARADISO DEL FREERIDE E DELL’AMBIENTE. Immersa nel Parco Naturale Alta Valsesia, area protetta più alta d’Europa ai piedi del Monte Rosa e paradiso del freeride che unisce le atmosfere di una moderna località turistica con il fascino senza tempo della cultura e delle tradizioni, inaugura la stagione con un motivo d’orgoglio in più, la Bandiera Arancione : il marchio di qualità turistico ambientale attribuito dal Touring Club Italiano alle località dell'entroterra con le caratteristiche del turismo di qualità. La stazione sciistica, inserita nella parte piemontese del Comprensorio Monterosa Ski (180 km di piste) è servito da impianti all’avanguardia, tra cui il nuovo collegamento Passo dei Salati – Indren con due telecabine da 60 posti che da 2.970 metri portano in 4 minuti e 54 secondi ai 3.275 metri del ghiacciaio viaggiando alla velocità di 10 metri al secondo con un trasporto di 740 persone all’ora. -

Torino E L'arco Alpino Piemontese
RAPPORTO FINALE Marzo 2010 Torino e l’arco alpino piemontese: prospettive di sviluppo turistico in un’ottica comparativa Ricerca finanziata dalla Fondazione CRT nell’ambito del Progetto Alfieri Indice 1. Sintesi del progetto di ricerca…………………………………………………………………………………… p.5 2. Alpi e città: inquadramento generale del tema………………………………………………………………. p.9 2.1. Le Alpi: ………………………………………..……………………………………………………………… p.9 2.2. Le città e le Alpi……………………………………………………………………………………………... p.13 2.3. Il turismo alpino…………………………………………………………………………………………….. p.19 2.4. Il punto di vista degli esperti……………………………………………………………………………… p.27 2.4.1. Le relazioni città-Alpi………………………………………………………………………………… .. p.27 2.4.2. Il turismo e i trasporti……………………………………………………………………………… p.29 3. Dinamiche turistiche di Torino e delle valli………………………………………………………………….. p.32 3.1. Torino: breve presentazione……………………………………………………………………………….. p.32 3.2. Il ruolo delle Olimpiadi………………………………………………………………………………………… p.54 3.2.1. La territorializzazione post olimpica……………………………………………………………… p.54 3.2.2. L’eredità turistica di Torino 2006: alcuni nodi problematici ed evidenze empiriche………… p.60 3.3. Il turismo dell’area montana torinese nei documenti di pianificazione territoriale e di programmazione strategica………………………………………………………………………………… p.67 3.3.1. Piano strategico Regionale per il Turismo…………………………………………………… p.70 3.3.2. VAS del Piano Strategico Regionale per il Turismo: Rapporto ambientale……………….. p.74 3.3.3. Materiali in preparazione del Piano Turistico della Provincia di Torino…………………..... p.77 3.3.4. PTI del Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone………………. p.81 3.3.5. PTI “Metromontano”……………………………………………………………………………….. p.85 3.3.6. Schema di piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione p.88 3.4. Torino e le valli: l’immagine veicolata……………………………………………………………………… p.93 3.4.1. -

Scarica Il Volume
BIBLIOTECA DI TESTI E STUDI / SOCIOLOGIA Alla memoria di Rinaldo Bontempi, uomo di grande intelligenza e sensibilità, politico gentile, capace di grandi visioni e passioni, che ha contribuito con le sue idee e il suo dinamismo alla nascita di OMERO, con il quale abbiamo intrecciato riflessioni e proposte per il futuro di Torino e dei territori olimpici Gli amici del Centro OMERO e di Torino Incontra I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore via Sardegna , Roma, telefono , fax Visitateci sul nostro sito Internet: http://www.carocci.it A Giochi fatti Le eredità di Torino A cura di Piervincenzo Bondonio, Egidio Dansero, Chito Guala, Alfredo Mela, Sergio Scamuzzi Centro OMERO, Torino Carocci editore Il volume è stato realizzato con il contributo di Torino Incontra via San Francesco da Paola, Torino tel. / a edizione, novembre © copyright by Carocci editore S.p.A., Roma Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari Finito di stampare nel novembre dalla Litografia Varo (Pisa) ISBN ---- Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. della legge aprile , n. ) Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico. Indice Prefazione di Alessandro Barberis Introduzione a cura del Centro OMERO Parte prima L’eredità immateriale: emozioni, ricordi e immagini di un evento e di un territorio a cura di Sergio Scamuzzi . Lo spettacolo e la festa: il pubblico delle Olimpiadi di Sergio Scamuzzi . Il pubblico delle gare e delle cerimonie . Emozioni in città durante i Giochi . Partecipazione e apprendimento durante e dopo i Giochi .