Vincenzo Monti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
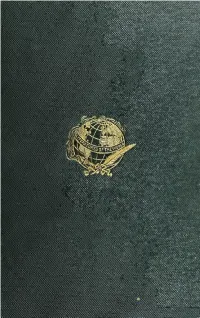
A History of Italian Literature Should Follow and Should Precede Other and Parallel Histories
I. i III 2.3 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY C U rar,y Ubrary PQ4038 G°2l"l 8t8a iterature 1lwBiiMiiiiiiiifiiliiii ! 3 1924 oim 030 978 245 Date Due M#£ (£i* The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924030978245 Short Histories of the Literatures of the World: IV. Edited by Edmund Gosse Short Histories of the Literatures of the World Edited by EDMUND GOSSE Large Crown 8vOj cloth, 6s. each Volume ANCIENT GREEK LITERATURE By Prof. Gilbert Murray, M.A. FRENCH LITERATURE By Prof. Edward Dowden, D.C.L., LL.D. MODERN ENGLISH LITERATURE By the Editor ITALIAN LITERATURE By Richard Garnett, C.B., LL.D. SPANISH LITERATURE By J. Fitzmaurice-Kelly [Shortly JAPANESE LITERATURE By William George Aston, C.M.G. [Shortly MODERN SCANDINAVIAN LITERATURE By George Brandes SANSKRIT LITERATURE By Prof. A. A. Macdonell. HUNGARIAN LITERATURE By Dr. Zoltan Beothy AMERICAN LITERATURE By Professor Moses Coit Tyler GERMAN LITERATURE By Dr. C. H. Herford LATIN LITERATURE By Dr. A. W. Verrall Other volumes will follow LONDON: WILLIAM HEINEMANN \AU rights reserved] A .History of ITALIAN LITERATURE RICHARD GARNETT, C.B., LL.D. Xon&on WILLIAM HEINEMANN MDCCCXCVIII v y. 1 1- fc V- < V ml' 1 , x.?*a»/? Printed by Ballantyne, Hanson &* Co. At the Ballantyne Press *. # / ' ri PREFACE "I think," says Jowett, writing to John Addington Symonds (August 4, 1890), "that you are happy in having unlocked so much of Italian literature, certainly the greatest in the world after Greek, Latin, English. -
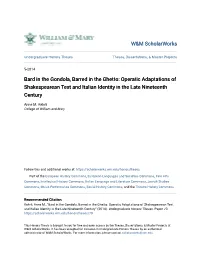
Operatic Adaptations of Shakespearean Text and Italian Identity in the Late Nineteenth Century
W&M ScholarWorks Undergraduate Honors Theses Theses, Dissertations, & Master Projects 5-2014 Bard in the Gondola, Barred in the Ghetto: Operatic Adaptations of Shakespearean Text and Italian Identity in the Late Nineteenth Century Anne M. Kehrli College of William and Mary Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/honorstheses Part of the European History Commons, European Languages and Societies Commons, Fine Arts Commons, Intellectual History Commons, Italian Language and Literature Commons, Jewish Studies Commons, Music Performance Commons, Social History Commons, and the Theatre History Commons Recommended Citation Kehrli, Anne M., "Bard in the Gondola, Barred in the Ghetto: Operatic Adaptations of Shakespearean Text and Italian Identity in the Late Nineteenth Century" (2014). Undergraduate Honors Theses. Paper 70. https://scholarworks.wm.edu/honorstheses/70 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Undergraduate Honors Theses by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Bard in the Gondola, Barred in the Ghetto: Operatic Adaptations of Shakespearean Text and Italian Identity in the Late Nineteenth Century A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Arts in Theatre from The College of William and Mary by Anne Merideth Kehrli Accepted for _____Highest Honors________________________ -

From Coppet to Milan: Romantic Circles at La Scala
From Coppet to Milan: Romantic Circles at La Scala Carmen Casaliggi Cardiff Metropolitan University When Percy Shelley left England and settled with Mary Godwin and Claire Clairmont at Maison Chapuis close to Villa Diodati in May 1816, his thoughts naturally turned to the people who were part of the coterie of European writers and artists visiting Switzerland during that Summer. As he wrote in a letter to Thomas Jefferson Hogg dated July 18, 1816: “Lord Byron, whom I have seen at this place, is about to publish a new canto of Childe Harold [...] Mad. de Stael [sic] is here & a number of literary people whom I have not seen, & indeed have no great curiosity to see” (493). Despite their strident disagreement over the merits of Byron’s entourage, Shelley’s words are suggestive of the significance of Switzerland as a centre of creativity and inspiration; it also becomes an important site to test authentic forms of sociability. John William Polidori’s diary entry for May 25, 1816 – written only few days after he arrived in Switzerland as Byron’s personal physician - retraces the footsteps of writers and philosophers interested in Swiss destinations: “It is a classic ground we go over. Buonaparte, Joseph, Bonnet, Necker, Staël, Voltaire, Rousseau, all have their villas (except Rousseau). Genthoud, Ferney, Coppet are close to the road” (96). This distinctive association of the biographical, the historical, and the geographical indicates the extent to which the Swiss experience can be seen as one of the first Romantic examples of influence and collaboration between British and European Romantic writers. -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R
The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR .... -

Cesena, Via San Benedetto 71 Italy [email protected] [email protected]
ROBERTA IOLI Liceo Vincenzo Monti, Cesena Independent researcher, University of Bologna/University of Rome Tor Vergata Address: Cesena, via San Benedetto 71 Italy [email protected] [email protected] EDUCATION _______________________________________________________________________________________ 2006 Ph.D. IN PHILOSOPHY, University of Roma Tor Vergata (XVIII ciclo). Subject: History of Ancient Philosophy: Il Peri tou mē ontos di Gorgia di Leontini: Frammenti, Testimonianze ed Echi. Supervisor: prof. Aldo Brancacci. Final mark: excellent. 2001 TEACHING QUALIFICATION in public secondary school (D.D.G. 31.3.99, D.D.G. 1.4.99, OM 1/2001): - Italian Literature, History and Geography (A043); - Italian Literature and History (A050); - History and Philosophy (A037). 1999 M.PHIL DEGREE (Master in Classics), University of Cambridge. Subject: Ancient Philosophy: Agōgē and related concepts in Sextus Empiricus. Supervisor: prof. David Sedley. Final mark: first class. 1998 FIRST DEGREE IN PHILOSOPHY (Laurea vecchio ordinamento), University of Bologna. Subject: History of Ancient Philosophy: Sextus Latinus: la fortuna di Sesto Empirico nelle traduzioni latine moderne. Supervisor: prof. Walter Cavini. Final mark: 110/110 summa cum laude. 1996 POST-GRADUATE DEGREE: PERFEZIONAMENTO IN INFORMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE UMANE (Biblioteconomia e Archivistica), University of Bologna. 1992 FIRST DEGREE IN CLASSICS (Laurea vecchio ordinamento), University of Bologna. Subject: Greek Archaeology and History of Art: “Greek myth and plastic arts: the metopes of Selinus”. Supervisor: prof. Giuseppe Sassatelli. Final mark: 110/110 summa cum laude. 1987 DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA, Liceo Classico Vincenzo Monti, Cesena. Final mark: 60/60, with honour. FELLOWSHIPS, GRANTS, AWARDS _______________________________________________________________________________________ 2002 PH.D. FELLOWSHIP, XVIII ciclo, University of Roma Tor Vergata. 1999 AHRB SCHOLARSHIP for Ph.D. -
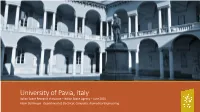
Presentazione Standard Di Powerpoint
University of Pavia, Italy Italian Space Research showcase – Italian Space Agency – June 2020 Fabio Dell’Acqua - Department of Electrical, Computer, Biomedical Engineering University of Pavia ▪ Public university, founded in year 1361 ▪ Among its rectors we may recall Alessandro Volta, the inventor of the electric battery, and Camillo Golgi, the earliest Italian Nobel laureate, for his studies on the histology of the human nerve system ▪ The town of Pavia forms a local «knowledge network» covering various scientific and also practical aspects: ▪ Institute for Advances Studies (IUSS) ▪ Polyclinic hospital «S. Matteo» ▪ Research foundations (CNAO, Maugeri, Mondino, EUCENTRE, …) ▪ Research institutes (IGM, INFM, CHT, …) ▪ Residential system, including historical «colleges of merit» founded in the XVI century ▪ Network of museums and libraries ▪ Technological incubator ITALIAN SPACE RESEARCH SHOWCASE – ITALIAN SPACE AGENCY – JUNE 2020 University of Pavia and Space ❑ Full member of the Regional Aerospace Cluster ❑ The Department of Electrical, Biomedical, Computer Engineering is a member of the Copernicus Academy ❑ Various courses explicitly address the joint ESA-EU Copernicus initiative ❑ The graduate course in Electronic Engineering features a “Space Communication and Sensing” track On 9th Nov. 2017, during celebrations for the 50° ❑ The University of Pavia will coordinate the didactic anniversary of the founding of the Faculty of activities of the Italian semester of the joint ASI-CONAE Engineering, the astronaut Samantha Cristoforetti Master -

Elogio Del Cavaliere Vincenzo Monti
E L O GIO DEI, CAVALIERE VINCENZO MONTI COMPOSTO DA CINERANCESCO RAMBELLI LUGHESE EDIZIONE SECONDA BOLOGNA TIPOGRAFIA B o R T o L o t t º x 8 5 2 . - T ( S e t 2 o M E Z . º , AL CHIARISSIMO l º e 2 . SIGNOR l t f i 4 DOMENICO VACCOLINI PROF. DI FILOSOFIA E MATEMATICA i NEL GINNASIO DI BAGNACAVALLO GIANFRANCESCO RAMBELLI - I n o n p o c h i e r r o r i tipografici c h e c o r s e r o n e l l a p r i m a e d i z i o n e d i q u e s t o E l o g i o f a t t a s i n e l f a s c . VII dell'Antologia d i p r o s e i t a l i a n e d i s c r i t t o r i v i v e n t i c h e u s c i v a i n I m o l a n e l 1 8 5 1 , m i h a n n o d e t e r m i n a t o a r i p r o d u r l o o p e r a n d o v i q u a l c h e c o r r e z i o n e e p a r e c c h i e a g g i u n t e i m p o r t a n t i s s i m e . -
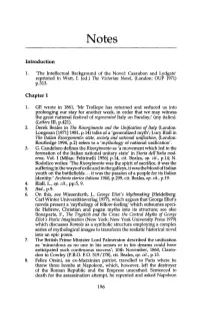
Introduction Chapter 1
Notes Introduction 1. 'The Intellectual Background of the Novel: Casaubon and Lydgate' reprinted in Watt, I. (ed.) The Victorian Novel, (London: OUP 1971) p.313. Chapter 1 1. GE wrote in 1861, 'Mr Trollope has returned and seduced us into prolonging our stay for another week, in order that we may witness the great national festival of regenerated Italy on Sunday;' (my italics). (Letters III, p.421). 2. Derek Beales in The Risorgimento and the Unification of Italy (London: Longman [1971] 1981, p.l4) talks of a 'generalized myth'; Lucy Riall in The Italian Risorgimento: state, society and national unification, (London: Routledge 1994, p.2) refers to a 'mythology of national unification'. 3. G. Candeloro defines the Risorgimento as 'a movement which led to the formation of the Italian national unitary state' in Storia deli'Italia mod erna, Vol. I (Milan: Feltrinelli 1956) p.l4, cit. Beales, op. cit., p.14; N. Rodolico writes: 'The Risorgimento was the spirit of sacrifice, it was the suffering in the ways of exile and in the galleys, it was the blood ofltalian youth on the battlefields ... it was the passion of a people for its Italian identity.' Archivio storico italiano 1960, p.299, cit. Beales, op. cit., p.19. 4. Rial!, L., op. cit., pp.S, 9. 5. Ibid., p.9. 6. On this, see Wiesenfarth, J., George Eliot's Mythmaking (Heidelberg: Carl Winter Universitii.tsverlag 1977), which argues that George Eliot's novels present a 'mythology of fellow-feeling' which subsumes speci fic Hebrew, Christian and pagan myths into its structure; see also Bonaparte, F., The Tryptich and the Cross: the Central Myths of George Eliot's Poetic Imagination (New York: New York University Press 1979) which discusses Romola as a symbolic structure employing a complex series of mythological images to transform the realistic historical novel into an epic poem. -

The Songs of Luigi Gordigiani (1806-1860), "Lo Schuberto Italiano" Thomas M
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2007 The Songs of Luigi Gordigiani (1806-1860), "Lo Schuberto Italiano" Thomas M. Cimarusti Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC THE SONGS OF LUIGI GORDIGIANI (1806-1860), “LO SCHUBERTO ITALIANO” By THOMAS M. CIMARUSTI A Dissertation submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Summer Semester, 2007 Copyright © 2007 Thomas M. Cimarusti All Rights Reserved The members of the Committee approve the dissertation of Thomas M. Cimarusti defended on 28 June 2007. Douglass Seaton Professor Directing Dissertation Valerie Trujillo Outside Committee Member Charles E. Brewer Committee Member Jeffery Kite -Powell Committee Member William Leparulo Committee Member Approved: Seth Beckman, Chair, College of Music Don Gibson, Dean, College of Music The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii To my parents iii ACKNOWLEDGMENTS The completion of this dissertation involved the help of many individuals. I am most grateful to my advisor Dr. Douglass Seaton, whose encouragement, patience, and inspiration have been invaluable. I am profoundly indebted to him. My deepest thanks to my committee members Drs. Charles Brewer, Jeffery Kite-Powell, and William Leparulo for their comments and suggestions regarding initial drafts. My sincere appreciation to Dr. Valerie Trujillo who, due to unforseen circumstances, stepped in to serve on the committee just prior to my defense. I am also thankful for Italian scholar Dr. -
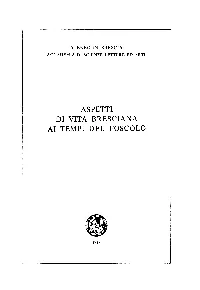
Aspetti Di Vita Bresciana Ai Tempi Del Foscolo
ATENE0 DI BRESCIA ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI ASPETTI DI VITA BRESCIANA AI TEMPI DEL FOSCOLO ATENE0 DI BRESCIA ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI ASPETTI DI VITA BRESCIANA AI TEMPI DEL FOSCOLO BRESCIA 1978 Pubblicazione realizzata con contributo finanziario della Regione L orn bardia Supplemento ai COMMENTAR1 DELL'ATENEO DI BRESCIA - per l'anno 1978 Autorizzazione del Tribunale di Brescia N. 64 in data 21 gennaio 1953 Direttore responsabile UGO VAGLIA TIPO-LITO FRATELLI GEROLDI - BRESCIA 1978 Soltanto per dire agli autori degli studi in questo volume raccolti - illustri e benemeriti soci dell'Ateneo - il mio vivo ringraziamento ed espressiorz i di sincera ainrnirazione. Fu quasi incidentalmente, in una lontana riunione presso l'Ate- neo, alle viste orinai la scadenza della mia non più rinnovabile presi- denza, che, accennando alle celebrazioni nazionali per il secondo cente- nario della nascita di Nicolò Ugo Foscolo, avanzai, assai vagamente e timidamente, più che una proposta, la auspicabile prospettiva che l'A teneo, per proprio conto, illustrasse alcuni ''aspetti" dei rapporti molteplici che il poeta soldato ebbe con l'ambiente bresciano del tem- po- Ma non avrei mai immaginato che tale timido e sprovveduto desi- derio venisse non soltanto raccolto con pronta cordialità, ma venisse puntualmente, abbondantemente ed egregiameizte realizzato. Ritengo, infatti, che quanti leggeranno le pagine che seguono, ver- ranno, con piacevole sorpresa, a conoscenza di aspetti (o come si usa oggi dire "risvolti") del Foscolo, poco, o male, conosciuti; e che, nel volume, sono esposti in pregevolissima forma; e con esemplare scrupo- lo di documentazione e di obiettività. Personalmente: a lettura terminata, mi è venuto spontaneo rifarmi alla autorevole affermazione del compianto prestigioso e ammirato cri- tico, socio dell'tlteneo, pro5 Mario Apollonio: la affermazione che: ((.. -

Academic Medicine in Pavia
HISTORY NOTES Giuseppe Specchia University of Pavia, Italy Academic medicine in Pavia whose rebellion against Rome deposed Romolo Augus- tolo and decreed the end of the Western Roman Empire. Odoacre was succeeded by Theodoric the Great King of the Goths, who in turn was recognized by the Eastern Empire as King of Italy. In 572 Pavia was conquered by the Lombards and became the effective capital and one of the most important cities of the king- dom with the name of Papia. The adhesion of Lombard sovereignty to Christianity gave rise to intense devel- opment of ecclesiastical construction, with the creation both of churches (frequently the seat of royal burials) and of monasteries whose wealth enabled immense development in agriculture and commerce. The sub- stantial economic growth of Pavia, the eminence gained by Pavia on account of its royal seat, the achieved independence of its episcopal see from that of Milano, fuelled the rivalry between the two Lombard cities, both destined to explode in bloody disputes. Figure 1. Portrait of the author, source: author’s archival When Charles King of the Franks, succeeded in materials Pepin “the short”, repudiated Ermengarda daughter of the Longobard King Desiderio, the Franco–Lombard relations began and rapidly deteriorated. In addition, The history of Pavia the highly Francophile and anti–Lombard Pope Adri- an, for the refusal of Desiderio to return the invaded Pavia is a city of 73 000 inhabitants, located in territories to the Papal state, asked the French for help Lombardy, 34 kilometres south of Milano, on the left on account of Desiderio's refusal to return the invaded bank of the Ticino river; originating from lake Maggiore, territories to Papal State. -

Don Antonio Garavini
FAUSTA GARAVINI Un amico di Carlo Piancastelli in fedeltà montiana: Don Antonio Garavini Incline ad appassionarsi ad ogni vicenda culturale e umana, Pier - giorgio Brigliadori si era chinato anche, non solo per fedeltà pian - castelliana, sulle ingiallite carte di Don Antonio Garavini: ne ave - va dedotto da par suo la qualità e la singolarità del personaggio e l’aveva delineata in perspicue parole. Ma le parole di Piergiorgio, refrattarie come molte altre volte a raggelarsi in scrittura, si sono volatilizzate. Rimangono, dimidiate, le mie, a testimonianza di una caparbia ricerca a quattro mani, occasionata dalla mia dona - zione al Fondo Piancastelli dei libri di Don Antonio, che per ini - ziativa di Piergiorgio sono stati inventariati. * * * Se Don Antonio Garavini, conosciuto e stimato come esper - to di studi montiani, può essere definito un prete ribelle o co - munque bislacco e battagliero, non è certo per una sua eventua - le indisciplina, di cui non esistono assolutamente testimonianze, nei confronti di Santa Romana Chiesa di cui fu ministro. È vero però che il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa, come della comunità culturale del suo tempo, fu costantemente libero, indipendente, spesso controcorrente. E ci si potrebbe magari in - terrogare sulla sua vocazione religiosa: infatti, stando alla leggen - da familiare, lacunosa ma abbastanza parlante, il suo ingresso in seminario fu piuttosto dovuto, come spesso accadeva, alla sua vo - 318 Fausta Garavini cazione letteraria, ossia all’opportunità, per i genitori, di avviare agli studi un ragazzo che dimostrava doti non comuni. Antonio, nato ad Alfonsine il 25 agosto del 1845 (quindi sud - dito del papa), fratello maggiore del mio nonno paterno, mo - strava infatti fin da piccolo una grande inclinazione alle lettere.