La Paura Degli Aristocratici Nell'impero Romano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Juifs De Libye Entre Israël Et L’Italie, De 1948 À Nos Jours
Scuola Dottorale di Ateneo École des Hautes Études Graduate School en Sciences Sociales Dottorato di ricerca in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea - Ciclo 27 Doctorat de recherche en Anthropologie Sociale et Historique Mémoires de diaspora, diaspora de mémoires. Juifs de Libye entre Israël et l’Italie, de 1948 à nos jours Tesi di Dottorato di Piera Rossetto matricola 825522 Coordinatore del Dottorato Ch.mo Prof. Federico Squarcini Tutore del Dottorando Ch.ma Prof.ssa Emanuela Trevisan Semi Co-tutore del Dottorando Ch.ma Prof.ssa Chantal Bordes-Benayoun SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: LOR/08 DISCIPLINE: ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET HISTORIQUE Anno di discussione 2015 Alle mie nonne, Bruna e Livia, che con forza d’animo, intelligenza e dignità hanno attraversato la loro vita, quasi un secolo di storia... Dédié à mes grand-mères, Bruna et Livia, avec courage, intelligence et dignité elles ont traversé leur vie, presque un siècle d’histoire… Ringraziamenti Questo lavoro di ricerca non sarebbe stato possibile senza i suoi veri protagonisti : gli ebrei di Libia, o meglio, i tripolini e le tripoline, i bengasini e le bengasine, che con grande senso di ospitalità mi hanno accolto nelle loro case e hanno condiviso con me i loro ricordi e i loro percorsi di vita. Agli “intervistati” va tutta la mia gratitudine per aver accettato di “tirar fuori dal cassetto” insieme agli album di famiglia anche le memorie di momenti belli e meno belli passati su un’altra riva del Mediterraneo, diventata da lungo tempo sponda inaccessibile per loro. Spetta tuttavia solo a me la responsabilità di aver interpretato le loro parole in un senso diverso da quello originariamente inteso, se questo è avvenuto. -
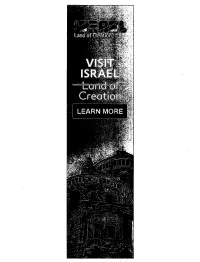
Informational Materials
' . :·· ~._ .~- ' . ~ .. ~ }, : .. • . ~ .... '-. .... .. ·.. · .· ·.. ·v·,:.···1·.r·;··1·,T ... ·... i'·• . ··1-s•i.11<" 'A~. :>::E· \~.·L· .· . ~ ~ ' ' . ::-·~J . -. ,'• -· ,' ,". <-•- • ·,,_... _-_ '. ~._ ,,, L.~:ARN MORE ------ ------- . •·· Received tiyJ,/SD/F ARA Registration Unit I 2/.21/2018 7:01 :00 PM . ! 1· I · '- .. -: , . .,,.,.{ ,,., ' .. \ .:" ·t·/. '.~ · l®J 01.~ ·@if (C GR~©~-O©>IT1 · ' . v. ·v·.. .·1··,s.···;;1··T·· :·.: -- .·1·eJlf·A,'&•-::::•·~n .-- ...L.. L~d ~,,;~;;~it:~ -------- L..E:ARN MORE: ( '--~,------,-,,------.-· , Received by NSD/FARA Registration Unit 12/21/2018 7:01 :00 PM Church HELPING LEADERS BECOME BETTER STEWARDS. Faith-Based Travel: 11::!AiL Land of Creation Received by NSD/FARA Registration Unit 12/21/2018 7:01:00 PM ('. ,-. ,· Table of Contents . ' -.,, ....: ..' ...- . ., . ' . .... : -· ., . - -- ' . .. ,. - - -- . ,-, ' '--- _, ·.-,, . .,.. , .TH~l~A~L~l'ERIENCE:' ,_4 CLOSER. ',•' --- ·- THAN'YOUTHINK. -, ·- For p_astors and church grouRs, [srael is where •.· the Bible'- andfellqwship.-trulycomjci,alille. _ 'lh tiles~ f~~pect~.1t;; ~ppe~IJs,16~\l'hel~ a.rid.; <.. Widely kFlbwn. ' .. , ·- . - ,. · .. ••••••~H ~ HOOOOOOOO •••••.• OO~H ~ oooC 000•0 • •. >-: ...... H••••~·•, ~ 00 • •• ' ISRAEL:THE PLANNING ·,·PROCESS. -~ . 6 . ·1f you want to ehs\Jr~ ;oGrisr,i'~l•trip i~ as transformative as its,an.be_(and sci often is). it' .pays to plan welL/i -- -- '"-,, · · - . ,.......,..., . (. ;·· ,·-_-., --,.. ·. -. ' . ' . .·l<~. theseJOt7d'and,true ,arl, trips inJ"fliFld. .... · IN GOOD FilTH-AJVfJ . - -

Type 2 Diabetes Among Circassians in Israel
Original Articles Type 2 Diabetes among Circassians in Israel Yafa Haron PhD1,2, Osama Hussein MD3, Leon Epstein MD PhD4, Danny Eilat MD5, Bakky Harash MD5 and Shai Linn MD PhD2,6 1 Unit for Quality Assurance, Western Galilee Hospital, Nahariya, Israel 2 Affiliated to Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel 3 Department of Medicine, Sieff Medical Center, Safed, Israel 4 Hadassah University Hospital and Braun School of Public Health, Hebrew University, Jerusalem, Israel 5 Clalit Health Services, Northern District, Israel 6 Epidemiology Unit, Rambam Medical Center, Haifa, Israel Key words: Circassians, type 2 diabetes, ethnology, epidemiology, risk factors Abstract the data in these studies had been derived from the general Background: The Muslim Circassians in Israel represent white population and from non-white ethnic groups [5]. a unique ethnic community, distinct from Jews and Arabs. This The Adyge people, commonly known as Circassians, are endogamous group has a limited genetic variability that allows the oldest indigenous people of the North Caucasus region of studying risk factors associated with type 2 diabetes. Eastern Europe [6]. Under military pressure, a mass exodus of Objectives: To estimate the prevalence of type 2 diabetes among Israeli Circassians and its correlation to obesity and genetic Circassians to Turkey and other parts of the Ottoman Empire, susceptibility. including the Middle East, occurred between 1825 and 1864 [7], Methods: Israeli Circassian women (n=450) and men (n=289) and Circassians settled in Ottoman-occupied Palestine in the older than 35 were included in the study. They were classified as late 19th century. -

Landespokal Qualifikationsphase 2012-2013
Landespokal Qualifikationsphase 2012-2013 6. Qualifikationsrunde 12.11.2012 12:45 Hapoel Beit Shean - Hapoel Herzliya 2:3 Beit Shean 13.11.2012 13:30 Hapoel Asi Gilboa - Hapoel Migdal haEmek 3:0 Gush Ya’el 16.11.2012 12:30 Hapoel Azur - SC Shikun haMizrah 5:0 Azur 16.11.2012 12:30 Beitar Yafo - Ironi Kiryat Gat 1:3 Noah Golan 16.11.2012 12:30 Hapoel Afula - SC Hazor 12:0 Green 16.11.2012 12:30 Beitar Nahariya - SC Pardes Hana Karkur 2:0 Pekiin 16.11.2012 13:00 Orthodoksim Lod - Ironi Bat Yam 2:1 Beit haAlmin 16.11.2012 13:30 SC Tira - Shimshon Bnei Taibe 3:5 Tira 16.11.2012 13:30 SC Givat Olga - Akhva Umm al-Fahm 0:1 Givat Olga 16.11.2012 13:30 Hapoel Sandala Gilboa - Sektzia Maalot Tarshiha 1:3 Daburiya 17.11.2012 13:30 Hapoel Daliyat al-Karmel - FC Bir al-Maksur 2:1 Isfiya 26.11.2012 13:00 Maccabi Beer Yaakov - Beitar Kfar Saba 3:4 Beer Yaakov 27.11.2012 15:00 Hapoel Kfar Shalem - SC Bnei Yafo 3:5 Shkunat Hatikva 11.12.2012 13:30 Hapoel Katamon Jerusalem - Maccabi Ironi Sderot 4:0 Kiryat Gat Freilose: Maccabi Kabilio Yafo, SC Karmiel Zefat 5. Qualifikationsrunde (Liga Alef Nord) 21.09.2012 13:00 Hapoel Hadera - Sektzia Maalot Tarshiha 1:3 Givat Olga 21.09.2012 14:00 Maccabi Kfar Kana - Hapoel Herzliya 1:3 Azmi Nassar 21.09.2012 14:00 Hapoel Afula - Ironi Tiberias 1:0 Afula Illit 21.09.2012 14:00 Maccabi Daliyat al-Karmel - SC Karmiel Zefat 2:3 Daliyat al-Karmel 21.09.2012 14:00 Hapoel Asi Gilboa - Maccabi Ironi Kiryat Ata 4:0 Gush Ya‘el 21.09.2012 14:00 Maccabi Zur Shalom - Hapoel Migdal haEmek 2:3 Zur Shalom 22.09.2012 14:30 Hapoel Daliyat al-Karmel - Hapoel Kfar Kana 3:1 Daliyat al-Karmel 24.09.2012 15:00 FC Akhva Araba - SC Givat Olga 0:1 Doha 5. -

Restoration and Reconstruction of the Circassian Village Kfar-Kama
FIG2009 Restoration and reconstruction of the Circassian village Kfar-Kama Orit SHWARTS, Israel 1 “The Production of Space”, Henri Lefebvre “Space is a social product, with physical and economic attributes”. The Place is an intersection between physical, mental and social aspects of space, made by historical moves. Every society - and therefore every mode of production - produces its own space. 2 The Same Place at the Same Time… Different Knowledge The residents The percepted space The society The planners The lived space The pronounced space The relation between those spaces, create the meeting between the individual experience of space and the 3 structural forces. Discussion Points Planning activities that guided the restoration and preservation of the core of the village, Kfar Kama, and the way in which these activities impacted social processes in the village. External processes that compete with the architectural preservation of the "authentic" village core. The inner conflict of the Circassian people, between the desire to preserve their tradition, and life in the reality of the open and permissive Israeli society. The various perceptions and social constructions of the village core articulated by the planners and the residents. 4 The Circassian Community in Israel The Circassian are people of the northwest Caucasus region. They are Sunni Muslims, but not Arabs in their nationality. Circassians began arriving in the Levant in the 1860s and 1870s through resettlement by the Ottoman Empire. The Circassian, came to Israel as refugees in 1878. 5 The Circassian Community in Israel Even today, various communities of Caucasian origin living in the Middle East, notably Jordan, Syria, Israel and Damascus. -
Annual Report of Activities 2009
Adalah 3ب+¨Æ®≥"¨µª¨π≠∂π π®© ,∞µ∂π∞ª¿1∞Æت∫∞µ(∫π®¨≥ µµº®≥1¨∑∂πª∂≠ ™ª∞Ω∞ª∞¨∫ 2009 (∫∫º¨´%¨©πº®π¿ 1 Introduction This report highlights Adalah’s main achievements and impact, as well as our key activities conducted in 2009, our thirteenth year of operation. As this report reflects, Adalah achieved several successes on our legal representations and international advocacy initiatives, and submitted major new impact litigation cases of crucial importance in promoting and defending the rights of Palestinian citizens of Israel and Palestinian residents of the Occupied Palestinian Territory (OPT). Adalah also issued new legal publications and delivered papers at numerous conferences and symposium, by invitation, both in Israel and abroad. Adalah (“Justice” in Arabic) is an independent human rights organization and legal center with offices in Haifa in the north and Beer el-Sabe (Beer Sheva) in the south. Established in November 1996, Adalah serves Palestinian citizens of Israel, numbering 1.2 million people or close to 20% of the population and Palestinians living in the OPT. Adalah’s main objectives are to achieve equal individual and collective rights for the Palestinian Arab minority in Israel in different fields including land and planning rights; civil and political rights; economic, social and cultural rights; religious rights; women’s rights; and prisoners’ rights, and to defend the rights of Palestinians living under occupation. In order to achieve these goals, Adalah: • Brings impact litigation cases before Israeli courts and various state authorities; • Provides legal consultation to individuals, NGOs, and Arab institutions; • Appeals to international institutions and forums; • Organizes conferences and study days and publishes reports on legal issues; • Conducts extensive media outreach; • Trains legal apprentices, law students, and new lawyers in the field of human rights. -
The Social Adjustment of Girls Circassian Students in State Elementary Schools
Open Journal of Social Sciences, 2018, 6, 230-245 http://www.scirp.org/journal/jss ISSN Online: 2327-5960 ISSN Print: 2327-5952 The Social Adjustment of Girls Circassian Students in State Elementary Schools Yosy Maman1, Janan Faraj Falah2, Elana Napso2 1Ohalo College, Katzreen, Israel 2The Arab College for Education, Haifa, Israel How to cite this paper: Maman, Y., Falah, Abstract J.F. and Napso, E. (2018) The Social Ad- justment of Girls Circassian Students in The Circassians are Sunni Muslims, originated in the Caucasus, a part of the State Elementary Schools. Open Journal of former Soviet Union. During the rule of the Ottoman Sultan Abd al-Hamid II Social Sciences, 6, 230-245. in the 1860s, many Circassians joined the Ottoman Army; some of them were https://doi.org/10.4236/jss.2018.61017 settled in Israel and worked as farmers or as the maintainers of the Hejaz rail- Received: December 19, 2017 way’s route from attacks of Bedouin tribes (Shabsu, 1993) [1]. Since 1948, Cir- Accepted: January 27, 2018 cassian men had begun serving in the Israel Defense Forces on the order of their Published: January 30, 2018 leaders. The Circassians live in two villages in the Galilee area, in the Village of Copyright © 2018 by authors and Kama and in Rihania. These two villages have elementary schools, in which, Scientific Research Publishing Inc. most of the teachers are Circassians. They belong to the Druze Education De- This work is licensed under the Creative partment that is separated from the regular Israeli educational system. At the Commons Attribution International end of the elementary school phase, the Circassian pupils go to Jewish schools. -
The Circassians of Israel: Maintaining an Exilic Culture in the Zionist Homeland
Kedma: Penn's Journal on Jewish Thought, Jewish Culture, and Israel Volume 2 Number 5 Spring & Summer 2020 Article 5 2020 The Circassians of Israel: Maintaining an Exilic Culture in the Zionist Homeland Nitin Rao University of Pennsylvania Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/kedma Part of the Jewish Studies Commons, Near and Middle Eastern Studies Commons, and the Religion Commons This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/kedma/vol2/iss5/5 For more information, please contact [email protected]. The Circassians of Israel: Maintaining an Exilic Culture in the Zionist Homeland Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License This article is available in Kedma: Penn's Journal on Jewish Thought, Jewish Culture, and Israel: https://repository.upenn.edu/kedma/vol2/iss5/5 The Circassians of Israel: Maintaining an Exilic Culture in the Zionist Homeland Nitin Rao In July of 2019, protests broke out in the Israeli village of Kfar Kama, in the Lower Galilee, over the anticipated settlement of a non-Circassian couple in the municipality.1 The Circassians are an ethnic group of historic origins in the Caucasus mountains some of whose forebears arrived in modern-day Israel as refugees amid violent disruptions caused by the expansion of the Russian Empire into their ancestral lands during the mid-nineteenth century. In 2019, the Circassians of Kfar Kama protested the introduction of non-Circassians into their homogeneous community as the beginning of a cultural erosion that could erase their generations-long efforts to maintain their identity despite their displacement. -

DIBATTITI STORICAMENTE.ORG Laboratorio Di Storia
St�rica L A B O R A T O R I O D I S T O R I A ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna Dipartimento di Storia Culture Civiltà DIBATTITI STORICAMENTE.ORG Laboratorio di Storia Lorenzo Kamel Identities and Migrations: a Borderless Middle East’s Perspec- tive Numero 11 - 2015 ISSN: 1825-411X Art. 8 pp. 1-16 DOI: 10.12977/stor595 Editore: BraDypUS Data di pubblicazione: 7/7/2015 Licenza: CC BY-NC-ND 4.0 International Sezione: Dibattiti Identities and Migrations: a Borderless Middle East’s Perspective LORENZO KAMEL Univ. Bologna, Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà New sources have been recently released fostering the thesis according to which a significant percentage of the Palestinian Arabs were originally immigrants from Egypt and other nei- ghbouring countries. Their histories, as highlighted by some scholars, are largely unknown and continue to be ignored. This article aims to shed light on these aspects, assessing them from a borderless Middle East’s perspective. The aim is to show the process through which a local complex reality has been simplified and denied in its continuity. Introduction In a recent academic article published by the Jerusalem Center for Public Affairs, professor Gideon M. Kressel (Ben-Gurion University) and the late Middle East historian Reuven Aharoni (Haifa University) argued «that a significant portion of the Palestinian Arabs came from Egypt» and that the histories of «immigrants who have arrived in Palestine from its neighboring Middle Eastern lands are largely stored in families’ me- morials», or mentioned in documents that «have been left to yellow in unexamined archives» (Kressel, Aharoni 2013, 36). -

Download the Full Report
ISRAEL: A SOCIAL REPORT 2012 Dr. Shlomo Swirski | Etty Konor Attias ||| December 2012 2 Israel: A Social Report 2012 مركزأدفا Board of Directors Dr. Yossi Dahan, Chair This report was made possible Gilbert Finkel (M.A.), Treasurer by generous grants from: Professor Ismail Abu-Saad Ford Israel Foundation Dr. Nitza Berkovitch MAZON: A Jewish Response to Hunger Professor Dani Filc Professor Rachel Kallus Professor Hubert Law-Yone Professor Uri Ram The Adva Center is supported by the following: Dr. Yitzhak Saporta Jacob & Hilda Blaustein Foundation Professor Rivka Savaiya Heinrich Boell Foundation Professor Oren Yiftachel CORDAID Professor Yossi Yona European Union Friedrich Ebert Stiftung Audit Committee FordIsrael Fund Attorney Ovadia Golestany Ms. Ruti Gur Hadassah Foundation Mr. Howard Horowitz and Ms. Alisse Waterston Staff Members Jewish Women’s Foundation of New York Barbara Swirski, Executive Director MAZON: A Jewish Response to Hunger Shlomo Swirski, Academic Director National Council of Jewish Women Etty Konor-Attias, Research Coordinator New Israel Fund Adi Sofer, Economist Rosa Luxemburg Foundation Safa Agbaria, Economist Zabar Family Attorney Noga Dagan-Buzaglo, Researcher Yael Hasson, Researcher and Coordinator, Women’s Budget Forum Valeria Seigelshifer, Advocacy Director Shira Pinhas, Community Social Worker Ariane Ofir, Statistician Yaron Dishon, Outreach Coordinator Mira Oppenheim, Office Manager and Press Liaison 3 INTRODUCTION This annual update of the Social Report appears at the height of the Israeli election season, held early because of government fears that it would not be able to mobilize a majority to pass a budget bill that called for harsh cuts in the social services. Election campaigns tend to highlight the issues that capture media headlines. -

Reports Submitted by States Parties Under Article 9 of the Convention
United Nations CERD/C/ISR/14-16 International Convention on Distr.: General 17 January 2011 the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Original: English Committee on the Elimination of Racial Discrimination Reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Fourteenth to sixteenth periodic reports of States parties due in 2010* Israel** * This document contains the fourteenth, fifteenth and sixteenth periodic reports of Israel, due on 2 February 2006, 2008 and 2010 respectively, submitted in one document. For the tenth to thirteenth periodic reports and the summary records of the meetings at which the Committee considered the report, see document CERD/C/471/Add.2, CERD/C/SR.1794, 1795, 1810 and 1813. ** In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document was not formally edited before being sent to the United Nations translation services. GE.11-40249 (E) 310111 CERD/C/ISR/14-16 Contents Paragraphs Page Introduction........................................................................................................................ 1–25 3 I. Article 2.................................................................................................................. 26–164 7 A. Measures to eliminate racial discrimination ................................................... 26–91 7 B. Social, economic and cultural measures to ensure development and protection of racial groups............................................................................. -

Ethnic Minority Languages in Israel
ETHNIC MINORITY LANGUAGES IN ISRAEL Asher Shafrir Tel Aviv University The non-Jewish minorities make up nearly 25% of the population of Israel. Among them are 4 groups differentiated in various ways from the general Arab Israeli population. The Bedouin are differentiated by their traditional residence patterns, the Druzes by religion, the Circassians by religion and ethnicity. The Greek Orthodox Church brings Greek-speaking priests to Israel, who teaches the language in their church schools. There are Arab Christian families with knowledge of Greek. There are speakers of Aramaic (Syriac), but most members of the Syriac community now speak Arabic. For the rest of the Churches, such as the Coptic and Ethiopians, the speakers are generally clerics. The exception to this is the small but significant Armenian community. The Armenians, like the Circassians, are working effectively for maintenance of their own language. In this paper we will look at language issues that affect these groups. Ethnicity, religion, minority, Aramaic, Druze, Circassian, Arab, Christians Some 1.8 million people, comprising Christian Arabs, some 150,000, live some 24 percent of Israel's population, are mainly in urban areas. Although many non-Jews. Although defined collectively as denominations are nominally represented, the Arab citizens of Israel, they include a number majority are affiliated with the Greek of different, primarily Arabic-speaking Catholic, Greek Orthodox and Roman groups, each with distinct characteristics. Catholic churches Religion Total Grand Jews Moslems s Christian Druze Other Muslim Arabs, over 1.2 million people, reside mainly in small towns and villages, over half of them in the north of the country.