Università Degli Studi Di Salerno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Luxury Board Games for the Northern Greek Elite Despina Ignatiadou
Luxury Board Games for the Northern Greek Elite Despina Ignatiadou To cite this version: Despina Ignatiadou. Luxury Board Games for the Northern Greek Elite. Archimède : archéologie et histoire ancienne, UMR7044 - Archimède, 2019, pp.144-159. halshs-02927454 HAL Id: halshs-02927454 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02927454 Submitted on 1 Sep 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. N°6 ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE ANCIENNE 2019 1 DOSSIER THÉMATIQUE : HISTOIRES DE FIGURES CONSTRUITES : LES FONDATEURS DE RELIGION DOSSIER THÉMATIQUE : JOUER DANS L’ANTIQUITÉ : IDENTITÉ ET MULTICULTURALITÉ GAMES AND PLAY IN ANTIQUITY: IDENTITY AND MULTICULTURALITY 71 Véronique DASEN et Ulrich SCHÄDLER Introduction EGYPTE 75 Anne DUNN-VATURI Aux sources du « jeu du chien et du chacal » 89 Alex DE VOOGT Traces of Appropriation: Roman Board Games in Egypt and Sudan 100 Thierry DEPAULIS Dés coptes ? Dés indiens ? MONDE GREC 113 Richard. H.J. ASHTON Astragaloi on Greek Coins of Asia Minor 127 Véronique DASEN Saltimbanques et circulation de jeux 144 Despina IGNATIADOU Luxury Board Games for the Northern Greek Elite 160 Ulrich SCHÄDLER Greeks, Etruscans, and Celts at play MONDE ROMAIN 175 Rudolf HAENSCH Spiele und Spielen im römischen Ägypten: Die Zeugnisse der verschiedenen Quellenarten 186 Yves MANNIEZ Jouer dans l’au-delà ? Le mobilier ludique des sépultures de Gaule méridionale et de Corse (Ve siècle av. -

Royal Power, Law and Justice in Ancient Macedonia Joseph Roisman
Royal Power, Law and Justice in Ancient Macedonia Joseph Roisman In his speech On the Crown Demosthenes often lionizes himself by suggesting that his actions and policy required him to overcome insurmountable obstacles. Thus he contrasts Athens’ weakness around 346 B.C.E. with Macedonia’s strength, and Philip’s II unlimited power with the more constrained and cumbersome decision-making process at home, before asserting that in spite of these difficulties he succeeded in forging later a large Greek coalition to confront Philip in the battle of Chaeronea (Dem.18.234–37). [F]irst, he (Philip) ruled in his own person as full sovereign over subservient people, which is the most important factor of all in waging war . he was flush with money, and he did whatever he wished. He did not announce his intentions in official decrees, did not deliberate in public, was not hauled into the courts by sycophants, was not prosecuted for moving illegal proposals, was not accountable to anyone. In short, he was ruler, commander, in control of everything.1 For his depiction of Philip’s authority Demosthenes looks less to Macedonia than to Athens, because what makes the king powerful in his speech is his freedom from democratic checks. Nevertheless, his observations on the Macedonian royal power is more informative and helpful than Aristotle’s references to it in his Politics, though modern historians tend to privilege the philosopher for what he says or even does not say on the subject. Aristotle’s seldom mentions Macedonian kings, and when he does it is for limited, exemplary purposes, lumping them with other kings who came to power through benefaction and public service, or who were assassinated by men they had insulted.2 Moreover, according to Aristotle, the extreme of tyranny is distinguished from ideal kingship (pambasilea) by the fact that tyranny is a government that is not called to account. -

Neolithic Society in Northern Greece: the Evidence of Ground Stone Artefacts
Neolithic society in Northern Greece: the evidence of ground stone artefacts Volume I Christina Tsoraki Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of Archaeology, University of Sheffield October 2008 to (j3en ABSTRACT Analysis of ground stone technology from the Neolithic of Greece rarely goes beyond incomplete descriptive accounts to focus on the activities performed with these tools and the contexts of their use. Ground stone products are seen as mundane static objects devoid of meaning and lacking significance. The aim of this thesis is to move away from incomplete accounts of ground stone technology and static typologies. Drawing upon the concepts of the chaine operatoire and 'object biographies' this thesis investigates ground stone technology as a social practice focusing on the life-cycle of artefacts from raw material selection to final deposition. The underlying premise is that a contextual approach can contribute to understanding the ways in which the production, consumption and discard of ground stone artefacts were structured within different forms and scales of social practice and the manner in which these differences articulated different meanings and social understandings. The aims of the thesis were materialised through the study of the rich ground stone assemblage from the LN settlement of Makriyalos, Greece. The analysis of the chaine operatoire of the Makriyalos ground stone assemblage revealed diverse technological choices expressed throughout the cycle of production and use. Established traditions existed according to which specific materials were considered to be appropriate for the production of different objects. Furthermore, detailed analysis suggests that the resulting objects were far from mundane artefacts but were instead active media for expressing choices informed by cultural understandings of appropriateness. -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Cremation, Society, and Landscape in the North Aegean, 6000-700 BCE Permalink https://escholarship.org/uc/item/8588693d Author Kontonicolas, MaryAnn Emilia Publication Date 2018 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Cremation, Society, and Landscape in the North Aegean, 6000 – 700 BCE A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Archaeology by MaryAnn Kontonicolas 2018 © Copyright by MaryAnn Kontonicolas 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Cremation, Society, and Landscape in the North Aegean, 6000 – 700 BCE by MaryAnn Kontonicolas Doctor of Philosophy in Archaeology University of California, Los Angeles, 2018 Professor John K. Papadopoulos, Chair This research project examines the appearance and proliferation of some of the earliest cremation burials in Europe in the context of the prehistoric north Aegean. Using archaeological and osteological evidence from the region between the Pindos mountains and Evros river in northern Greece, this study examines the formation of death rituals, the role of landscape in the emergence of cemeteries, and expressions of social identities against the backdrop of diachronic change and synchronic variation. I draw on a rich and diverse record of mortuary practices to examine the co-existence of cremation and inhumation rites from the beginnings of farming in the Neolithic period -

The Religious Tourism As a Competitive Advantage of the Prefecture of Pieria, Greece
Journal of Tourism and Hospitality Management, May-June 2021, Vol. 9, No. 3, 173-181 doi: 10.17265/2328-2169/2021.03.005 D DAVID PUBLISHING The Religious Tourism as a Competitive Advantage of the Prefecture of Pieria, Greece Christos Konstantinidis International Hellenic University, Serres, Greece Christos Mystridis International Hellenic University, Serres, Greece Eirini Tsagkalidou Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Evanthia Rizopoulou International Hellenic University, Serres, Greece The scope of the present paper is the research of whether the prefecture of Pieria comprises an attractive destination for religious tourism and pilgrimage. For this reason, the use of questionnaires takes place which aims to realizing if and to what extend this form of tourism comprises a comparative and competitive advantage for the prefecture of Pieria. The research method of this paper is the qualitative research and more specifically the use of questionnaires with 13 questions in total. The scope was to research whether the prefecture of Pieria is a religious-pilgrimage destination. The sample is comprised of 102 participants, being Greek residents originating from other Greek counties, the European Union, and Third World Countries. The requirement was for the participant to have visited the prefecture of Pieria. The independency test (x2) was used for checking the interconnections between the different factors, while at the same time an allocation of frequencies was conducted based on the study and presentation of frequency as much as relevant frequency. Due to the fact that, no other similar former researches have been conducted regarding religious tourism in Pieria, this research will be able to give some useful conclusions. -

Archaeological Anastylosis of Two Macedonian Tombs In
Virtual Archaeology Review, 11(22): 26-40, 2020 https://doi.org/10.4995/var.2020.11877 © UPV, SEAV, 2015 Received: May 22, 2019 Accepted: July 25, 2019 ARCHAEOLOGICAL ANASTYLOSIS OF TWO MACEDONIAN TOMBS IN A 3D VIRTUAL ENVIRONMENT LA ANASTILOSIS ARQUEOLÓGICA DE DOS TUMBAS MACEDONIAS EN UN AMBIENTE VIRTUAL 3D Maria Stampoulogloua, Olympia Toskab, Sevi Tapinakic, Georgia Kontogiannic , Margarita Skamantzaric, Andreas Georgopoulosc,* aSerres Ephorate of Antiquities, Eth. Antistasis 36-48, Serres, 62122 Greece. [email protected] bDepartment of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Dimokratias Ave. 1, Rhodes, 85132 Greece. [email protected] cLaboratory of Photogrammetry, National Technical University of Athens, Iroon Polytechniou 9, Zografos, Athens, 15780 Greece. [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Highlights: Use of contemporary digital methods for the 3D geometric documentation of complex burial structures. Interdisciplinary approach to implement digital techniques for 3D modelling, including 3D terrestrial laser scanning and image-based modelling. Implementation of virtual anastylosis by archaeologists using the 3D models and suitable software. Abstract: Archaeological restoration of monuments is a practice requiring extreme caution and thorough study. Proceeding to restoration or to reconstruction actions without detailed consultation and thought is normally avoided by archaeologists and conservation experts. Nowadays, anastylosis executed on the real object is generally prohibited. Contemporary technologies have provided archaeologists and other conservation experts with the tools to embark on virtual restorations or anastyloses, thus testing various alternatives without physical intervention on the monument itself. In this way, the values of the monuments are respected according to international conventions. In this paper, two examples of virtual archaeological anastyloses of two important Macedonian tombs in northern Greece are presented. -

In the Kingdom of Alexander the Great Ancient Macedonia
Advance press kit Exhibition From October 13, 2011 to January 16, 2012 Napoleon Hall In the Kingdom of Alexander the Great Ancient Macedonia Contents Press release page 3 Map of main sites page 9 Exhibition walk-through page 10 Images available for the press page 12 Press release In the Kingdom of Alexander the Great Exhibition Ancient Macedonia October 13, 2011–January 16, 2012 Napoleon Hall This exhibition curated by a Greek and French team of specialists brings together five hundred works tracing the history of ancient Macedonia from the fifteenth century B.C. up to the Roman Empire. Visitors are invited to explore the rich artistic heritage of northern Greece, many of whose treasures are still little known to the general public, due to the relatively recent nature of archaeological discoveries in this area. It was not until 1977, when several royal sepulchral monuments were unearthed at Vergina, among them the unopened tomb of Philip II, Alexander the Great’s father, that the full archaeological potential of this region was realized. Further excavations at this prestigious site, now identified with Aegae, the first capital of ancient Macedonia, resulted in a number of other important discoveries, including a puzzling burial site revealed in 2008, which will in all likelihood entail revisions in our knowledge of ancient history. With shrewd political skill, ancient Macedonia’s rulers, of whom Alexander the Great remains the best known, orchestrated the rise of Macedon from a small kingdom into one which came to dominate the entire Hellenic world, before defeating the Persian Empire and conquering lands as far away as India. -

The Auloi of Pydna Stelios Psaroudak˙S
The Auloi of Pydna Stelios Psaroudak˙s ZUSAMMENFASSUNG • The pipes are not bound together in any way but are physically independent of each other, Der Doppelaulos von Pydna wurde als einziges and their reeds are placed together inside the Instrument seiner Art bei der dokumentierten Aus- player’s mouth, each hand of the player operat- grabung einer ungestörten Begräbnisstätte gefunden. ing on the holes of only one pipe4. Er ist in einem so gut erhaltenen Zustand, dass zu sei- ner Vollständigkeit nur die Rohrblätter fehlen. Alle These are the basic established facts. However, erhaltenen Doppelauloi sind bisher ohne Provenienz there are important questions, which have not as und ohne Kontext überliefert, wir wissen nicht ein- yet been satisfactorily answered, and which have mal, ob sie überhaupt paarweise aufgefunden wur- to do both with the comparative physical aspects den (einen vergleichbaren Fund bildet nur das ausge- of the pipes in the pair, and the comparative grabene Rohrpaar von Akanthos, wobei dieses, was acoustic behaviour of the two pipes played in con- den Erhaltungszustand betrifft, nicht vergleichbar junction with each other. ist). Das Rohrpaar von Pydna hat eine kurze und eine lange knöcherne Pfeife, die jeweils aus fünf Ein- From a physical point of view the pertinent ques- zelteilen besteht: Becher am Anblasende, Birne, Ver- tions are: längerung, daran ein Mittelteil mit vier Grifflöchern, ein Ende mit zwei Löchern, das unterste jeweils ein • Are the two pipes equal or unequal in overall Windloch. Allem Anschein nach hielt der Spieler das length? Several depictions of the instrument längere Rohr, mit dem Daumenloch mit Drehung im while being played suggest unequal lengths: the Uhrzeigersinn, in der linken Hand und brachte dar- left pipe is drawn longer than the right one (e.g. -
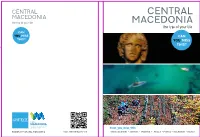
New VERYMACEDONIA Pdf Guide
CENTRAL CENTRAL ΜΑCEDONIA the trip of your life ΜΑCEDONIA the trip of your life CAΝ YOU MISS CAΝ THIS? YOU MISS THIS? #can_you_miss_this REGION OF CENTRAL MACEDONIA ISBN: 978-618-84070-0-8 ΤΗΕSSALΟΝΙΚΙ • SERRES • ΙΜΑΤΗΙΑ • PELLA • PIERIA • HALKIDIKI • KILKIS ΕΣ. ΑΥΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΕΣ. ΑΥΤΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΜΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΗ European emergency MUSEUMS PELLA KTEL Bus Station of Litochoro KTEL Bus Station Thermal Baths of Sidirokastro number: 112 Archaeological Museum HOSPITALS - HEALTH CENTERS 23520 81271 of Thessaloniki 23230 22422 of Polygyros General Hospital of Edessa Urban KTEL of Katerini 2310 595432 Thermal Baths of Agkistro 23710 22148 23813 50100 23510 37600, 23510 46800 KTEL Bus Station of Veria 23230 41296, 23230 41420 HALKIDIKI Folkloric Museum of Arnea General Hospital of Giannitsa Taxi Station of Katerini 23310 22342 Ski Center Lailia HOSPITALS - HEALTH CENTERS 6944 321933 23823 50200 23510 21222, 23510 31222 KTEL Bus Station of Naoussa 23210 58783, 6941 598880 General Hospital of Polygyros Folkloric Museum of Afytos Health Center of Krya Vrissi Port Authority/ C’ Section 23320 22223 Serres Motorway Station 23413 51400 23740 91239 23823 51100 of Skala, Katerini KTEL Bus Station of Alexandria 23210 52592 Health Center of N. Moudania USEFUL Folkloric Museum of Nikiti Health Center of Aridea 23510 61209 23330 23312 Mountain Shelter EOS Nigrita 23733 50000 23750 81410 23843 50000 Port Authority/ D’ Section Taxi Station of Veria 23210 62400 Health Center of Kassandria PHONE Anthropological Museum Health Center of Arnissa of Platamonas 23310 62555 EOS of Serres 23743 50000 of Petralona 23813 51000 23520 41366 Taxi Station of Naoussa 23210 53790 Health Center of N. -

Thessaloniki Perfecture
SKOPIA - BEOGRAD SOFIA BU a MONI TIMIOU PRODROMOU YU Iriniko TO SOFIASOFIA BU Amoudia Kataskinossis Ag. Markos V Karperi Divouni Skotoussa Antigonia Melenikitsio Kato Metohi Hionohori Idomeni 3,5 Metamorfossi Ag. Kiriaki 5 Ano Hristos Milohori Anagenissi 3 8 3,5 5 Kalindria Fiska Kato Hristos3,5 3 Iliofoto 1,5 3,5 Ag. Andonios Nea Tiroloi Inoussa Pontoiraklia 6 5 4 3,5 Ag. Pnevma 3 Himaros V 1 3 Hamilo Evzoni 3,5 8 Lefkonas 5 Plagia 5 Gerakari Spourgitis 7 3 1 Meg. Sterna 3 2,5 2,5 1 Ag. Ioanis 2 0,5 1 Dogani 3,5 Himadio 1 Kala Dendra 3 2 Neo Souli Em. Papas Soultogianeika 3 3,5 4 7 Melissourgio 2 3 Plagia 4,5 Herso 3 Triada 2 Zevgolatio Vamvakia 1,5 4 5 5 4 Pondokerassia 4 3,5 Fanos 2,5 2 Kiladio Kokinia Parohthio 2 SERES 7 6 1,5 Kastro 7 2 2,5 Metala Anastassia Koromilia 4 5,5 3 0,5 Eleftherohori Efkarpia 1 2 4 Mikro Dassos 5 Mihalitsi Kalolivado Metaxohori 1 Mitroussi 4 Provatas 2 Monovrissi 1 4 Dafnoudi Platonia Iliolousto 3 3 Kato Mitroussi 5,5 6,5 Hrisso 2,5 5 5 3,5 Monoklissia 4,5 3 16 6 Ano Kamila Neohori 3 7 10 6,5 Strimoniko 3,5 Anavrito 7 Krinos Pentapoli Ag. Hristoforos N. Pefkodassos 5,5 Terpilos 5 2 12 Valtoudi Plagiohori 2 ZIHNI Stavrohori Xirovrissi 2 3 1 17,5 2,5 3 Latomio 4,5 3,5 2 Dipotamos 4,5 Livadohori N. -

The Tomb of Olympias'
THE TOMB OF OLYMPIAS' MACEDONICAIV2 (PLATE 3) Tr HE SITE of ancient Pydna on the west coast of the Thermaic Gulf seems never to have been precisely determined, and I am not aware of ,any serious discussion of the problem of the city's location since that of Leon Heuzey written in the fifties of the last century.3 It is quite certain, however, that Pydna was the first important city of the north of the Pierian Plain, today the plain of Katerini, for otherwise the town would not have given its name to the great battle between King Perseus and the Romans in 168 B.C.4 It is equally certain that Pydna was located directly on the coast.5 It is true that Diodorus (XIII, 49, 2) states that King Archelaus in 410 B.C. moved the city twenty stadia inland from the coast, but it is abundantly clear that the coastal site had been reoccupied by the fourth century, probably during the disturbed period after the assassination of Archelaus in 399.6 Archelaus' Pydna, or New Pydna as we may call it, is verv probably to be placed at, or near, the medieval and modern 1 I am very deeply indebted to Professor Benedict Einarson of the University of Chicago for suggestions and criticism. Professor Einarson is of course in no sense responsible for the argu- mentation and conclusions of this study. 2 The first two studies in this series have been published in Harvard Studies in Classical Phi- lology, LI, 1940, pp. 125-136. The third, " Cults of Thessalonica," has appeared in the Harvard Theological Reviezv, XLI, 1948, pp. -
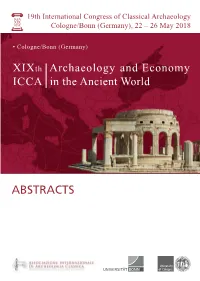
Abstract Book
19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany), 22 – 26 May 2018 PRACTICAL INFORMATION WiFi – Gürzenich: hotspot Köln • Cologne/Bonn (Germany) WiFi – University of Bonn: eduroam Emergency number: 112 th Taxi – Cologne: + 49 (0) 221-2882 XIX Archaeology and Economy Taxi – Bonn: + 49 (0) 228-55 55 55 ICCA in the Ancient World aiac2018.de [email protected] WELCOME TO COLOGNE AND BONN! – 26 May 2018 Abstracts – 26 May 2018 Cologne/Bonn (Germany), 22 PATRONAGE Under the patronage of the Minister-President of the State of North Rhine-Westphalia Armin Laschet. ABSTRACTS CO-OPERATION PARTNER 19th International Congress of Classical Archaeology 19th International Congress of Classical 018_AIAC_Book_of_Abstracts_Cover.indd 1 07.05.18 17:06 19th International Congress of Classical Archaeology Archaeology and Economy in the Ancient World 22-26 May 2018 Cologne/Bonn ABSTRACTS keynotes | panels & papers | posters| workshops EDITORIAL STAFF Simon Kleinschmidt Diana Wozniok Christine Avenarius Nickolas Gehrmann DESIGN Ulrike Kersting PRINTING sedruck Cologne Germany © AIAC 2018 Cologne/Bonn www.aiac2018.de Table of Content 1. Keynote Abstracts 7 2. Panel and Paper Abstracts 11 Session 1: The Human factor: Demography, nutrition, health, epidemics 11 Panel 1.1 Economy, Society and Health-related Quality of Life in the Ancient World: Bioarchaeological perspectives from the Eastern Mediterranean 11 Panel 1.2 Wealthy and Healthy? Methodological Approaches to Non-élite Burials 15 Panel 1.3 The Economic Contribution of Migrants