Rapporti ISTISAN 07/12 Istituto Superiore Di Sanità Conference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Open Access Passenger Rail Competition: the Case of Italy
Open Access Passenger Rail Competition: the case of Italy Angela Stefania Bergantino University of Bari, Italy Round Table On Open Access Passenger Rail Competition 2016 Masarykova Univerzita , Brno 11 th November 2016 1 Open Access Policy: The divestiture • The vertical divestiture (pre-NTV): • Legal unbundling as form of vertical separation. • The IM is managerially autonomous, but integrated • In 1985, FSI (Ferrovie dello Stato) in the Holding company…. ended being a department of the Ministry of Transportation; • In 1992, FSI became a SOE (Stated Owned Enterprise); • In 1998, FSI became an holding group with forms of separation: • RFI: new Infrastructure Manager (IM), responsible for allocation of capacity, safety, maintenance of infrastructure, traffic management; • Trenitalia: rail operator; • FSI works as a holding group. 2 A brief history of HSR in Italy: the network • First HSR network is “The Direttissima” over the Rome-Florence Route (completed in 1992) • Major investments over the 2000s with a consolidated cost of 32 billion of euro • The modern HSR Network was completed between 2006 and 2009 • Rome-Naples and Turin-Novara were completed in 2006; Milan-Bologna in 2008; Naples- Salerno , Milan-Novara and Florence-Bologna in 2009. • …but the network is still being developed. • In December, HSR on Treviglio-Brescia (39.6 Km) over the Milan-Venice HSR route (245 km) which is still under construction for the Brescia-Padova component (152 km). Expected to be completed by 2020. • New projects in Southern Italy (which suffers a long-term infrastructure gap): • Bari-Naples-Rome line, works started in 2016 and are expected to be completed by 2026. -

Open Access Publishing
Open Access The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Suber, Peter. 2012. Open access. Cambridge, Mass: MIT Press. [Updates and Supplements: http://cyber.law.harvard.edu/hoap/ Open_Access_(the_book)] Published Version http://mitpress.mit.edu/books/open-access Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:10752204 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA OPEN ACCESS The MIT Press Essential Knowledge Series Information and the Modern Corporation, James Cortada Intellectual Property Strategy, John Palfrey Open Access, Peter Suber OPEN ACCESS PETER SUBER TheMIT Press | Cambridge, Massachusetts | London, England © 2012 Massachusetts Institute of Technology This work is licensed under the Creative Commons licenses noted below. To view a copy of these licenses, visit creativecommons.org. Other than as provided by these licenses, no part of this book may be reproduced, transmitted, or displayed by any electronic or mechanical means without permission from the publisher or as permitted by law. This book incorporates certain materials previously published under a CC-BY license and copyright in those underlying materials is owned by SPARC. Those materials remain under the CC-BY license. Effective June 15, 2013, this book will be subject to a CC-BY-NC license. MIT Press books may be purchased at special quantity discounts for business or sales promotional use. -

Chapter 5. Digital Transformation and Capabilities
5. DIGITAL TRANSFORMATION AND CAPABILITIES 125 Chapter 5. Digital transformation and capabilities Digital technologies are transforming people’s life, business and society. Higher education systems and institutions are particularly affected by digital transformation, which can enable new services and provide new opportunities for innovation and entrepreneurship. Higher education institutions (HEIs) embracing digital technologies can become drivers of growth and development for their own ecosystems. This chapter introduces relevant concepts and definitions on how the digital transformation is affecting HEIs and presents the specificities of the Italian case, discussing good practices and challenges emerged during study visits. Recommendations for policymakers and leaders of HEIs conclude the chapter. The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in the West Bank under the terms of international law. SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN HIGHER EDUCATION IN ITALY © OECD/EUROPEAN UNION 2019 126 5. DIGITAL TRANSFORMATION AND CAPABILITIES Introduction: Defining digital transformation and capabilities The rapid development and spread of digital technologies are contributing to change in every aspect of people’s lives, business and society. Digital transformation is the result of digitisation and digitalisation of economies and societies (OECD, 2019a).1 Some authors consider digital transformation as a more pervasive set of changes that digital technologies cause or affecting all aspects of human life (Stolterman and Fors, 2006). The digital transformation is intrinsically connected to what has been defined as the “fourth industrial revolution” (Schwab, 2016): a process through which digital technologies are shaping the future of society and economic development in a comparable manner to the case of steam power for the first industrial revolution. -

Ten Simple Rules to Consider Regarding Preprint Submission
EDITORIAL Ten simple rules to consider regarding preprint submission Philip E. Bourne1*, Jessica K. Polka2, Ronald D. Vale3, Robert Kiley4 1 Office of the Director, The National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, United States of America, 2 Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts, United States of America, 3 Department of Cellular and Molecular Pharmacology and the Howard Hughes Medical Institute, University of California San Francisco, San Francisco, California, United States of America, 4 Wellcome Library, The Wellcome Trust, London, United Kingdom * [email protected] For the purposes of these rules, a preprint is defined as a complete written description of a body of scientific work that has yet to be published in a journal. Typically, a preprint is a research article, editorial, review, etc. that is ready to be submitted to a journal for peer review or is under review. It could also be a commentary, a report of negative results, a large data set and its description, and more. Finally, it could also be a paper that has been peer reviewed and either is awaiting formal publication by a journal or was rejected, but the authors are willing to make the content public. In short, a preprint is a research output that has not completed a typi- cal publication pipeline but is of value to the community and deserving of being easily discov- ered and accessed. We also note that the term preprint is an anomaly, since there may not be a a1111111111 print version at all. The rules that follow relate to all these preprint types unless otherwise a1111111111 noted. -

Whither the Ingelfinger Rule? an Editor’S Perspective
Whither the Ingelfinger rule? An editor’s perspective Dr Trish Groves Deputy editor, BMJ [email protected] The problem The Food and Drug Amendments Act 2007 requires pharmaceutical companies to register nearly all trials and to disclose their results publicly within a timeframe dictated by the new legislation or pay penalties of $10K a time Will this infringe the Ingelfinger rule and make it impossible to publish trials in medical journals? What results have to be disclosed for FDA? Four tables: • demographic and baseline data collected overall and for each arm of the trial, including patients dropped out and excluded from analysis • raw data and stats tests for each of the primary and secondary outcome measures for each arm of the trial • anticipated and unanticipated serious adverse events grouped by organ system, with number and frequency of such event in each arm of the clinical trial • anticipated and unanticipated adverse events exceeding 5% frequency in any arm of the trial, grouped by organ system What I aim to cover • International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) policy • BMJ policy • what investigators and authors need to know to continue publishing clinical trial results in top-tier journals and comply with the new law ICMJE policy ICMJE said in June 2007 that member journals * will not consider results posted in a clinical trials register as previous publications if presented in the form of a brief, structured (<500 words) abstract or table. ICMJE meets next in May: will this policy change to cover FDAA’s required four tables? * Annals of Internal Medicine, BMJ, Canadian Medical Association Journal, Croatian Medical Journal, JAMA, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, New England Journal of Medicine, New Zealand Medical Journal, The Lancet, The Medical Journal of Australia,Tidsskrift for Den Norske Llegeforening, and Ugeskrift for Laeger ICMJE left door open “. -

Phd2020 OS 4.Pdf
Open Science 4 OPEN ACCESS Elena Giglia [email protected] @egiglia https://doi.org/10.5281/zenodo.4039829 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Photos are mine, available for reuse on Flickr, https://www.flickr.com/photos/eg65/albums/ What we shall learn: 1. how to «do» Open Access 2. tools to support Take home messages • Open Access is also self-archiving, not only publishing • Open Access does not preclude any career advancement nor assessment exercise. There is a way Open Access Apr. 26, 2018 https://twitter.com/rmounce/status/910467463690801152 Open Access http://opencontent.org/definition/ The pillars Knowledge is a common Scholarly communication is a great conversation The results of publicly funded research must be publicly available Why do we need Open Access? [or: where does the money go?] Corina Logan, 2018 It’s not my call to jump. Let’s wait for our leaders to decide. It’s my league Researcher 3 People say we should build it. …who asked us to What are you doing All of them build this wall? up there? Just jump. I’ll catch you Researcher Community, 2 common people This wall has been here It’s me who for centuries, it’s our know where duty to keep it the door But what are you standing is and doing? And why? also has Cementing the [flying drone] this brick key Researcher mmmmh the wall 5 Commercial strechtes very far, I Researcher publisher Researcher 6 can’t see any door 4 Why do we need Open Access? http://bulliedintobadscience.org/ Corina Logan, 2018 Roorick, June -

Publishing Collaborative Studies Between Academics and Industry
Eur Respir J 1997; 10: 2441–2442 Copyright ERS Journals Ltd 1997 DOI: 10.1183/09031936.97.10112441 European Respiratory Journal Printed in UK - all rights reserved ISSN 0903 - 1936 EDITORIAL Publishing collaborative studies between academics and industry P.J. Sterk*, K. Larsson**, R. Naeije+, U. Costabel++ Research partnership should be in accordance with legal and ethical regula- tions, and with the standard rules generally obeyed by During the last decade we have observed a large pro- the scientific community. gress in biomedical research in general, and in the pul- monary field in particular. This is shown by the almost What can go wrong? exponential increase in the quantity of published sci- ence, as well as by the obvious improvement of its over- The editors of the ERJ have recently faced a serious all quality. We are very pleased that this is certainly dilemma as to whether to publish a manuscript submit- apparent from the current submissions to the European ted by PALMQVIST et al. [1]. This is a collaborative study Respiratory Journal (ERJ). between academic researchers and a pharmaceutical Presumably, one of the reasons for this favourable company. Although not innovative in the strict sense, development is the improved exchange of information the study provides useful data on the application of anti- among scientists all over the world. This has been facili- asthma drugs, also to be used for an international regi- tated by modern communication techniques, and seems stration dossier. Even though the manuscript of the to have led to intensive and frank collaboration between study had passed the scientific peer review process after different research groups and institutes. -

Di-Barbora-Eugenia-CV-2017.Pdf
• Referente Progetto CLIL e sua sperimentazione (aa. ss. 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09) • Referente del Progetto di Ricerca-Azione “Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale” MIUR (coordinamento gruppo di lavoro, conduzione ricerca), (aa. ss. 2013-14, 2012- 13, 2011-12) • Membro della Commissione POF e Valutazione dell’Istituto Comprensivo Divisione Julia (aa. ss. 2012-13, 2011-12) • Coordinatrice del gruppo di lavoro dell’I.C. Julia per la rivisitazione delle “Indicazioni nazionali per i curricoli per la scuola del primo ciclo” (a.s. 2011-12) • Referente per l’Istituto Comprensivo Julia del progetto « Intercultura », bando regione FVG, (a.s. 2006-07) • Coordinatrice per l’Istituto C. Julia del progetto MIUR “Aree a forte flusso migratorio” (a.s. 2006-07) • Insegnante accogliente dei tirocinanti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria con incarichi di coordinamento educativo-didattico a tirocini all’interno della scuola (a.s. 2005-06) 2002-04 Insegnante a disposizione del Ministero degli Affari Esteri Docente di italiano presso la Scuola Internazionale Robert Schuman di Strasburgo – Francia 1998-2002 Attività e di promozione culturale, linguistica ed educativo-didattico presso il Consolato d’Italia di Mulhouse (attività e manifestazioni interculturali, viaggi linguistici, concorsi ed esposizioni) 1997-2002 Insegnante a disposizione del Ministero degli Affari Esteri Insegnante di italiano L2 nei corsi (livello primarie e collège) attivati presso la Circoscrizione consolare di Mulhouse – Francia -
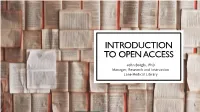
Introduction to Open Access
INTRODUCTION TO OPEN ACCESS John Borghi, PhD Manager, Research and Instruction Lane Medical Library Open Access Week OA Week at Lane Library Enhancing Your Researcher Profile with ORCID | October 19, 2:00 pm A Brief Introduction to Preprints October 20, 2:00 pm Introduction to Dryad (Data Sharing) October 22, 2:00 pm Open Science Reading Group October 27, 2:00 pm All events are free of charge and conducted virtually. Visit Lane.Stanford.edu to register for our upcoming classes and events. Today’s Agenda Preprints!? Wrap up 2:00 3:00 What is OA? Breakout Groups Fraser, N., et al. (2020). Preprinting a pandemic: The role of preprints in the COVID-19 Reading for today: pandemic. BioRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.05.22.111294 Penfold, N. C., & Polka, J. K. (2020). Technical and social issues influencing the adoption of preprints in the life sciences. PLOS Genetics, 16(4), Additional reading: e1008565. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008565 Suber, P. (2012). What is Open Access? In Open Access (pp 1-27). MIT Press. https://archive.org/details/9780262517638OpenAccess/page/n13/mode/2up What is Open Access? By "open access" to [peer reviewed] literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to For a work to be OA, the copyright holder read, download, copy, distribute, print, must consent in advance to let users “copy, search, or link to the full texts of these use, distribute, transmit and display the articles, crawl them for indexing, pass work publicly and to make and distribute them as data to software, or use them for derivative works, in any digital medium for any other lawful purpose, without any responsible purpose, subject to proper financial, legal, or technical barriers other attribution of authorship.” than those inseparable from gaining access to the internet itself. -

Textrelease.Com ▪ [email protected] Textrelease Tel/Fax +31-20-331.2420
Twelfth International Conference on Grey Literature National Technical Library, Prague, Czech Republic, 6-7 December 2010 Transparency in Grey Literature Grey Tech Approaches to High Tech Issues Conference Program and Abstract Book ISSN 1385-2308 Host and Sponsors GL12 Program and Conference Bureau Javastraat 194-HS, 1095 CP Amsterdam, The Netherlands www.textrelease.com ▪ [email protected] TextRelease Tel/Fax +31-20-331.2420 CIP GL12 Conference Program and Abstracts Twelfth International Conference on Grey Literature : Transparency in Grey Literature, Grey Tech Approaches to High Tech Issues, 6-7 December 2010 / compiled by D.J. Farace and J. Frantzen ; GreyNet, Grey Literature Network Service. – Amsterdam : TextRelease, December 2010. – 138 p. ; 30 cm. – Author Index. – (GL-conference series, ISSN 1385-2308 ; No. 12) The British Library, FLICC-FEDLINK, INIST-CNRS, NTK, and NYAM are corporate authors and associate members of GreyNet. This program book contains the schedule for the plenary and poster sessions. The titles and abstracts of the papers as well as information on the authors are provided. When available, copies of the PowerPoint slides are also included in notepad format. ISBN: 978-90-77484-15-9 © TextRelease, 2010 Foreword Transparency in Grey Literature Grey Tech Approaches to High Tech Issues At the onset of twenty-ten, Grey Literature emerged into the public arena after more than a quarter century in the corridors of libraries and in workplaces and meeting rooms of information practitioners and professionals. Grey Literature is now a topic of news in the world media. Coverage in magazines and newspapers e.g. Nature, New Scientist, The Economist, the Guardian, etc. -

Challenges and Changing Roles for Medical Journals in the Cyberspace Age: Electronic Pre-Prints and E-Papers
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH Eysenbach Editorial Challenges and changing roles for medical journals in the cyberspace age: Electronic pre-prints and e-papers Gunther Eysenbach (J Med Internet Res 1999;1(2):e9) doi: 10.2196/jmir.1.2.e9 "We are in the business of revealing, not suppressing for the very purpose of open peer-review and in an effort to information." improve the manuscript are routinely rejected by these journals, with the argument that the public shall in this manner be J. P. Kassirer, N. Eng. J. Med. 327, 1238 (1992). protected from non-peer-reviewed, low-quality information. It In May 1999, the Director of the US National Institutes of shows the paternalistic concern of these journals, their belief Health (NIH), Harold Vermus, proposed a project, then dubbed that the public cannot discriminate between the different levels "E-biomed" [1] (now called "PubMed Central" [2]). In this of credibility of a manuscript. Another explanation for this proposal, the National Institutes of Health - through the National unwillingness to embrace electronic advance publication could Center for Biotechnology Information, a component of the be that traditional paper journals attempt to preserve their National Library of Medicine - proposed to establish an priority, newsworthiness, and exclusive access to research papers Internet-accessible database of full electronic papers, which (which has long been a guarantee for circulation, attention, and would be submitted directly by their authors. The original paid advertisements for their journals). However, this race of E-biomed plan [1] envisaged two sections in this system: one traditional journals against the Internet for priority and that allowed authors to submit papers which would only be exclusivity of research reports cannot be won by the journals. -

The State of the Art and the Challenges of Policies in Italy
Messina Declaration (November 4th – 5th 2004) ltalian Declaration supporting the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities promoted and organised by the Library Committee of the Italian Council of Rectors. It is the first institutional action of Italian university rectors to support OA. This event has helped foster awareness of Open Access issues and has boosted interest in Open Archives and related technologies for a more effective dissemination of scholarly content. Since the Messina Declaration 71 out of 77 Italian universities have signed the Berlin Declaration Open Access in Italy In the following years, the principles of open access have been also based on voluntary initiatives, even if the CRUI coordinated them. Over the past few years many universities and research institutions have placed repositories which are based on different approaches: in some cases they collect and make available the entire scientific production. In others, the articles are archived but not made all publicly accessible. 15 Italian universities, research and funding institutions (e.g. Telethon, Cariplo, Istituto Superiore di Sanità, CNR, INFN) have adopted OA policies that support OA and particularly the ‘Green Road’, more or less strongly. 1. Linee guide per il deposito tesi di dottorato presso BNCC Roma e Firenze 2. Linee guida per anagrafe e valutazione della ricerca 3. Linee guida per la creazione di archivi aperti 4. Linee guida per riviste elettroniche 5. Linee guida per metadati 6. Linee guida per policy e regolamenti di ateneo 7. Adoption of Open Access principles in University Regulations (Statuti di Ateneo) 8. DOI and NBN (DataCite and Magazzini Digitali) https://www.crui.it/gruppo-open-access-2014-2016.html In February 2012, CRUI’S Open Access group published the • Policy guidelines for the development and promotion of open access.