134 Estate 2000.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Track Listing the Complete Olimpia Boronat Gramophone and Typewriter Company, St. Petersburg, 1904 Gramophone Company (Pre-Dog)
Track Listing Total timing (72:08) The Complete Olimpia Boronat The Complete Olimpia Boronat Gramophone and Typewriter Company, St. Petersburg, 1904 COMPLETE TRACK LISTING 1. LA TRAVIATA: Sempre libera (Verdi) [3:05] LINER NOTES (1769L) 53346 / Transposed down a semi-tone to G For the first time, the complete 2. Solovei [The Nightingale] (Alabiev) [3:39] and rare recordings of Olimpia (1770L) 23420 / Transposed down a full tone to C Boronat (b. 1867 - d. 1934) have minor been gathered to create a single CD that brings to light one of the most beautiful coloratura 3. Senza l'amore (Tosti) [3:05] soprano voices on disc. (1771L) 53347 4. RIGOLETTO: Caro nome (Verdi) [3:34] (1772L) 53348 / Transposed down a semi-tone to E- [return to main menu] flat 5. MIREILLE: O d'amor messaggera (Gounod) [2:37] (1773L) 53349 6. ZABAVA PUTIATISHNA: [Zabava's arioso] (Ivanov) [2:48] (1774L) 53350 7. I PURITANI: O rendetemi la speme...Qui la voce sua soave (Bellini) [3:34] (1775L) 53351 8. Desiderio (Zardo) [2:27] (1776L) 53352 9. LES PÊCHEURS DE PERLES: Siccome un dì caduto il sole (Bizet) [3:36] (1777L) 53353 10. MARTHA: Qui sola, vergin rosa (Flotow) [2:50] (1778L) 53354 Gramophone Company (Pre-dog), Milan, 1908 11. I PURITANI: O rendetemi la speme...Qui la voce sua soave (Bellini) [4:07] (1505C) , assigned 053282, published only as HMB 20 12. DON PASQUALE: So anch'io la virtù magica (Donizetti) [4:22] (1506HC) 053185 13. RIGOLETTO: Tutte le feste (Verdi) [3:23] (1507C) 053186 14. MARTHA: Qui sola, vergin rosa (Flotow) [4:17] (1515C), assigned 053288, published only as HMB 29 15. -

Memoirs of the Author Concerning the HISTORY of the BLUE ARMY Dm/L Côlâhop
Memoirs of the author concerning The HISTORY of the BLUE ARMY Dm/l côlâhop Memoirs of the author concerning The HISTORY of the BLUE AR M Y by John M. Haffert - ' M l AMI International Press Washington, N.J. (USA) 07882 NIHIL OBSTAT: Rev. Msgr. William E. Maguire, S.T.D. Having been advised by competent authority that this book contains no teaching contrary to the Faith and Morals as taught by the Church, I approve its publication accord ing to the Decree of the Sacred Congregation for the Doc trine of the Faith. This approval does not necessarily indi cate any promotion or advocacy of the theological or devo tional content of the work. IMPRIMATUR: Most Rev. John C. Reiss, J.C.D. Bishop of Trenton October 7, 1981 © Copyright, 1982, John M. Haffert ISBN 0-911988-42-4 All rights reserved. No part of this book may be repro duced or transmitted in any form or by any means, elec tronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. This Book Dedicated To The Most Rev. George W. Ahr, S.T.D., Seventh Bishop of Trenton — and to The Most Rev. John P. Venancio, D.D., Second Bishop of Leiria - Fatima and Former International President, The Blue Army of Our Lady of the Rosary of Fatima Above: The Most Rev. John P. Venancio, D.D. (left), and the Most Rev. George W. Ahr, S.T.D. (right), at the dedication and blessing of the Holy House, U.S.A. -
Reset MODERNITY!
reset MODERNITY! FIELD BOOK ENGLISH reset MODERNITY! 16 Apr. – 21 Aug. 2016 ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe What do you do when you are disoriented, when the compass on your smartphone goes haywire? You reset it. The procedure varies according to the situ- ation and device, but you always have to stay calm and follow instructions carefully if you want the compass to capture signals again. In the exhibition Reset Modernity! we ofer you to do some- thing similar: to reset a few of the instruments that allow you to register some of the confusing signals sent by the epoch. Except what we are trying to recalibrate is not as simple as a compass, but instead the rather obscure principle of projection for mapping the world, namely, modernity. Modernity was a way to diferentiate past and future, north and south, progress and regress, radical and con- servative. However, at a time of profound ecological mutation, such a compass is running in wild circles with- out ofering much orientation anymore. This is why it is time for a reset. Let’s pause for a while, follow a procedure and search for diferent sensors that could allow us to recalibrate our detectors, our instru- ments, to feel anew where we are and where we might wish to go. No guarantee, of course: this is an experiment, a thought experiment, a Gedankenausstellung. HOW TO USE THIS FIELD BOOK This feld book will be your companion throughout your visit. The path through the show is divided into six procedures, each allowing for a partial reset. -

Příspěvek Ke Kontextologii Studia Křesťanského Východu V Katolické Církvi a Hledání Nového Metodologického Východiska
SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS C 53, 2006 Pavel AMBROS „Ó Východe, jase Věčného sVětla“ Příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska Chceme-li se zabývat otázkou kontextu studia křesťanského Východu v kato- lické církvi,1 musíme se oprostit od falešného romantismu a přiblížit si „Sitz im Leben“ tohoto studia – historicitu fenoménu vzájemných vztahů a poznávání. V příspěvku ukáži na některé rysy kontextologického přístupu, jak jej navozuje název našeho kolokvia.2 Dobře jej můžeme poznávat na příkladu jezuitského řádu či při studiu oficiálních papežských dokumentů. Mohou se stát vhodnou ilustrací toho, jak proměna kontextu ovlivňuje poznání a komunikaci mezi křesťanskými tradicemi Východu a Západu.3 1. studium Křesťanského Východu jako historický fenomén – jezuité a křesťanský Východ, ilustrace Jezuité přišli na území dnešního západního Běloruska,4 Ukrajiny5 a baltských zemí již v samém počátku své existence. Žili zde, s výjimkou krátkých přeruše- 1 Pokud nebude upřesněno v textu jinak, máme v našem příspěvku na mysli katolickou církev latinského obřadu ve smyslu CIC, kán. 1 (Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Latinsko-české vydání s věcným rejstříkem. Praha 1994, s. 3). 2 Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. Brno. 5. října 2005. 3 Význam kontextu jsem si uvědomil loni při svém měsíčním pobytu v Moskvě, kdy jsem byl svědkem diskuze mezi ruskými jezuity nad vyhlášením mladých ruských neofašistů, jejichž „führer“ Alexij, obránce Bílého domu v době vzpoury proti Jelcinovi, byl schopen říci: „My nejsme politická strana. Jsme starý náboženský jezuitský řád.“ Když přišli po roce 1989 prv- ní dva jezuité oficiálně do Moskvy, v novinách se objevil titulek: „AMDG. -

Platelet Abnormalities in Idiopathic Myelofibrosis
original paper Haematologica 1994; 79:29-39 PLATELET ABNORMALITIES IN IDIOPATHIC MYELOFIBROSIS: FUNCTIONAL, BIOCHEMICAL AND IMMUNOMORPHOLOGICAL CORRE- LATIONS Pietro Leoni, Serena Rupoli, Gianfranco Lai°, Maria Antonietta Brunelli#, Monica Mattioli Belmonte*, Armanda Pugnaloni*, Rosa Anna Rabini**, Laura Mazzanti**, Graziella Biagini* Institute of General Medicine and Medical Therapy, Ancona University; #Institute of Histology, Bologna University; *Institute of Human Morphology, Ancona University; **Institute of Biochemistry, Ancona University, °Central Laboratory, Torrette Hospital, Ancona; Italy ABSTRACT Background. An extensive study of platelet function was performed on 18 consecutive patients affected by idiopathic myelofibrosis (IM). Materials and methods. Clinical hematological and morphofunctional parameters were studied in IM patients and control subjects. Platelet tests, ultrastructural data, immunocytochemical von Willebrand factor detection, freeze fracturing results and free cytosolic calcium level were evalu- ated. Results. Bleeding time was frequently found to be prolonged, but it never reached levels which could give any cause for concern. Aggregation by ADP, collagen and epinephrine was always altered, sometimes profoundly; on the contrary, agglutination by ristocetin was almost always normal, albeit occasionally increased. Plasma ͱ-TG and PF4 levels were found to be elevated in 11 and 12 patients, respectively. This indicated an abnormal release from platelet Ͱ-granules. Depletion of Ͱ-granules was also confirmed by the -

Music Migration in the Early Modern Age
Music Migration in the Early Modern Age Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence Advisory Board Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Żórawska-Witkowska Published within the Project HERA (Humanities in the European Research Area) – JRP (Joint Research Programme) Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West, and South (MusMig) Music Migration in the Early Modern Age Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska, Eds. Warsaw 2016 Liber Pro Arte English Language Editor Shane McMahon Cover and Layout Design Wojciech Markiewicz Typesetting Katarzyna Płońska Studio Perfectsoft ISBN 978-83-65631-06-0 Copyright by Liber Pro Arte Editor Liber Pro Arte ul. Długa 26/28 00-950 Warsaw CONTENTS Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska Preface 7 Reinhard Strohm The Wanderings of Music through Space and Time 17 Alina Żórawska-Witkowska Eighteenth-Century Warsaw: Periphery, Keystone, (and) Centre of European Musical Culture 33 Harry White ‘Attending His Majesty’s State in Ireland’: English, German and Italian Musicians in Dublin, 1700–1762 53 Berthold Over Düsseldorf – Zweibrücken – Munich. Musicians’ Migrations in the Wittelsbach Dynasty 65 Gesa zur Nieden Music and the Establishment of French Huguenots in Northern Germany during the Eighteenth Century 87 Szymon Paczkowski Christoph August von Wackerbarth (1662–1734) and His ‘Cammer-Musique’ 109 Vjera Katalinić Giovanni Giornovichi / Ivan Jarnović in Stockholm: A Centre or a Periphery? 127 Katarina Trček Marušič Seventeenth- and Eighteenth-Century Migration Flows in the Territory of Today’s Slovenia 139 Maja Milošević From the Periphery to the Centre and Back: The Case of Giuseppe Raffaelli (1767–1843) from Hvar 151 Barbara Przybyszewska-Jarmińska Music Repertory in the Seventeenth-Century Commonwealth of Poland and Lithuania. -

Icrs2016 Programme
PAGE | I TH 26 ANNUAL SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL CANNABINOID RESEARCH SOCIETY BUKOVINA POLAND JUNE 26 – JULY 1, 2016 TH 26 ANNUAL SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL CANNABINOID RESEARCH SOCIETY BUKOVINA POLAND JUNE 26 – JULY 1, 2016 Symposium Programming by Cortical Systematics LLC Copyright © 2016 International Cannabinoid Research Society Research Triangle Park, NC USA ISBN: 978-0-9892885-3-8 These abstracts may be cited in the scientific literature as follows: Author(s), Abstract Title (2016) 26th Annual Symposium on the Cannabinoids, International Cannabinoid Research Society, Research Triangle Park, NC, USA, Page #. Funding for this conference was made possible in part by grant 5R13DA016280 from the National Institute on Drug Abuse. The views expressed in written conference materials or publications and by speakers and moderators do not necessarily reflect the official policies of the Department of Health and Human Services; nor does mention by trade names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the U.S. Government. ICRS Sponsors Government Sponsors National Institute on Drug Abuse Non- Profit Organization Sponsors Kang Tsou Memorial Fund 2016 ICRS Board of Directors Executive Director Cecilia Hillard, Ph.D. President Michelle Glass, Ph.D. President- Elect Matt Hill, Ph.D. Past President Steve Alexander, Ph.D. Secretary Sachin Patel, M.D., Ph.D. Treasurer Steve Kinsey, Ph.D. International Secretary Roger Pertwee, M.a., D.Phil. , D.Sc. Student Representative Natalia Małek, M.Sc. Grant PI Jenny Wiley, Ph.D. Managing Director Jason Schechter, Ph.D. 2016 Symposium on the Cannabinoids Conference Coordinators Steve Alexander, Ph.D. Michelle Glass, Ph.D. Cecilia Hillard, Ph.D. -
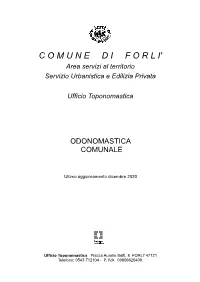
C O M U N E D I F O R L I'
C O M U N E D I F O R L I' Area servizi al territorio Servizio Urbanistica e Edilizia Privata Ufficio Toponomastica ODONOMASTICA COMUNALE Ultimo aggiornamento dicembre 2020 Ufficio Toponomastica Piazza Aurelio Saffi, 8 FORLI' 47121 Telefono: 0543 712104 - P. IVA 00606620409. Avvertenza: la presente raccolta deve essere intesa come provvisoria. Si sollecita chi, utilizzandola, vorrà segnalare eventuali errori, omissioni o altro. PER OGNI AREA DI CIRCOLAZIONE: LE PRIME RIGHE CONTENGONO IL CODICE ANAGRAFICO DELL’AREA DI CIRCOLAZIONE E L’INDICAZIONE DEI QUARTIERI ATTRAVERSATI. L’ULTIMA RIGA CONTIENE LE DATE DI APPROVAZIONE DELLA DENOMINAZIONE C.T. Abbreviazione di COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA (data della Commissione). C.C. Abbreviazione di CONSIGLIO COMUNALE (numero e data della deliberazione). G.C. Abbreviazione di GIUNTA COMUNALE (numero e data della deliberazione). Soppresse Circoscrizioni 2010 Revisione Quartieri con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 04.08.2015, pubblicata all'albo in data 03.09.2015 Tutti i diritti di pubblicazione sono riservati al Comune di Forlì. E’ ammessa la riproduzione citando la fonte. ABRUZZO VIA (cod. 00077) Foro Boario Vecchiazzano Massa Ladino 1747-1823, di Forlì. Scultore, apprese a Bologna i Dal nome della regione dell'Italia centrale che si rudimenti della scultura ed in seguito aprì a Roma affaccia sul Mare Adriatico. uno studio. Lavorò a Milano per il Duomo e per l'Arco C.T. del 27.10.1987, C.C. 833 del 11.12.1987. del Sempione. ACCADEMIA BORGHETTO (cod. 08217) ADAMELLO VIA (cod. 00440) Musicisti Grandi Italiani Pianta Ospedaletto Coriano A ricordo dell'Accademia aeronautica che vi ebbe Gruppo montuoso delle Alpi Retiche, fra il Trentino e sede. -

Phase-3 Study Older with Acute Myeloid Leukemia: Final Results Of
From bloodjournal.hematologylibrary.org at UNIVERSITEIT ANTWERPEN on December 2, 2013. For personal use only. 2005 106: 27-34 Prepublished online March 10, 2005; doi:10.1182/blood-2004-09-3728 Use of glycosylated recombinant human G-CSF (lenograstim) during and/or after induction chemotherapy in patients 61 years of age and older with acute myeloid leukemia: final results of AML-13, a randomized phase-3 study Sergio Amadori, Stefan Suciu, Ulrich Jehn, Roberto Stasi, Xavier Thomas, Jean-Pierre Marie, Petra Muus, Francois Lefrère, Zwi Berneman, George Fillet, Claudio Denzlinger, Roel Willemze, Pietro Leoni, Giuseppe Leone, Marco Casini, Francesco Ricciuti, Marco Vignetti, Filip Beeldens, Franco Mandelli and Theo De Witte Updated information and services can be found at: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/106/1/27.full.html Articles on similar topics can be found in the following Blood collections Clinical Trials and Observations (3784 articles) Hematopoiesis and Stem Cells (3186 articles) Neoplasia (4212 articles) Information about reproducing this article in parts or in its entirety may be found online at: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/site/misc/rights.xhtml#repub_requests Information about ordering reprints may be found online at: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/site/misc/rights.xhtml#reprints Information about subscriptions and ASH membership may be found online at: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/site/subscriptions/index.xhtml Blood (print ISSN 0006-4971, online ISSN 1528-0020), is published weekly by the American Society of Hematology, 2021 L St, NW, Suite 900, Washington DC 20036. Copyright 2011 by The American Society of Hematology; all rights reserved. From bloodjournal.hematologylibrary.org at UNIVERSITEIT ANTWERPEN on December 2, 2013. -

Acta Apostolicae Sedis
ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XXVII - SERIES II - VOL. II ROMAE TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M • DGGCG • XXXV An. et vol. XXVII 24 Ianuarii 1935 (Ser. II, v. II) - Num. 1 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. XI EPISTOLA AD R. P. D. PETRUM GERLIER, EPISCOPUM TARBIENSEM ET LAPURDENSEM, DE SUPPLICATIONIBUS LAPURDÏ INSTITUENDIS AD EXITUM ANNI IUBI LARIS. PIUS PP. XI Venerabilis frater, salutem et apostolicam bened.ictio.nem.— Quod tam alacri volentique animo amplexus es, susceptum a dilectis filiis nostris consilium, Francisco nempe S. B. E.-Card. Bourne— quem recens vita functum comploramus — ac Ioanne S. B. E. Card. Verdier, Archiepiscopo Parisiensi* celebrandi scilicet Lapurdi, proximo mense Aprili, ad prodigiàle Immaculatae Virginis specus, publicas in triduum supplicationes, ita quidem ut per tres eas dies noctesque, quibus propagatum ad universum catholicum orbem humanae Bedemptionis Iubilaeum explebitur, Eucha ristica Sacrificia perpetuo inibi continenterque agantur, id profecto conti neri non possumus quin summopere dilaudemus. Siquidem quo aptiore modo, quo digniore potest finis saecularibus hisce sollemnibus ac veluti corona imponi? Si enim tot tantaque sunt1} quae a sacratissimo Bedempto- ris nostri opere profluunt beneficia, at divina Eucharistia, mirabile illud christianae vitae quasi centrum ac ratio maxima, itemque per eam in cruento modo perennatum Calvariae Sacrificium, eiusmodi munera sunt, ut non solum maius quidquam humana cogitatione effîngi non possit, sed infinitam etiam ipsius Dei videantur explevisse potentiam, exhausisse misericordiam. Ad Augustum igitur Altaris Sacramentum, undeviginti a tanto accepto beneficio elapsis saeculis, mentem convertant pietatemque intendant 6 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale christiani omnes; per profluentes ex eo gratiae rivos labes eluant, com missa expient, ac suas, quibus tantopere premuntur, angustias aegritu- dinesque ei concredant ac confidant, qui unus potest eas lenire, relevare et ad caelestia erigere. -
Pegylated Recombinant Interferon Alpha-2B Vs Recombinant Interferon
Leukemia (2004) 18, 309–315 & 2004 Nature Publishing Group All rights reserved 0887-6924/04 $25.00 www.nature.com/leu Pegylated recombinant interferon alpha-2b vs recombinant interferon alpha-2b for the initial treatment of chronic-phase chronic myelogenous leukemia: a phase III study M Michallet1, F Maloisel2, M Delain3, A Hellmann4, A Rosas5, RT Silver6 and C Tendler7, for the PEG-Intron CML Study Group8 1Hoˆpital Edouard Herriot, Lyon, France; 2Hoˆpital Hautepierre, Strasbourg, France; 3Hoˆpital Bretonneau, Tours, France; 4Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland; 5Centro Mexico Nacional La Raza Instituto Mexicano del Seguro Social, Mexico City, Mexico; 6New York Presbyterian Hospital-Weill Cornell Medical Center, New York, NY, USA; and 7Schering-Plough, Kenilworth, NJ, USA Recombinant interferon alpha-2b (rIFN-a2b) is an effective A pegylated form of recombinant interferon alpha-2b (rIFN- therapy for chronic-phase chronic myelogenous leukemia a2b), PEG Introns (Schering-Plough Corporation, Kenilworth, (CML). Polyethylene glycol-modified rIFN-a2b is a novel for- mulation with a serum half-life (B40 h) compatible with once- NJ, USA), was developed, which contains a single polyethylene weekly dosing. This open-label, noninferiority trial randomized glycol moiety (12 000 Da average molecular weight). Pegylated 344 newly diagnosed CML patients: 171 received subcutaneous rIFN-a2b exhibits decreased clearance, increased area under the pegylated rIFN-a2b (6 lg/kg/week); 173 received rIFN-a2b (5 curve, and a significantly longer half-life (B10-fold greater) than 2 million International Units/m /day). Primary efficacy end point rIFN-a2b, and is compatible with weekly dosing.9 An increased was the 12-month major cytogenetic response (MCR) rate area under the curve in combination with prolonged tumor ( 35% Philadelphia chromosome-positive cells). -

Interreg En.Pdf
Directorate General for Programs and Agreements, European Relations and International Cooperation EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO This publication was realized in the frame of the project REACT, fi nanced by INTERACT Programme Edited by Michele Migliori Emilia-Romagna Region Directorate General for Programmes and Agreements, European Relations and International Cooperation With the technical assistance of ERVET Emilia-Romagna Region Development Agency Introduction and analysis edited by Michele Migliori Emilia-Romagna Region Claudia Ziosi ERVET - Emilia-Romagna Region Development Agency, European Union Policies and International Cooperation Unit With the support of Mario Cerè, Germana De Carli, Lodovico Gherardi, Giuliana Ventura Emilia-Romagna Region, Directorate General for Programmes and Agreements, European Relations and International Cooperation 2 Coordination and project fi ches by Lucia Calliari, Franco Cima, Roberta Pierantoni, Andrea Pignatti, Ornela Zylyfi ERVET - Emilia-Romagna Region Development Agency, European Union Policies and International Cooperation Unit We would like to thank the projects’ referents for the precious contribution We also thank the Emilia Romagna Region Photographic File, that has allowed the use of some images in this volume Translation by Maria Pia Falcone Graphic design by Avenida - MO Printed in October 2006 Preface 5 Introduction 6 1. The future 2007-2013 European territorial cooperation 7 1.1 The general framework 7 1.2 Internal cooperation 8 1.3 External cooperation 9 1.4 The 2007-2013 cooperation in the Emilia-Romagna region 10 2. The 2000-2006 INTERREG III Community Initiative 12 2.1 Cross-border cooperation 12 2.2 Transnational cooperation 12 2.3 Interregional cooperation 13 2.4 INTERACT, ESPON and URBACT programmes 13 3.