Storia Militare Contemporanea
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
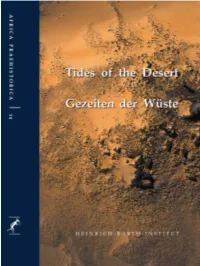
Tides-Of-The-Desert.Pdf
UNIVERSITÄT ZU KÖLN Heinrich -Barth -Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas 14 A F R I C A P R A E H I S T O R I C A Monographien zur Archäologie und Umwelt Afrikas Monographs on African Archaeology and Environment Monographies sur l'Archéologie et l'Environnement d'Afrique Herausgegeben von Rudolph Kuper KÖLN 2002 Tides of the Desert – Gezeiten der Wüste Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolph Kuper Beiträge zu Archäologie und Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von Rudolph Kuper Edited by Jennerstrasse 8 Jennerstrasse 8 comprises Tilman Lenssen-Erz, Ursula Tegtmeier and Stefan Kröpelin as well as Hubert Berke, Barbara Eichhorn, Michael Herb, Friederike Jesse, Birgit Keding, Karin Kindermann, Jörg Linstädter, Stefanie Nußbaum, Heiko Riemer, Werner Schuck and Ralf Vogelsang HEINRICH-BARTH-INSTITUT © HEINRICH-BARTH - INSTITUT e.V., Köln 2001 Jennerstraße 8, D – 50823 Köln http://www.uni-koeln.de/hbi/ Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung. CIP – Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Tides of the desert : contributions to the archaeolo- gy and environmental history of Africa in honour of Rudolph Kuper = Gezeiten der Wüste : Beiträge zu Archäologie und Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von Rudolph Kuper / Heinrich-Barth-In- stitut. Ed. by Jennerstrasse 8. - Köln : Heinrich- Barth-Inst., 2002 (Africa praehistorica ; 14) ISBN 3-927688-00-2 Printed in Germany Druck: Hans Kock GmbH, Bielefeld Typographisches Konzept: Klaus Kodalle Digitale Bildbearbeitung: Jörg Lindenbeck Satz und Layout: Ursula Tegtmeier Titelgestaltung: Marie-Theres Erz Redaktion: Jennerstrasse 8 Gesetzt in Palatino ISSN 0947-2673 Contents Prolog Jennerstrasse 8 – The Editors Eine Festschrift für Rudolph Kuper.......................... -

The Bacterial Communities of Sand-Like Surface Soils of the San Rafael Swell (Utah, USA) and the Desert of Maine (USA) Yang Wang
The bacterial communities of sand-like surface soils of the San Rafael Swell (Utah, USA) and the Desert of Maine (USA) Yang Wang To cite this version: Yang Wang. The bacterial communities of sand-like surface soils of the San Rafael Swell (Utah, USA) and the Desert of Maine (USA). Agricultural sciences. Université Paris-Saclay, 2015. English. NNT : 2015SACLS120. tel-01261518 HAL Id: tel-01261518 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01261518 Submitted on 25 Jan 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. NNT : 2015SACLS120 THESE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY, préparée à l’Université Paris-Sud ÉCOLE DOCTORALE N°577 Structure et Dynamique des Systèmes Vivants Spécialité de doctorat : Sciences de la Vie et de la Santé Par Mme Yang WANG The bacterial communities of sand-like surface soils of the San Rafael Swell (Utah, USA) and the Desert of Maine (USA) Thèse présentée et soutenue à Orsay, le 23 Novembre 2015 Composition du Jury : Mme. Marie-Claire Lett , Professeure, Université Strasbourg, Rapporteur Mme. Corinne Cassier-Chauvat , Directeur de Recherche, CEA, Rapporteur M. Armel Guyonvarch, Professeur, Université Paris-Sud, Président du Jury M. -

The Theban Desert Road Survey
oi.uchicago.edu ARCHAEOLOGY THE THEBAN DESERT ROAD SURVEY (THE LUXOR-FARSHOT DESERT ROAD SURVEY) John Coleman Darnell and Deborah Darnell During the fourth season of our desert exploration we continued to work at all of the sites and along all of the desert routes within our concession. The new name for the project reflects the growing body of evidence for the significance of this system of routes to the ascendancy of Thebes at the beginning of the Middle Kingdom and the New Kingdom. In light of the vandalism at the Wadi el-H61, and considering the impor tance of the material, the major thrust of our fourth season has been the recording of rock inscriptions and rock art in the Wadi el-H61 and at Gebel Tjauti. Gebel Antef During the fourth season of work on the Theban Desert Road Survey, we continued work in the area of the Seventeenth Dynasty chapel of Antef V, which we discovered in 1992/93. The overwhelming majority of the ceramic material examined through ran dom sampling in the vicinity of the chapel is of Middle Kingdom through early New Kingdom date. Analysis of pottery from the series of dry stone huts mapped last season has shown that they were originally in use in the Middle Kingdom, as were a number of similar structures on the cAlamat Tal Road. The Wadi el-Hdl Continued recording of the wealth of graffiti in the Wadi el-H61 was given top priority this season. The site had recently been vandalized, and a number of inscriptions de stroyed, at the time of our first visit to the site. -

The Limits of Independence
RUTH FIRST Libya The Elusive Revolution Part II: The Limits of Independence First published by Penguin Books in 1974 Republished in 2012 by the Ruth First Papers Project www.ruthfirstpapers.org.uk Part II : The Limits of Independence MEDITERRANEAN SEA / \ I \ Hummadalt AI Hamra \, Grc:al Sand Stu of Calatucia \ UAR l (EGYPT) y FEZZAN Hantj AIAifflld A \ \ I Rurrn Mur=w! e SandSta \ Total or<:or Libya r,759,ooosq. km. - -- - ---- :;....;:...- ::..:.;.- 2 Hostage to History and Geography The Ancient Greeks gave the name Libye to all North Africa west of Egypt, but for many .centuries the terms Tripoli or Barbary (after the corsairs who practised piracy in the Mediterr• anean) were used instead. It was in 1934, after the completion of the Italian conquest of Cyrenaica and Tripolitania, that the two provinces were united under Italian over-rule as the colony of Libia. The independent State that was established in 1951 kept that name as the one associated with the region from ancient times. The political divisions of the former provinces of Cyrenaica, Tripolitania, and Fezzan corresponded with the country's natural physical barriers and differences. Geography had made the ancient affiliations of the two coastal regions dissimilar - Cyrenaica's early history was influenced by Greece and Egypt, whereas Tripolitania fell under Rome and was close to Tunisia. The Arab invasions had unifying effects on the population, as did the Turkish occupation in the sixteenth century. But the three provinces were never closely unified,and successive foreign powers, whether they controlled all of modern Libya or only parts of it, generally continued to follow the natural divisions of the country in the shape of their administrations. -

Art De L'islam Et De L'inde
ART DE L'ISLAM ET DE L'INDE Mardi 7 juillet 2020 Lot 177 Vente aux enchères publiques régulée À l’étude ADER - Salle des Ventes Favart 3, rue Favart 75002 Paris Mardi 7 juillet 2020 à 14 h Exposition publique régulée À l’étude ADER 3, rue Favart 75002 Paris Lundi 6 juillet de 11 h à 18 h Mardi 7 juillet de 11 h à 12 h Expert : Marie-Christine DAVID Avec la collaboration de Camille CELIER [email protected] Tél. : 01 45 62 27 76 Responsable de la vente : Magdalena MARZEC [email protected] Tél. : 01 78 91 10 08 Téléphone pendant l’exposition : 01 53 40 77 10 Catalogue visible sur www.ader-paris.fr ART DE L'ISLAM Enchérissez en direct sur www.drouotlive.com & DE L'INDE En 1re de couverture est reproduit le lot 178 En 4e de couverture est reproduit le lot 279 TABLEAUX & DESSINS 1 CHARLES ÉMILE DE CALLANDE CHAMPMARTIN (1797-1883) Deux orientaux et leur singe Encre et aquarelle. Signée en bas à droite. 23 x 30,5 cm 800 / 1 000 € 2 2 3 2 AUGUSTE BOUCHET (1831-1889) Ville orientale animée, 1871 Aquarelle. Signée et datée en bas à droite. (Petites rousseurs.) 32 x 23 cm 300 / 400 € 3 ALEXANDRE LUNOIS (1863-1916) Femme orientale Aquarelle. Non signée. 20 x 16 cm 200 / 300 € 4 LÉON CAUVY (1874-1933) Scène de marché Eau-forte et aquatinte. Signée et numérotée sur 50. 32 x 41 cm 80 / 120 € 4 3 5 6 5 6 ÉCOLE ORIENTALISTE ÉCOLE ORIENTALISTE El Maadid, 1929 Deux femmes sur les marches Aquarelle et encre. -

Issue of US Troop Presence Spills Over Onto Iraqi Streets
UK £2 Issue 241, Year 5 EU €2.50 January 26, 2020 www.thearabweekly.com Hezbollah’s Presidential terror agenda of Tunisia’s listings PM-designate Pages 4,6 Page 9 Issue of US troop presence spills over onto Iraqi streets The anti-US demonstration, which took place after Friday prayers January 24, buttressed al-Sadr’s leadership ambitions but also showed his ambiguous position towards Tehran’s role in Iraq The Arab Weekly staff balance between the two,” Obeidy said in comments broadcast by Iraqi state TV. London Experts see al-Sadr playing a new risky role by defending Tehran’s he controversy of US troops agenda in Baghdad and associating deployed in Iraq spilled onto himself closely with pro-Iran Iraqi Iraqi streets after support- militias. T ers of influential Shia cleric The protests seemingly upended Muqtada al-Sadr rallied in Baghdad attempts by Iraqi President Bar- demanding the end of America’s ham Salih and US President Donald military presence. Trump to smooth out differences Hundreds of thousands of pro- during a meeting at Davos. testers attended what al-Sadr had “We are obviously working on a dubbed a “million-man march” lot of things together. We’re working seeking the withdrawal of US troops on military. We’re working on [the from Iraq. “Get out, occupier,” pro- Islamic State] ISIS. We have a whole testers chanted as they marched host of very difficult things to dis- through Baghdad’s streets, “Yes to cuss and some very positive things sovereignty.” also. And we’ve been friends and the Although the initial protests were relationship is very good,” Trump peaceful, at least two protesters was quoted in a January 22 White were killed and 25 injured in clashes House statement as saying. -

A Barren Legacy? the Arabian Desert As Trope in English Travel Writing, Post-Thesiger
A Barren Legacy? The Arabian Desert as Trope in English Travel Writing, Post-Thesiger Jenny Owen A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Nottingham Trent University for the degree of Doctor of Philosophy March 2020 Note on Copyright This work is the intellectual property of the author. You may copy up to 5% of this work for private study, or personal, non-commercial research. Any re-use of the information contained within this document should be fully referenced, quoting the author, title, university, degree level and pagination. Queries or requests for any other use, or if a more substantial copy is required, should be directed to the owner of the Intellectual Property Rights. Contents Abstract ....................................................................................................................... 3 Acknowledgements ..................................................................................................... 4 Introduction: Arabia, the Land of Legend ................................................................ 5 Locating Arabia ................................................................................................... 11 Studying Arabia as a country of the mind ............................................................. 18 The Lawrence and Thesiger legacy ...................................................................... 22 Mapping the thesis: an outline of the chapters ...................................................... 27 1. In Literary Footsteps: The Prevalence of -

Western Uzbekistan Water Supply System Development Project
Initial Environmental Examination Document stage: Final version Project number: September 2017 Republic of Uzbekistan: Western Uzbekistan Water Supply System Development Project Prepared by the Communal Services Agency of the Republic of Uzbekistan “KOMMUNKHIZMAT” for thО Asian DОvОlopmОnt Bank (ADB) This report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB Board of Directors or staff, and may be preliminary in nature. TABLE OF CONTENTS GLOSSARY.............................................................................................................................. 5 EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................... 6 1. INTRODUCTION .............................................................................................................. 13 2. POLICY, LEGAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK AND STANDARDS .... 14 2.1. Institutional set up of water supply and environmental sectors ..................... 14 2.1.1. Institutional set up of water supply sector ................................................. 14 2.1.2. Institutional set up of environmental protection ........................................ 17 2.2. Policy and Legal Framework ............................................................................... 18 2.2.1 ADB Safeguards Policy ................................................................................ 18 2.2.2 National Environmental Regulatory Framework ...................................... -

Prehistoric Rock Art Research in the Western Desert of Egypt Heiko Riemer, University of Cologne, Germany
Prehistoric Rock Art Research in the Western Desert of Egypt Heiko Riemer, University of Cologne, Germany During the most recent past there has been Introduction an enormous increase in the discovery of new rock art sites in the Western Desert, The following paper will focus on two aspects: which goes along with the growing tourism First, it will argue from the most recent de- in this area. However, in contrast to this, velopment as to why rock art research in the Egyptian rock art in the Western Desert has Western Desert is a desideratum and therefore not been properly recognized as a rich and most pressing in any future perspectives of important archive by specialists in the field professional archaeological work in this area. of rock art research. This does not mean This aspect is the major conclusion of the pa- that surveys on rock art do not exist from per, but stands at the beginning, as it introdu- the area west of the Nile, but the Western ces the state of art that forms the basis of any Desert rock art is generally less well-studied overview in the fi eld of rock art research. Se- than the vivid rock paintings of the central cond, the paper will introduce what we know Sahara or the depictions of the Eastern De- about Western Desert rock art viewed from ar- sert and the Nubian Nile Valley. What can chaeological research that aims at the recons- be summarized about the present state in truction of cultural chronologies and socio- rock art research is a frame of reference, in economic developments during the Holocene. -
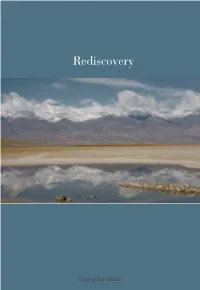
The California Deserts: an Ecological Rediscovery
3Pavlik-Ch1 10/9/07 6:43 PM Page 15 Rediscovery Copyrighted Material 3Pavlik-Ch1 10/9/07 6:43 PM Page 16 Copyrighted Material 3Pavlik-Ch1 10/9/07 6:43 PM Page 17 Indians first observed the organisms, processes, and history of California deserts. Over millennia, native people obtained knowledge both practical and esoteric, necessitated by survival in a land of extremes and accumulated by active minds recording how nature worked. Such knowledge became tradition when passed across generations, allowing cul- tural adjustments to the changing environment. The depth and breadth of their under- standing can only be glimpsed or imagined, but should never be minimized. Indians lived within deserts, were born, fed, and raised on them, su¤ered the extremes and uncertainties, and passed into the ancient, stony soils. Theirs was a discovery so intimate and spiritual, so singular, that we can only commemorate it with our own 10,000-year-long rediscov- ery of this place and all of its remarkable inhabitants. Our rediscovery has only begun. Our rediscovery is not based upon living in the deserts, despite a current human pop- ulation of over one million who dwelling east of the Sierra. We do not exist within the ecological context of the land. We are not dependant upon food webs of native plants and [Plate 13] Aha Macav, the Mojave people, depicted in 1853. (H. B. Molhausen) REDISCOVERY • 17 Copyrighted Material 3Pavlik-Ch1 10/9/07 6:43 PM Page 18 Gárces 1776 Kawaiisu Tribal groups Mono Mono Tribe Lake Aviwatha Indian place name Paiute Inyo Owens Valley -

Fall 2014, Volume 33.2
The Bi-Annual Journal of Desert Survivors Experience • Share • Protect Fall 2014 33.2 FROM THE EDITOR: Since the publication of the last issue of The Survivor the U.S. Court of Appeals issued a ruling on the lawsuit to stop implementation of the Bureau of Land Management (BLM) plan to open large areas of The Journal of Desert Survivors - Experience. Share. Protect. protected desert sand dunes in Imperial County for off-highway- vehicles (OHVs). The decision went against the four environmen- Desert Survivors is an affiliation of desert lovers committed to experiencing, tal groups—led by the Center for Biological Diversity and includ- sharing and protecting desert wilderness wherever we find it. We recognize ing Desert Survivors—that were attempting to keep the Algodones the places we love to explore will not remain wild unless we give others the Dunes protected as wilderness. Within weeks of the ruling OHV opportunity to experience them as we do and unless we remain vigilant and enthusiasts removed the wilderness boundary markers in the dunes active in our efforts to monitor and preserve them. and 40,000 acres of pristine wilderness are now open to dune buggy, dirt-bike and quad-drive mayhem. There is a horror show of competing and conflicting entities out there, Of course, this ruling was deeply disappointing to Desert Survivors. A all with ideas as to how the BLM should do its job. The agency has key component of our mission is to protect deserts as wilderness. We satisfy an ambitious mandate in the face of budget cuts, hiring freez- feel that activities such as mining, grazing, expanded vehicle access, es, sequestrations and a Republican party ideologically committed to suburbanization, power corridors, industrial solar plants and military abolishing it. -

The AAF in Northwest Africa
DISTRIBUTION STATEMEFNT A Approved for Public Release Distribution Unlimited Wings at War Series, No. 6 The AAF in Northwest Africa AN ACCOUNT OF THE TWELFTH AIR FORCE IN THE NORTHWEST AFRICAN LANDINGS AND THE BATFLE FOR TUNISIA An Interim Report Published by Headquarters, Army Air Forces Washington, D. C. Office of Assistant Chief of Air Staff, Intelligence New Imprint by the Center for Air Force History Washington- D- C- 1992 20050429 005 Wings at War COMMEMORATIVE EDITION Originally published shortly after key air campaigns, the Wings at War series captures the spirit and tone of America's World War II experience. Eyewitness accounts of Army Air Forces' aviators and details from the official histories enliven the story behind each of six important AAF operations. In coopera- tion with the Office of the Secretary of Defense, the Center for Air Force History has reprinted the entire series to honor the airmen who fought so valiantly fifty years ago. ,.' Celtrfor Air Force History Washington, D.C. DOCUMENTATION PAGE Form Approved REPORT OMB No. 0704-0188 The public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, Including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing the burden, to Department of Defense, Washington Headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports (0704-0188), 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302.