25 V.Inc.A.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

I TARTUFINI DI PAPOZZE Una Tradizione Che Continua
I Quaderni dell’Accademia del tartufo del Delta del Po n.22 I TARTUFINI DI PAPOZZE Una tradizione che continua A cura di Antonio Dimer Manzolli Famiglia Vicentini: una tradizione centenaria La storia inizia a Santa Maria in Punta, l’antica Santa Maria del Traghetto, in comune di Ariano nel Polesine, piccola e suggestiva località che sorge proprio all’inizio dell’isola di Ariano dove il Po Grande o Po di Venezia da vita al primo ramo del Delta, il Po di Goro lungo il quale corre il confine tra il Veneto e l’Emilia Romagna. Qui viveva la famiglia Vicentini, in seguito trasferitasi a Curicchi in comune di Papozze. Dire che era una famiglia di esperti tartufino, che si tramandava quest’arte di padre in figlio, è, a dir poco, riduttivo poiché i Vicentini erano anche esperti barcari e abili pescatori di storioni. Lo storione, preda prediletta dei pescatori più abili, non viveva soltanto dove il fiume Po si abbraccia con il mare Adriatico, la cui pesca ha ispirato il celebre romanzo di Gianantonio Cibotto “Scano Boa”, da cui è stato tratto l’omonimo film di Renato Dall’Ara con Alain Cuny e Carla Gravina, ma risaliva per chilometri il corso del fiume e diventava oggetto di caccia dei pescatori soprattutto durante le piene del fiume con le acque torbide. La nostra storia inizia con nonno Sante (1874-1958), esperto pescatore e tartufino, che ha trasmesso l’arte al figlio Gennaro. Gennaro Vicentini era veramente un grande esperto sia nella cerca che nell’addestramento dei cani. Quando usciva di buonora difficilmente tornava a casa senza tartufo, le sue aree preferite erano le golena e le campagne dell’isola di Ariano. -

ТB 1. Plants of Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach
2000L0029 — EN — 14.04.2006 — 013.001 — 54 ¼B ANNEX III PART A PLANTS, PLANT PRODUCTS AND OTHER OBJECTS THE INTRODUCTION OF WHICH SHALL BE PROHIBITED IN ALL MEMBER STATES Description Country of origin 1. Plants of Abies Mill., Cedrus Trew, Non-European countries Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. and Tsuga Carr., other than fruit and seeds 2. Plants of Castanea Mill., and Quercus Non-European countries L., with leaves, other than fruit and seeds 3. Plants of Populus L., with leaves, other North American countries than fruit and seeds ¼M12 ¼B 5. Isolated bark of Castanea Mill. Third countries 6. Isolated bark of Quercus L., other than North American countries Quercus suber L. 7. Isolated bark of Acer saccharum Marsh. North American countries 8. Isolated bark of Populus L. Countries of the American continent 9. Plants of Chaenomeles Ldl., Cydonia Non-European countries Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., and Rosa L., intended for planting, other than dormant plants free from leaves, flowers and fruit 9.1. Plants of Photinia Ldl., intended for USA, China, Japan, the Republic of Korea planting, other than dormant plants free and Democratic People's Republic of from leaves, flowers and fruit Korea 10. Tubers of Solanum tuberosum L., seed Third countries other than Switzerland potatoes 11. Plants of stolon- or tuber-forming species Third countries of Solanum L. or their hybrids, intended for planting, other than those tubers of Solanum tuberosum L. as specified under Annex III A (10) 12. Tubers of species of Solanum L., and Without prejudice to the special require- their hybrids, other than those specified ments applicable to the potato tubers listed in points 10 and 11 in Annex IV, Part A Section I, third coun- tries other than Algeria, ºA1 ÄEgypt, Israel, Libya, ºA1 ÄMorocco, Syria, Switzerland, Tunisia and Turkey, and other than European third countries which are either recognised as being free from Clavibacter michiganensis ssp. -

3B2 to Ps.Ps 1..9
2001L0032 — EN — 28.03.2003 — 002.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COMMISSION DIRECTIVE 2001/32/EC of 8 May 2001 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community and repealing Directive 92/76/EEC (OJ L 127, 9.5.2001, p. 38) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Commission Directive 2002/29/EC of 19 March 2002 L 77 26 20.3.2002 ►M2 Commission Directive 2003/21/EC of 24 March 2003 L 78 8 25.3.2003 2001L0032 — EN — 28.03.2003 — 002.001 — 2 ▼B COMMISSION DIRECTIVE 2001/32/EC of 8 May 2001 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community and repealing Directive 92/76/EEC THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (1), and in particular the first subparagraph of Article 2(1)(h) thereof, Having regard to the requests made by Denmark, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Austria, Portugal, Finland, Sweden and the United Kingdom, Whereas: (1) Under the provisions of Directive 2000/29/EC, ‘protected zones’ exposed to particular plant health risks may be defined and therefore may be accorded special protection under conditions compatible with the internal market. Such zones were defined in Commission Directive 92/76/EEC of 6 October 1992, recog- nising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community (2) as last amended by Directive 2000/23/ EC (3). -

Scheda Percorso 4
Percorsi di mobilità lenta PERCORSO 4 Sinistra Po Elaborazione: T.E.R.R.A. Consulting srl Dati percorso Dati percorso Comuni Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Calto, Salara, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, Canaro, Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Villanova Località di Melara attraversati: Marchesana, Papozze, Adria, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle partenza: Elementi di Località di arrivo: Porto Tolle golena lungo il Po a Bergantino; golena Cibo a Castelnovo Bariano; isola Tontola a Ficarolo; golena Quarti a Guarda Veneta;golena lungo il Po a Crespino; golena di interesse (località Pila) Panarella a Papozze; conca di Volta Grimana a Loreo; golena Madonnina a Porto Viro; valli da pesca a Porto Viro e a Porto Tolle, isola della Batteria a Porto Tolle naturalistico: Lunghezza: 140,4 Km Elementi di Museo della Civiltà Contadina “Bragazzi”, chiese e monumenti storici nel centro di Melara; Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare, chiesa di San Giorgio Tipo di fondo: 96,7% asfalto, interesse e palazzi nel centro storico di Bergantino; chiesa Parrocchiale a Castelnovo Bariano; chiesa di Santo Stefano e edifici storici a Castelmassa; chiesa di San Rocco e 3,3% sterrato storico- villa Fioravanti a Calto; chiese e villa Schiatti Giglioli a Ficarolo; villa Manfredini Stampanoni e chiesa di San Giuseppe a Gaiba; villa Camerini Bertelè ora Bonfiglioli Strade a scarso 70,5% culturale: a Boaria Gilliola; Chiesa di Santo Stefano Martire e villa Masi Roveroni a Stienta; chiesa di San Lorenzo a Occhiobello; chiesa di Santa -

The Oxfordian Volume 21 October 2019 ISSN 1521-3641 the OXFORDIAN Volume 21 2019
The Oxfordian Volume 21 October 2019 ISSN 1521-3641 The OXFORDIAN Volume 21 2019 The Oxfordian is the peer-reviewed journal of the Shakespeare Oxford Fellowship, a non-profit educational organization that conducts research and publication on the Early Modern period, William Shakespeare and the authorship of Shakespeare’s works. Founded in 1998, the journal offers research articles, essays and book reviews by academicians and independent scholars, and is published annually during the autumn. Writers interested in being published in The Oxfordian should review our publication guidelines at the Shakespeare Oxford Fellowship website: https://shakespeareoxfordfellowship.org/the-oxfordian/ Our postal mailing address is: The Shakespeare Oxford Fellowship PO Box 66083 Auburndale, MA 02466 USA Queries may be directed to the editor, Gary Goldstein, at [email protected] Back issues of The Oxfordian may be obtained by writing to: [email protected] 2 The OXFORDIAN Volume 21 2019 The OXFORDIAN Volume 21 2019 Acknowledgements Editorial Board Justin Borrow Ramon Jiménez Don Rubin James Boyd Vanessa Lops Richard Waugaman Charles Boynton Robert Meyers Bryan Wildenthal Lucinda S. Foulke Christopher Pannell Wally Hurst Tom Regnier Editor: Gary Goldstein Proofreading: James Boyd, Charles Boynton, Vanessa Lops, Alex McNeil and Tom Regnier. Graphics Design & Image Production: Lucinda S. Foulke Permission Acknowledgements Illustrations used in this issue are in the public domain, unless otherwise noted. The article by Gary Goldstein was first published by the online journal Critical Stages (critical-stages.org) as part of a special issue on the Shakespeare authorship question in Winter 2018 (CS 18), edited by Don Rubin. It is reprinted in The Oxfordian with the permission of Critical Stages Journal. -

Allegato 13 Al Programma Di Sviluppo Rurale Per Il Veneto 2007-2013
ALLEGATO 13 AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 ELENCO DELLE "AREE BIANCHE" RICADENTI NELLE ZONE RURALI C e D DEL VENETO Classe rurale DENOMINAZIONE AREA PROVINCIA COMUNE del comune ARSIE' Belluno Arsiè D FASTRO Belluno Arsiè D ROCCA Belluno Arsiè D LIGONTO Belluno Auronzo di Cadore D MISURINA P. Belluno Auronzo di Cadore D BOLZANO BELLUN. Belluno Belluno D NEVEGAL Belluno Belluno D LAMOSANO Belluno Chies d'Alpago D CIBIANA Belluno Cibiana di Cadore D CANDIDE Belluno Comelico Superiore D PADOLA Belluno Comelico Superiore D DANTA Belluno Danta di Cadore D CAVIOLA Belluno Falcade D SPERT Belluno Farra d'Alpago D VILLABRUNA Belluno Feltre D GOSALDO Belluno Gosaldo D COL CUGNAN Belluno Ponte nelle Alpi D RIVAMONTE Belluno Rivamonte Agordino D SOTTOGUDA Belluno Rocca Pietore D S.GREGORIO Belluno San Gregorio nelle Alpi D S.PIETRO Belluno San Pietro di Cadore D S.TOMASO Belluno San Tomaso Agordino D AUNE Belluno Sovramonte D SOVRAMONTE Belluno Sovramonte D TAMBRE Belluno Tambre D S.ANTONIO T. Belluno Trichiana D VIGO DI C. Belluno Vigo di Cadore D VODO Belluno Vodo Cadore D FRASSENE' Belluno Voltago Agordino D VOLTAGO Belluno Voltago Agordino D FUSINE Belluno Zoldo Alto D ARQUA' Padova Arquà Petrarca C VALBONA Padova Lozzo Atestino C BASTIA Padova Rovolon C BOTTRIGHE Rovigo Adria C CROCIARONE Rovigo Ariano nel Polesine C BERGANTINO Rovigo Bergantino C CALTO Rovigo Calto C CANARO Rovigo Canaro C BRESSANE Rovigo Castelguglielmo C CASTELGUGLIELMO Rovigo Castelguglielmo C S.PIETRO P. Rovigo Castelnovo Bariano C CENESELLI Rovigo Ceneselli C PEZZOLI Rovigo Ceregnano C CORBOLA Rovigo Corbola C COSTA DI RO. -

Stienta Villanova Del Ghebbo Rovigo
ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di STIENTA , VILLANOVA DEL GHEBBO , ROVIGO , ed in collaborazione con il Comitato Provinciale di ROVIGO , tre Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità. STIENTA VILLANOVA ROVIGO DEL GHEBBO 29 Maggio 2018 16 Ottobre 2018 6 Novembre 2018 Sala Polivalente “P. Rovigatti” Sala Cinema Ridotto del Teatro Sociale Via Gramsci, 75 Via Sabbioni Piazza Garibaldi, 14 X Convegno Regionale del Veneto Pedavena (BL) - 10 Maggio 2018 Viale Vittorio Veneto, 76 Stienta, 29 Maggio 2018 Ore 14.30 • Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti Ore 14.45 IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI PER AFFRONTARE SITUAZIONI IN COSTANTE AUMENTO • Differenza tra acquisto di cittadinanza e riconoscimento del possesso ininterrotto • La procedura della circolare k 28.1/1991: la competenza dell’ufficiale di stato civile • I documenti allegati all’istanza: verifiche ed acquisizioni da parte dell’ufficiale di stato civile • La discendenza per linea materna o paterna: filiazione nel matrimonio o fuori del matrimonio • Requisiti sostanziali, preavviso di rigetto e rifiuto del riconoscimento • La conclusione del procedimento: la trascrizione dell'atto di nascita e adempimenti conseguenti • L'accertamento eseguito dai consolati e la trasmissione degli atti per la trascrizione • L’accertamento eseguito dal Tribunale e la trasmissione degli atti per la trascrizione Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA Ore 17.30 • Quesiti -

Villadose Provincia Di Rovigo
Comune di Villadose Provincia di Rovigo VILLADOSE RAPPORTO COMUNALE SULL’ECONOMIA Anno 2020 Dicembre 2020 Questo Rapporto offre una fotografia sintetica della struttura economica del comune analizzando dati sul mondo imprenditoriale, sul mercato del lavoro e sui redditi dei contribuenti. Per presentare il maggior numero di informazioni sono stati elaborati dati a partire da tre fonti che permettono di analizzare il livello comunale e valorizzano aspetti differenti della situazione economica. Dove possibile sono stati condotti confronti con la zona d’appartenenza del comune e con la provincia. Il rapporto è diviso in sezioni in base all’oggetto dell’analisi: ● Sezione 1. Imprese attive nel comune (Fonte A.S.I.A. - Istat). Analisi delle imprese per macro settore di attività economica e degli addetti, anni dal 2014 al 2018 ………..…………... pag. 3 ● Sezione 2. Localizzazioni attive nel comune (Fonte C.C.I.A.A Delta Lagunare - Infocamere). Analisi delle unità locali attive e degli addetti, anni dal 2015 al 2019 ………………….. pag. 7 ● Sezione 3. Reddito dei contribuenti del comune (Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze). Analisi dei redditi dei contribuenti per tipologia e fascia di reddito, anni dal 2013 al 2018 ……………………………………………………………………………………………. pag. 10 A cura dell’Ufficio di Coordinamento Statistica Provincia di Rovigo via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - Rovigo tel. 0425 386261/266; fax 0425 386250 posta elettronica: [email protected] riferimento del Comune: [email protected] La somma delle percentuali in alcuni grafici potrebbe non essere pari a 100 a causa di arrotondamenti automatici del programma. © 2020 Provincia di Rovigo È autorizzata la riproduzione parziale o totale del presente fascicolo con la citazione della fonte. -

Commission Directive 2004/70/EC Amending Council Directive 2000
29.4.2004 EN Official Journal of the European Union L 127/97 COMMISSION DIRECTIVE 2004/70/EC of 28 April 2004 amending Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (Text with EEA relevance) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (6) By the Act of Accession of 2003, Malta was granted the status of a protected zone as regards Citrus tristeza virus (European strains) for a limited period of time expiring Having regard to the Treaty establishing the European on 31 March 2006. It is appropriate to amend the text Community, of Annex IV to reflect the changes made by the Act of Accession. Having regard to Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 (7) In the interest of clarity it is appropriate to combine in on protective measures against the introduction into the Com- one text some of the amendments made since 1 munity of organisms harmful to plants or plant products and November 2002. An appropriate period should be given against their spread within the Community (1), and in particular for the Member States to implement those provisions of points (c) and (d) of the second paragraph of Article 14 this Directive which do not reflect existing legislation. thereof, (8) Directive 2000/29/EC should, therefore, be amended accordingly. Whereas: (9) The measures provided for in this Directive are in (1) Article 20 of the Act of Accession of 2003, refers to accordance with the opinion of the Standing Committee Annex II to that Act, which contains adaptations to the on Plant Health, acquis required by accession. -

Ambito 26 Basso Polesine (RO) Ambiti Territoriali Per La Mobilità 2016/17 - Comma 66 Art
Ambito 24 Alto Polesine (RO) Ambito 25 Medio Polesine (RO) Ambito 26 Basso Polesine (RO) Ambiti territoriali per la mobilità 2016/17 - comma 66 art. 1 Legge 107/2015 Tipo dim. Codice istituto Denominazione istituto Comune Indirizzo Con plessi nei comuni di istituto Provincia di Rovigo Ambito 24 Alto Polesine (RO) IC ROIC816004 BADIA POLESINE BADIA POLESINE PIAZZA MARCONI 192 IC ROIC80000E CASTELMASSA CASTELMASSA VIA MATTEOTTI, 30 BERGANTINO; CASTELNUOVO BARIANO; CENESELLI; MELARA IC ROIC811001 COSTA DI ROVIGO COSTA DI ROVIGO VIA VITTORIO EMANUELE II, 204 ARQUA' POLESINE; VILLAMARZANA IC ROIC810005 FIESSO UMBERTIANO FIESSO UMBERTIANO VIA VERDI,194 CASTELGUGLIELMO; SAN BELLINO IC ROIC81200R FRATTA POLESINE FRATTA POLESINE VIA ROMA, 49 PINCARA; VILLANOVA DEL GHEBBO IC ROIC81700X LENDINARA LENDINARA VIA G. MARCONI 36 LUSIA IC ROIC803002 OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO VIA M.L.KING N.3 CANARO IC ROIC823007 IC STIENTA STIENTA VIA MAFFEI, 195 FICAROLO; GAIBA; SALARA IC ROIC809001 TRECENTA TRECENTA VIA E.DE AMICIS,135 BAGNOLO DI PO; GIACCIANO CON BARUCHELLA IIS ROIS00700D I.I.S. "PRIMO LEVI" BADIA POLESINE VIA MANZONI, 191 IIS ROIS003006 I.I.S. "BRUNO MUNARI" - CASTELMASSA CASTELMASSA VIA MATTEOTTI, 34 BADIA POLESINE; TRECENTA Ambito 25 Medio Polesine (RO) IC ROIC808005 POLESELLA POLESELLA VIA G.GARIBALDI, 416 BOSARO; CRESPINO; GUARDA VENETA; PONTECCHIO POLESINE IC ROIC81900G ROVIGO 4 ROVIGO VIA MOZART, 8 IC ROIC82000Q ROVIGO 1 ROVIGO VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 IC ROIC82100G ROVIGO 2 ROVIGO VIA F. CORRIDONI, 40 IC ROIC82200B ROVIGO 3 ROVIGO VIA F. CORRIDONI N.40 IC ROIC807009 ISTITUTO COMPRENSIVO VILLADOSE VILLADOSE VIA DELLA PACE, 22 CEREGNANO; GAVELLO; SAN MARTINO DI VENEZZE CPIA ROMM052008 CPIA DI ROVIGO ROVIGO VIA W.MOZART, 8 ADRIA; CASTELMASSA I.MAG. -
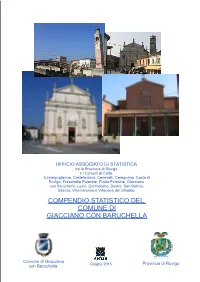
Compendio Statistico Del Comune Di Giacciano Con
UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA tra la Provincia di Rovigo e i Comuni di Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia, Occhiobello, Salara, San Bellino, Stienta, Villamarzana e Villanova del Ghebbo COMPENDIO STATISTICO DEL COMUNE DI A cura dell’Ufficio di Coordinamento Statistica Provincia di Rovigo—Responsabile: Cinzia Viale Referente Statistico Comunale: Rosella Navari ([email protected]) GIACCIANO CON BARUCHELLA Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - Rovigo Tel. 0425 386557/261; fax 0425 386250 Posta elettronica: [email protected] Si ringraziano le seguenti Aree della Provincia di Rovigo: Area Personale e Lavoro, Area Servizi alla persona, Area Ambiente. Si ringrazia inoltre: Aquaprogram srl, Arpav, Bioprogramm scrl di Padova, CCIAA di Rovigo, Comuni Polesani, ISTAT, Polesine Acque © 2015 Provincia di Rovigo È autorizzata la riproduzione parziale o totale del presente fascicolo con la citazione della fonte. I dati contenuti nei precedenti rapporti che non concordano con quelli del presente si intendono rettificati. La somma delle percentuali (espresse con un solo decimale) in alcuni grafici potrebbe non essere 100 a causa di arrotondamenti automatici del programma. I dati contenuti nel compendio sono riferiti al comune, se non diversamente specificato Comune di Giacciano Provincia di Rovigo con Baruchella Giugno 2015 POPOLAZIONE Popolazione residente complessiva e incidenza percentuale della popolazione straniera. Anni 2005-2014, al 31/12 di ogni anno (2011* Censimento) 2.500 2.000 2.286 2.304 2.267 2.291 2.236 2.246 2.182 2.167 2.173 2.170 1.500 11,0 10,5 1.000 9,7 9,7 9,6 9,1 10,2 8,0 8,8 6,5 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Residenti stranieri Totale residenti Fonte: Elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat (2005-2013); Ufficio Anagrafe comunale (2014) Famiglie residenti e numero medio di componenti. -

Plant Quarantine (Harmful Organisms) Regulations, 2004
B 873 Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 17,543, 24 ta’ Frar, 2004 Taqsima B –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– L.N. 97 of 2004 PLANT QUARANTINE ACT, 2001 (ACT NO. XI OF 2001) Plant Quarantine (Harmful Organisms) Regulations, 2004 IN exercise of the powers conferred by article 32 of the Plant Quarantine Act 2001, the Minister for Rural Affairs and the Environment has made the following regulations>- 1. The title of these regulations is the Plant Quarantine (Harmful Title and Organisms) Regulations, 2004 and they shall come into force on the 1st commencement. April, 2004. 2. (a) The scope of these regulations is to make provision to Scope and safeguard against the introduction and spread in Malta of harmful applicability. organisms. (b) These regulations shall apply to any movement and introduction of plant, plant products and other objects specified in these regulations whether within or into Malta. 3. (a) In these regulations, unless the context otherwise requires> Interpretation. “the Act” means the Plant Quarantine Act< “the Commission” means the Commission of the European Community< “the Community” means the European Community< “consignment” means a quantity of goods covered by a single document required either for customs formalities on entering Malta or for other formalities for internal movement, and includes a single phytosanitary certificate and a single alternative document or mark< a consignment may comprise of one or more lots< “export” means the export of goods to third countries<