Breve Biografia Di Edoardo Amaldi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fermi-Glast Rome U. Amaldi 9.5.11.Ppt
INFLUENCE OF FERMI AND HIS ROMAN GROUP ON NUCLEAR AND MEDICAL PHYSICS Ugo Amaldi Universitày Milano Bicocca and TERA Foundation Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 1 Photo of a photo Enrico Fermi at 36 Edoardo Amaldi at 80 1936 1988 Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 2 The discovery of neutron induced radioactivity Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 3 January-March 1934 1933 Christmas holidays: Enrico Fermi and the other “ragazzi di Via Panisperna” at Santa Cristina March 1934: The Joliot-Curies discover artificial radioactivity induced by alfa particles The Institute of Via Panisperna Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 4 1934 : Fermi discovery was made with a Be-Rn source. Radon extracted at Laboratorio Fisico della Sanità Pubblica The “Divine Providence” Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 5 The third paper iodine isotopes used in nuclear medicine Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 6 The efficacy of slow neutrons Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 7 October 20, 1934 Rome - 9.5.11 - U. Amaldi 8 October 1934: discovery of artificial radioactivity induced by slow neutrons Discovery: Saturday 20.10.34 (*) First paper: Monday 22.10.34 Patent: Friday 26.10.34 (*) A. De Gregorio : not on October 22! O. D’Agostino E. Segrè E. Amaldi F. Rasetti E. Fermi Rome - 9.5.11 - U. Amaldi + B. Pontecorvo = The boys of Via Panisperna9 Writing the paper Emilio Segrè: “Enrico Fermi physicist” – 1970 Fermi dictated while I wrote. He stood by me; Rasetti, Amaldi and Pontecorvo paced the room excitedly, all making comments at the same time. The din was such that when we left, Amaldi’s maid discreetly asked whether the evening guests were tipsy. -

The Accademia Nazionale Dei Lincei Founded in 1603, the Accademia
THE XXI EDOARDO AMALDI CONFERENCE INTERNATIONAL COOPERATION FOR ENHANCING NUCLEAR SAFETY, SECURITY, SAFEGUARDS AND NON-PROLIFERATION ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI ROME, 7 – 8 OCTOBER 2019 ITALY The Accademia Nazionale dei Lincei Founded in 1603, the Accademia Nazionale dei Lincei is the oldest academy in the world which included, among many other prestigious names, Galileo Galilei. The Accademia Nazionale dei Lincei is within the sphere of the Italian Ministry of Cultural Heritage and is considered the highest Italian cultural institution. The Accademia Nazionale dei Lincei is a scientific consultant to the President of the Italian Republic and has recently been granted his High Permanent Patronage. The Accademia Nazionale dei Lincei mission is to promote, coordinate, integrate and spread scientific knowledge in its highest expressions, in the frame of cultural unity and universality. To this end, the Accademia Nazionale dei Lincei organises national and international conferences, meetings and seminars. The United States National Academy of Sciences Established by an Act of Congress signed by President Abraham Lincoln in 1863, the National Academy of Sciences is charged with providing independent, objective advice to the nation on matters related to science and technology. The National Academy of Sciences is committed to furthering science in America, and its members are active contributors to the international scientific community. Nearly 500 members of the National Academy of Sciences have won Nobel Prizes, and the Proceedings of the National Academy of Sciences, founded in 1914, is today one of the premier international journals publishing the results of original research. The National Academy of Sciences also encourage education and research, recognize outstanding contributions to knowledge, and increase public understanding in matters of science. -

IRPS Home Page
IRPS Home Page ARCHIVE EDITION OF IRPS BULLETIN Volume 19 No 1 June, 2005 Office Bearers : 2003 - 2006 Editorial President's Report Member's Paper Member's Report Junior Radiation Physics Medal Awards : Abstracts from Papers Return to Archive Home Page file:////warsaw/www/irps/archives/vol19no1/welcome.html [19/09/2013 3:01:07 PM] Untitled OFFICE BEARERS : 2003 - 2006 President: Regional Vice Executive Presidents: Councillors: R.H. Pratt Dept. of Physics North America: P. Bergstrom (U.S.A.) Univ Pittsburgh, PA J. Hubbell (USA) 15260 USA L. South and Central Gerward (Denmark) Secretariat: America: J.E. Fernandez (Italy) D.A. Bradley A. Paschoa (Brazil) R.T. School of Physics, Mainardi (Argentina) University of Exeter Africa and Middle East: Stocker Road J. O'Meara (Canada) Exeter EX4 4QL UK D.T.L. Jones (South K. Singh Thind (India) Africa) Treasurer: D. McLean (Australia) East Europe A. Ljubicic L. Musilek (Czech Rudjer Boskovic Institute T. Nakamura (Japan) Republic) Bijenicka 54 Zagreb 41000 Croatia F.S.U A.V. Korol (Russia) Chair, Advisory Board Western Europe: M.J. Cooper Department of Physics M.J. Farquharson (U. University of Warwick K.) Coventry CV4 7AL U.K. S.E. Asia : S.C. Roy (India) Australasia : D.C. Creagh (Australia) North East Asia: Luo Zhengming (PR China) EDITORIAL BOARD Editor : P.M. Bergstrom (U.S.A.) Editorial Committee : D.C. Creagh (Australia) S.A. McKeown (Australia) file:////warsaw/www/irps/archives/vol19no1/officers.html (1 of 2) [19/09/2013 3:01:07 PM] Untitled Home Page file:////warsaw/www/irps/archives/vol19no1/officers.html (2 of 2) [19/09/2013 3:01:07 PM] Untitled EDITORIAL Welcome to Vol. -

ILC Newsline
Director's Corner 20 November 2008 The legacy of Edoardo Amaldi Edoardo Amaldi was one of the giants who shaped our field. He was celebrated last month at the University of Rome on the 100th anniversary of his birth in the inspiring meeting “The Legacy of Edoardo Amaldi in Science and Society.” I was honoured to be invited to speak about international collaboration in physics, an area where Amaldi led the way, especially for his role in the creation and development of CERN. In fact, his impact on physics and society was far broader than his contributions to particle physics alone: they also include his scientific contributions and leadership in nuclear physics, gravitational wave research and astrophysics. Moreover, he worked to protect human rights, and more generally was committed to promoting Barry Barish peace and to controlling the proliferation of nuclear weapons. Edoardo Amaldi was born in Italy in 1908 to a famous mathematician father. He became interested in studying physics while he was a high school student and eventually became a student under Orso Mario Corbino, working under the guidance of the young Enrico Fermi. Fermi had already obtained a chair in theoretical physics and went on to win the Nobel Prize in 1938. Amaldi became part of Fermi's exceptional group at the University of Rome that included Emilio Segrè, Franco Rasetti, Ettore Majorana and Bruno Pontecorvo. Amaldi's most important work before World War II involved neutron scattering off matter. Throughout his career, he made significant and most impressive contributions to a wide range of fields of physics. -

Italian Physicists of All Times: a Biographical Dictionary in Preparation
IL NUOVO CIMENTO 42 C (2019) 239 DOI 10.1393/ncc/i2019-19239-x Communications: SIF Congress 2018 Italian physicists of all times: A biographical dictionary in preparation A. La Rana(1)(2) (1) Centro Fermi, Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” - Rome, Italy (2) Dipartimento di Fisica, Sapienza Universit`adiRoma-Rome,Italy received 26 February 2019 Summary. — This paper describes the historical research activity aimed at ac- complishing the first prosopography of Italian physics. The investigation spans over a period of time of more than five centuries, starting from the Renaissance period and including the physicists born up to 1948. The data which are being collected will be articulated in a biographical dictionary, which is gradually being prepared and will be published in 10 separate dossiers. Up to now the research activity fo- cused on the scholars who were active between the Risorgimento and World War II, allowing to list about 1000 Italian physicists born between 1770 and 1918. Many of them, including about 250 high school teachers, had been neglected so far by historical-scientific literature. Almost 100 women physicists were also identified, attesting a gradual evolution of Italian society and of its scientific culture. Concern- ing the above-mentioned period of time, the first four dossiers of the biographical dictionary (letters A–Z) are about to be completed and published within 2020. To show the significance of such a prosopographic investigation, a case study is de- scribed, concerning Enrico Stracciati (1858–1937), a little-known physicist who had an important role in Orso Mario Corbino’s education. -

Italy in Space 1946–1988
HSR-30 March 2003 Italy in Space 1946–1988 Michelangelo De Maria Dipartimento di Fisica Università di Roma – La Sapienza Lucia Orlando Gruppo di storia della fisica Università di Roma – La Sapienza Filippo Pigliacelli Università di Pavia a ii Acknowledgements The authors would like to thank Lorenza Sebesta and Maria Pia Bumbaca for revising drafts and for their helpful suggestions. Abbreviations The following abbreviations were used in the footnotes: AA for “Archivio Amaldi, Dipartimento di Fisica, Università di Roma 'La Sapienza'”; ACS for 'Archivio Centrale dello Stato'. The archival references for the holdings of the Archivio Centrale dello Stato are referred to the deposit inventory (e.g., the list of documents of the CNR archives, lodged in the ACS). Title HSR-30, Italy in Space, 1946–1988 Published by ESA Publications Division ESTEC, Postbus 299 2200 AG Noordwijk The Netherlands Editor R.A. Harris Price €10 ISSN 1683-4704 ISBN 92-9092-539-6 Copyright ©2003 The European Space Agency Printed in The Netherlands iii Contents 1 The Origins: From Cosmic-ray Physics to Space Research (1946–1958)....................1 1.1 Scientific research and the political situation.............................................................1 1.2 First initiatives: Edoardo Amaldi and cosmic-ray research (1946–1952)..................1 1.3 Luigi Broglio and the initial developments in the rocketry field (1952–1957)..........2 1.4 The International Geophysical Year (1957–1958) .....................................................3 2 Italy and International -

Orso Mario Corbino
Orso Mario Corbino di GIOVANNI VACCARO Siamo grati all’Ing. Giovanni Vaccaro per averci consentito di ristampare il suo insuperato studio sulla figura e l’opera di Orso Mario Corbino, originariamente apparso sul Notiziario Storico di Augusta n. 9, 1976, in occasione del centenario della nascita dell’illustre scienziato 1 Tav. I Orso Mario Corbino 2 Nel primo centenario della nascita PREFAZIONE Sono certamente rari, nel campo della cultura, gli uomini che, nel ventesimo secolo, hanno vissuto vicende tanto esaltanti come quelle di O. M. Corbino che, entrato giovanissimo nelle alte sfere della fisica pura, assaporava le soddisfazioni delle pratiche applicazioni della scienza, e, nella ininterrotta continuità dell'insegnamento universitario, esercitava il potere di governo nei settori della pubblica istruzione e dell'economia nazionale, dedi- candosi, poi, alla costituzione della gloriosa scuola di fisica moderna di Roma, mentre, negli ultimi anni della sua vita, presiedeva alle direttive artistiche sulle radiodiffusioni e preparava le prime applicazioni sperimentali per le trasmissioni televisive. Caratteristica della sua meravigliosa vita la coerenza esistenziale che, nel volubile mondo delle ideologie politiche, gli consentiva di non fare la comparsa, né il semplice spettatore, ma di svolgere, invece, sempre il ruolo di protagonista, perché nel suo mondo, che era il mondo della cultura e della scienza e delle sue applicazioni pratiche, la continuità della sua azione, al servizio del progresso della civiltà del sapere, era inarrestabile ed emergeva nitida la sua figura di uomo di scienza, al di sopra de M e parti e delle fazioni, fiero e orgoglioso della propria indipendenza, convinto e consapevole di avere riportato ai più alti livelli la gloriosa tradizione scientifica italiana della fisica, II primo annuncio della sua morte venne dato dal “Giornale Radio” trasmesso dalla Stazione di Roma la sera del 23 gennaio 1937 alle ore 20,10: “Il Senatore Orso Mario Corbino si è spento oggi alle 15,20 nella sua abitazione, in seguito a polmonite. -
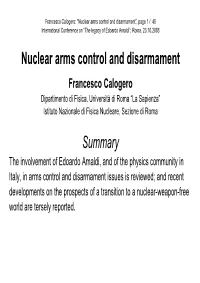
Nuclear Arms Control and Disarmament Summary
Francesco Calogero: “Nuclear arms control and disarmament”, page 1 / 48 International Conference on “The legacy of Edoardo Amaldi”; Roma, 23.10.2008 Nuclear arms control and disarmament Francesco Calogero Dipartimento di Fisica, Università di Roma “La Sapienza” Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma Summary The involvement of Edoardo Amaldi, and of the physics community in Italy, in arms control and disarmament issues is reviewed; and recent developments on the prospects of a transition to a nuclear-weapon-free world are tersely reported. Francesco Calogero: “Nuclear arms control and disarmament”, page 2 / 48 International Conference on “The legacy of Edoardo Amaldi”; Roma, 23.10.2008 - September 5, 1908: birth of Edoardo Amaldi. - 1926: Enrico Fermi becomes the first Professor of Theoretical Physics in Rome. - 1927: the students Edoardo Amaldi, Ettore Maiorana and Emilio Segré shift from Engineering to Physics (at this University in Rome). - 1934: the Rome group (Fermi, Amaldi, D’Agostino, Pontecorvo, Rasetti, Segré) discover the effectiveness of slow neutrons to initiate nuclear reactions. - 1938: anti-Jewish laws are promulgated by the Fascist regime in Italy. - 1938: Fermi receives the Nobel Prize for Physics and moves with his family to the USA; the Rome group disbands, only Amaldi remains in Rome. - June 4, 1944: liberation of Rome. Francesco Calogero: “Nuclear arms control and disarmament”, page 3 / 48 International Conference on “The legacy of Edoardo Amaldi”; Roma, 23.10.2008 - April 25, 1945: liberation of Italy. - 6 August 1945: Hiroshima. - 9 August 1945: Nagasaki. - from 1945: the period of reconstruction, with Amaldi playing the main role in physics (and other fields as well), in Italy and also in Europe. -
Industrial Patents and the Production of Isotopes, 1930-1960
A contentious business: Industrial patents and the production of isotopes, 1930-1960 Simone Turchetti Division of History and Philosophy of Science (HPS), University of Leeds. [email protected] Dynamis Fecha de recepción: 22 de febrero de 2008 [0211-9536] 2009; 29: 191-217 Fecha de aceptación: 4 de abril de 2008 SUMMARY: 1.—Introduction. 2.—A statistical survey. 3.—The isotope business before the war. 4.—Patents, isotopes and the war. 5.—The Patent Compensation Board (PCB) activities. 6.—Britain and Canada. 7.—Conclusions: the contentious business. ABSTRACT: This paper analyses the role that patents played in the establishment of the isotope industry. In the first part I survey the number of issued patents on the production of isotopes, also arguing that the isotope industry was typified by inadequate patenting activities. Then I examine the factors that hindered these activities by looking at the history of industrial patents in the establishment of the isotope industry. I especially focus on the consequences of the Manhattan Project on patent legislation. As the Atomic Energy Act (1946) made the isotope industry a monopoly of the US Atomic Energy Commission (AEC), it contributed to transform the trading of its relevant patents in a «contentious» business. Since then, inventors and assignors already in possession of isotope production patents could only claim compen- sation to the AEC, which was authorised to seize them. And those who might have outlined new inventions were now deprived of the economic incentive to do so, being prohibited from free-trading them in the international market. PALABRAS CLAVE: Patentes, Comisión de Energía Atómica, Ofi cina de Compensación de Patentes, Enrico Fermi, Ley de McMahon, producción de isótopos, Philips. -

The Beginning of Edoardo Amaldi's Interest In
The beginning of Edoardo Amaldi’s interest in gravitation experiments and in gravitational wave research Luisa Bonolis - Max Planck Institute for the History of Science, Berlin - [email protected] Adele La Rana - TERA Foundation, Novara; Sapienza University of Rome; CERN, Geneva - [email protected] Abstract: The research activity in gravitational wave (GW) detection in Rome started in 1970, promoted by Guido Pizzella and Edoardo Amaldi. Unpublished documents1 allowed establishing that Edoardo Amaldi’s first interest in experiments on gravitation dates back to the late 1950s, about twelve years before. Connected to the major international physicists, Amaldi was attentively following the renewed and increasing activity of re- search on gravitation, which was taking place in the international scientific community, both from the theoretical and the experimental point of view, since the second half of the 1950s. Today many historians of physics iden- tify the new attitude of the scientific community towards Einstein’s theory of gravitation, in the 1950s and 1960s, as the “renaissance” of General Relativity. The coeval letters and archival documents in Amaldi’s archive show how his contacts with relativists were progressively growing. Starting from the middle of the 1960s, a clear will appears of beginning an experi- mental activity for detecting gravitational radiation in Rome. Keywords: Gravitation, General Relativity, Gravitational Waves, Edoardo Amaldi, Bruno Touschek, Robert Dicke, Dmitri Ivanenko, Robert Wheeler, Joseph Weber, Livio Gratton, Remo Ruffini 1. Introduction It is perhaps not widely known outside the GW community that one of the most impor- tant gatherings in the field is named after Edoardo Amaldi. -

Concluding Remarks: the Scientist That Lived Three Times
Concluding Remarks: the Scientist that Lived Three Times Luciano MAIANI Dipartimento di Fisica, Universit`adi Roma La Sapienza INFN, Sezione di Roma Piazzale A. Moro 5, Roma, I-00185. Abstract The highlights of the conference: The Legacy of Bruno Pontecorvo: the Scientist and the Man, held in Roma, Universit`a La Sapienza, 11-12 September, 2013, are summarized and illustrated. Foreword Bruno Pontecorvo has been a scientist that lived three times, in three great sagas of the 20th Century: the Via Panisperna boys, the Cold War life in post-war Soviet Union, the fall of real socialism and the disparition of the soviet system. These different periods correspond, approximately, to three different fo- arXiv:1407.1373v1 [physics.hist-ph] 5 Jul 2014 cuses of his interests: nuclear physics, particle physics, neutrinos in the Universe. He left permanent signs in all these areas. Personally, I am very glad of the invitation to give this talk, as I had several connections with Bruno and with the Pontecorvo family. After 1978, Bruno visited Roma periodically, working in an office next to mine. We discussed about Standard Theory and neutrinos. Occasionally, I drove him to his sister’s home, who lived in the other side of town, near the Vatican, and had ample time to be impressed by his personality. Secondly, when working at Istituto Superiore di Sanit`a, at the beginning of my career, I established a long standing friendship with Eugenio Tabet, 1 the son of another Bruno’s sister, Giuliana, and one of the organizers of this Conference. Finally, I met several times Bruno’s brother, Gillo, while Ludovico, Gillo’s son, also a pysicist, was a good friend of my son Tito (no connection between the name of my son and the name of Bruno’s second son, Tito Niels). -

Edoardo Amaldi: a True Statesman of Science
TRIBUTE Edoardo Amaldi: a true statesman of science Edoardo Amaldi was a scientist who used his talent and insight to re-establish science in Italy and across Europe, particularly in fundamental physics, during the critical period following the Second World War. Giovanni Battimelli and Luciano Maiani review the life of this significant individual. Edoardo Amaldi was a leading figure in Italian science in the 20th century, particularly in fundamental experimental physics. He con- tributed to nuclear physics in the 1930s and 1940s, and to cos- mic rays and particle physics in the post-war years, then became a pioneer in the experimental search for gravitational waves in the 1970s. It is largely thanks to his drive that Italian physics emerged successfully from the slump following the Second World War. He was also one of the main players in the process that turned the dreams of large European scientific projects into reality, most notably CERN. In Rome with Fermi Amaldi was born in Carpaneto Piacentino, northern Italy, on 5 Sep- tember 1908. He was the son of Ugo, a distinguished mathe- matician and university professor. Ugo’s academic career led him from Modena to Padua and finally to the University of Rome in 1924, where he joined the outstanding Italian mathematicians Vito Volt- erra, Tullio Levi-Civita, Guido Castelnuovo and Federigo Enriques. Edoardo enrolled at the University of Rome as a student of engineer- ing in 1925. Two years later he moved to physics, attracted by the presence of Enrico Fermi, as were a few other brilliant students, including Emilio Segrè and Ettore Majorana.