Rastrellamento Di Montecchio Precalcino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abano Terme Acerra Aci Castello Acqualagna Acquanegra
Abano Terme Alzano Scrivia Azzano San Paolo Belvedere Marittimo Acerra Amelia Azzate Benevento Aci Castello Anagni Bagnaria Benna Acqualagna Ancarano Bagnatica Bentivoglio Acquanegra Cremonese Ancona Bagno A Ripoli Berchidda Adro Andezeno Bagnoli Di Sopra Beregazzo Con Figliaro Affi Angiari Bagnolo Cremasco Bereguardo Afragola Anguillara Veneta Bagnolo Di Po Bergamo Agliana Annicco Bairo Bernareggio Agliano Annone Di Brianza Baone Bertinoro Agliè Antrodoco Baranzate Besana in Brianza Agna Anzola D’Ossola Barasso Besenello Agordo Aosta Barbarano Vicentino Besnate Agrate Brianza Appiano Gentile Barberino Di Mugello Besozzo Agugliano Appiano sulla strada del vino Barberino Val D’Elsa Biassono Agugliaro Aprilia Barbiano Biella Aicurzio Arce Barchi Bientina Ala Arcene Bardello Bigarello Alano Di Piave Arco Bareggio Binago Alba Arconate Bariano Bioglio Alba Adriatica Arcore Barlassina Boara Pisani Albairate Arcugnano Barone Canavese Bolgare Albano Laziale Ardara Barzago Bollate Albaredo Arnaboldi Ardea Barzanò Bollengo Albaredo D’Adige Arese Basaluzzo Bologna Albavilla Arezzo Baselga Di Pinè Bolsena Albese Con Cassano Argelato Basiano Boltiere Albettone Ariccia Basiliano Bolzano Albiano Arluno Bassano Bresciano Bolzano Vicentino Albiate Arquà Petrarca Bassano Del Grappa Bomporto Albignasego Arquà Polesine Bassano In Teverina Bonate Sotto Albino Arre Bastida Pancarana Bonemerse Albiolo Arsago Seprio Bastiglia Bonorva Albisola Superiore Artegna Battaglia Terme Borghetto S. Spirito Albuzzano Arzachena Battuda Borgo San Dalmazzo Aldeno Arzano Baveno -

Le Tavole Statistiche Fuori Testo
Tavole statistiche Elenco delle tavole statistiche fuori testo Tirature e vendite complessive dei giornali quotidiani per area di diffusione e per categoria (2003-2004-2005) Provinciali ....................................................................................................................................................... Tavola I Regionali .......................................................................................................................................................... Tavola II Pluriregionali ............................................................................................................................................... Tavola III Nazionali .......................................................................................................................................................... Tavola IV Economici ....................................................................................................................................................... Tavola V Sportivi .............................................................................................................................................................. Tavola VI Politici ................................................................................................................................................................. Tavola VII Altri ...................................................................................................................................................................... -
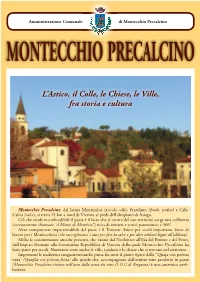
Montecchio Precalcino MONTECCHIO PRECALCINO
Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino MONTECCHIO PRECALCINO L’Astico, il Colle, le Chiese, le Ville, fra storia e cultura Montecchio Precalcino, dal latino Monticulus (piccolo colle), Praedium (fondo, podere) e Calx- Calcis (calce), si trova 15 km a nord di Vicenza ai piedi dell’altopiano di Asiago. Ciò che rende inconfondibile il paese è il fatto che al centro del suo territorio sorge una collinetta (comunemente chiamata “el Monte de Montècio”) ricca di sentieri e scorci panoramici a 360°. Altro componente imprescindibile del paese è il Torrente Astico per secoli importante fonte di lavoro per i Montecchiesi (che raccoglievano i sassi per fare la calce e per altri utilizzi legati all’edilizia). Molte le testimonianze antiche presenti, che vanno dal Neoloitico all’Età del Bronzo e del Ferro, dall’Impero Romano alla Serenissima Repubblica di Venezia della quale Montecchio Precalcino ha fatto parte per secoli. Numerose sono anche le ville, i palazzi e le chiese che si trovano nel territorio. Importanti le tradizioni enogastronomiche prina fra tutte il piatto tipico della “Quaja con poènta onta” (Quaglia con polenta fritta) allo spiedo che, accompagnato dall’ottimo vino prodotto in paese (Montecchio Precalcino rientra nell’area della zona dei vini D.O.C.di Breganze) è una autentica preli- batezza. Villa Da Schio - Cita: del XVII e XVIII secolo fu donata al Comune di Montecchio Precalcino nel 1978 dalla signora Marianna Cita Cabianca. Posta in splendida posizione sul lato orientale della collina ospita varie associazioni ed è sede di numerose manifestazioni ricreative e culturali. Villa Nievo Bonin Longare: già dei conti Nievo, poi Nievo Bonin Longare ed attualmente di pro- prietà dell’Ulss 4 Alto Vicentino. -

1. World Heritage Property Data
Periodic Report - Second Cycle Section II-City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto 1. World Heritage Property Data Villa Forni Cerato, 45.653 / 11.561 2.23 0 2.23 1996 Montecchio Precalcino , 1.1 - Name of World Heritage Property Province of Vicenza , Veneto City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto Region , Italy Comment Villa Godi 45.746 / 11.529 4.66 0 4.66 1996 Committee Decision 20COM VIIC: The name of the property Malinverni, Lonedo di Lugo was changed to “The City of Vicenza and the Palladian Villas Vicentino , of the Veneto” . (Note: "The") Province of Vicenza , Veneto Region , Italy 1.2 - World Heritage Property Details Villa Pisani Ferri, 45.359 / 11.369 1.6 0 1.6 1996 State(s) Party(ies) Bagnolo di Lonigo , Province Italy of Vicenza , Veneto Region , Type of Property Italy cultural Villa Pojana, 45.282 / 11.501 6.14 0 6.14 1996 Identification Number Poiana Maggiore , 712bis Province of Vicenza , Veneto Year of inscription on the World Heritage List Region , Italy 1994, 1996 Villa Saraceno, 45.311 / 11.587 0.59 0 0.59 1996 Agugliaro , Province of 1.3 - Geographic Information Table Vicenza , Veneto Name Coordinates Property Buffer Total Inscription Region , Italy (latitude/longitude) (ha) zone (ha) year Villa Thiene, 45.573 / 11.63 0.38 0 0.38 1996 (ha) Quinto Vicentino , 0 / 0 ? ? ? Province of Vicenza , Veneto 0 / 0 ? ? ? Region , Italy City of Vicenza 45.549 / 11.549 218 0 218 1994 Villa Trissino, 45.428 / 11.414 3.78 0 3.78 1996 (including 23 Sarego , Province buildings of Vicenza , constructed -

International Press
International press The following international newspapers have published many articles – which have been set in wide spaces in their cultural sections – about the various editions of Europe Theatre Prize: LE MONDE FRANCE FINANCIAL TIMES GREAT BRITAIN THE TIMES GREAT BRITAIN LE FIGARO FRANCE THE GUARDIAN GREAT BRITAIN EL PAIS SPAIN FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG GERMANY LE SOIR BELGIUM DIE ZEIT GERMANY DIE WELT GERMANY SUDDEUTSCHE ZEITUNG GERMANY EL MUNDO SPAIN CORRIERE DELLA SERA ITALY LA REPUBBLICA ITALY A NEMOS GREECE ARTACT MAGAZINE USA A MAGAZINE SLOVAKIA ARTEZ SPAIN A TRIBUNA BRASIL ARTS MAGAZINE GEORGIA A2 MAGAZINE CZECH REP. ARTS REVIEWS USA AAMULEHTI FINLAND ATEATRO ITALY ABNEWS.RU – AGENSTVO BUSINESS RUSSIA ASAHI SHIMBUN JAPAN NOVOSTEJ ASIAN PERFORM. ARTS REVIEW S. KOREA ABOUT THESSALONIKI GREECE ASSAIG DE TEATRE SPAIN ABOUT THEATRE GREECE ASSOCIATED PRESS USA ABSOLUTEFACTS.NL NETHERLANDS ATHINORAMA GREECE ACTION THEATRE FRANCE AUDITORIUM S. KOREA ACTUALIDAD LITERARIA SPAIN AUJOURD’HUI POEME FRANCE ADE TEATRO SPAIN AURA PONT CZECH REP. ADESMEUFTOS GREECE AVANTI ITALY ADEVARUL ROMANIA AVATON GREECE ADN KRONOS ITALY AVLAIA GREECE AFFARI ITALY AVLEA GREECE AFISHA RUSSIA AVRIANI GREECE AGENZIA ANSA ITALY AVVENIMENTI ITALY AGENZIA EFE SPAIN AVVENIRE ITALY AGENZIA NUOVA CINA CHINA AZIONE SWITZERLAND AGF ITALY BABILONIA ITALY AGGELIOF OROS GREECE BALLET-TANZ GERMANY AGGELIOFOROSTIS KIRIAKIS GREECE BALLETTO OGGI ITALY AGON FRANCE BALSAS LITHUANIA AGORAVOX FRANCE BALSAS.LT LITHUANIA ALGERIE ALGERIA BECHUK MACEDONIA ALMANACH SCENY POLAND -

STAMPA RASSEGNA STAMPA Dal 20 Al 26 NOVEMBRE 2012 CLICCA SUL TITOLO PER LEGGERE L’ARTICOLO
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza http://www.csv-vicenza.org RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA dal 20 al 26 NOVEMBRE 2012 CLICCA SUL TITOLO PER LEGGERE L’ARTICOLO A CATEGORIA CSV: 12 ACATEGORIA ODV: CATEGORIA NON ISCRITTE: CATEGORIA GENERALE: Il Giornale di Vicenza Clic - CRONACA - Stampa Articolo http://clic.ilgiornaledivicenza.it/GiornaleOnLine/GiornaleDiVicenza/gi... mercoledì 21 novembre 2012 – CRONACA – Pagina 18 SANITÀ. Festeggiato dai dirigenti della Fidas Il primato di Fabio Dona il sangue per duecento volte Un record che meriterebbe un applauso collettivo. Oltre che un successo di famiglia. Fabio Giua, assieme al presidente del Gruppo Fidas Madonna della Pace (stanga) Eros Gaspari ed al presidente provinciale di Fidas Vicenza Mariano Morbin, ha effettuato la sua 200esima donazione di sangue. Ma quello che è più straordinario è che a donare assieme al cinquantenne Fabio c´erano anche le due giovani figlie Eleonora e Fabio Giua con figlie, nipoti e i dirigenti Francesca e le nipoti Alessandra e Giorgia. «Si tratta di un uomo Fidas straordinario – dicono i dirigenti della Federazione locale donatori sangue – per la costanza nell´effettuare le donazioni una volta al mese e sempre di domenica, esprimendo tutto lo spirito volontaristico ed umano che sta dietro al suo gesto. Altrettanto stupefacente la sua capacità di coinvolgere i giovani e portarli a donare». E da figlie e nipoti arriva la conferma: «Non costa nulla recarsi periodicamente a donare il proprio sangue, contribuisce a sentirsi meglio ed una volta effettuata la donazione ci si sente soddisfatti e consapevoli di aver fatto qualcosa di buono per gli altri». -

Sistema Informativo Scolastico -2011/2012
S i s t e m a I n f o r m a t i v o S c o l a s t i c o P r o v i n c i a d i V i c e n z a Sistema informativo scolastico -2011/2012- SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI STATALI Pagina 1 di 81 Istituti professionali Istituto Prof. per l'Industria e l'Artigianato (Codice VIRI00601T) IPSIA Lobbia Via Cinque, 2 ASIAGO Dirigente Paiola Alfredo Anno Classe Classe Classe Classe Classe Totale Alunni scolastico 1 2 3 4 5 alunni stranieri 2004/05 92 88 57 39 63 339 18 2005/06 101 92 61 55 42 351 17 2006/07 93 100 70 49 50 362 18 2007/08 90 87 82 60 47 366 22 2008/09 89 79 77 67 52 364 25 2009/10 94 83 76 59 65 377 21 2010/11 80 76 76 61 54 347 22 2011/12 67 66 74 70 54 331 17 Comuni di residenza degli alunni - A.s. 2011/12 ARSIERO 2 Fuori regione 3 ARZIGNANO 1 Totale 331 ASIAGO 93 BASSANO DEL GRAPPA 8 CALTRANO 2 CARRE' 4 CASSOLA 1 CHIUPPANO 1 COGOLLO DEL CENGIO 5 CONCO 18 CREAZZO 1 ENEGO 10 FARA VICENTINO 2 FOZA 12 GALLIO 24 ISOLA VICENTINA 1 LUGO DI VICENZA 5 LUSIANA 10 MALO 1 MARANO VICENTINO 2 MAROSTICA 24 MASON VICENTINO 2 MOLVENA 3 NANTO 1 PIANEZZE 1 PIOVENE-ROCCHETTE 2 ROANA 66 ROMANO D'EZZELINO 1 ROTZO 6 SALCEDO 4 SANTORSO 1 SARCEDO 2 SCHIAVON 1 TEZZE SUL BRENTA 2 THIENE 5 VELO D'ASTICO 1 ZUGLIANO 2 Provincia di Venezia 1 Pagina 2 di 81 Istituto Prof. -

Rapporto 2019 Sull'industria Dei Quotidiani in Italia
RAPPORTO 2019 RAPPORTO RAPPORTO 2019 sull’industria dei quotidiani in Italia Il 17 dicembre 2012 si è ASSOGRAFICI, costituito tra AIE, ANES, ASSOCARTA, SLC-‐CGIL, FISTEL-‐CISL e UILCOM, UGL sull’industria dei quotidiani in Italia CHIMICI, il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA “Salute Sempre” per il personale dipendente cui si applicano i seguenti : CCNL -‐CCNL GRAFICI-‐EDITORIALI ED AFFINI -‐ CCNL CARTA -‐CARTOTECNICA -‐ CCNL RADIO TELEVISONI PRIVATE -‐ CCNL VIDEOFONOGRAFICI -‐ CCNL AGIS (ESERCENTI CINEMA; TEATRI PROSA) -‐ CCNL ANICA (PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVI) -‐ CCNL POLIGRAFICI Ad oggi gli iscritti al Fondo sono circa 103 mila. Il Fondo “Salute Sempre” è senza fini di lucro e garantisce agli iscritti ed ai beneficiari trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento Attuativo e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, mediante la stipula di apposita convenzione con la compagnia di assicurazione UNISALUTE, autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione nel ramo malattia. Ogni iscritto potrà usufruire di prestazioni quali visite, accertamenti, ricovero, alta diagnostica, fisioterapia, odontoiatria . e molto altro ancora Per prenotazioni: -‐ www.unisalute.it nell’area riservata ai clienti -‐ telefonando al numero verde di Unisalute -‐ 800 009 605 (lunedi venerdi 8.30-‐19.30) Per info: Tel: 06-‐37350433; www.salutesempre.it Osservatorio Quotidiani “ Carlo Lombardi ” Il Rapporto 2019 sull’industria dei quotidiani è stato realizzato dall’Osservatorio tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di informazione. Elga Mauro ha coordinato il progetto ed ha curato la stesura dei testi, delle tabelle e dei grafici di corredo e l’aggiornamento della Banca Dati dell’Industria editoriale italiana La versione integrale del Rapporto 2019 è disponibile sul sito www.ediland.it Osservatorio Tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di informazione Via Sardegna 139 - 00187 Roma - tel. -

Comune Di Thiene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Laghi, Lastebasse, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Sarcedo, T
Comune di Thiene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Laghi, Lastebasse, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Sarcedo, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico e Villaverla SUAP ASSOCIATO ALTOVICENTINO - NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA DALL'1-1-2014 TIPO DI PROCEDURA DIRITTI in € COMMERCIO s.c.i.a. senza verifica urbanistico-edilizia 50 s.c.i.a. con verifica urbanistico-edilizia 100 s.c.i.a. attività accessorie (giochi leciti, apparecchi da 50 gioco, vendita cose usate) s.c.i.a. media struttura di vendita senza verifica 100 urbanistico-edilizia s.c.i.a. media struttura di vendita con verifica 200 urbanistico-edilizia autorizzazione media struttura di vendita 350 autorizzazione grande struttura di vendita in centro 500 storico autorizzazione grande struttura di vendita fuori centro 500 + 500 conf. serv. storico autorizzazioni varie 150 autorizzazioni commercio aree pubbliche 80 autorizzazioni strutture sanitarie e sociali 200 autorizzazioni (aggiornamenti, duplicati, rinnovi, 50 temporanee e attività accessorie) tesserino hobbisti, autorizzazione istruttore/direttore di tiro 30 vidimazione registri, certificazioni varie 10 comunicazioni varie (orari, sospensione/cessazione 0 attività, vendite di liquidazione/sottocosto ecc.) MEZZI PUBBLICITARI insegne d'esercizio in vetrofania e preinsegne 50 insegne d'esercizio 80 cartelli stradali 100 insegne d'esercizio e mezzi pubblicitari superiori a 18 150 mq insegne d'esercizio e mezzi pubblicitari a messaggio 300 variabile rinnovi 50 striscioni stradali su impianti di proprieta' comunale 50 Variazione bozzetto 30 EDILIZIA pratiche paesaggistiche 50 6% contributo di costruzione (al rilascio) con un minimo di: € 200 uso agricolo e altri atti unici / permessi di costruire e “piano casa” € 250 direzionale, commerciale turistico, € 300 industriale € 350 telecomunicazioni (alla presentazione) e un max di €.500. -

Episodio Di Ponte Vecchio Bassano Del Grappa 19-22-02-1945 I.STORIA
Episodio di Ponte Vecchio Bassano del Grappa 19-22-02-1945 Nome del compilatore la scheda: Pierluigi Dossi I.STORIA Località Comune Provincia Regione Ponte Vecchio Bassano del Grappa Vicenza Veneto Data iniziale: 19 febbraio 1945 Data finale: 22 febbraio 1945 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 4 4 0 0 4 0 0 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 4 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute: 1. Cesare Lunardi da Foza; partigiano; 2. Ferdinando detto Federico Alberti “Faio” da Foza; partigiano; 3. Antonio Zavagnin “Burba” di Giuseppe, cl. 20, da Zugliano; partigiano; 4. Partigiano ignoto; Descrizione sintetica Il 19-20.2.1945 nel territorio dei comuni di Enego e Foza il BdS-SD organizza un rastrellamento che porta alla cattura di alcuni partigiani e patrioti della zona; molti di loro sono poi portati ad Asiago, ma soprattutto nelle sedi del BdS-SD di Bassano (Perillo) e di Longa di Schiavon (Carità), per poi essere tradotti alla sede centrale di Verona. Durante il rastrellamento viene assassinato un partigiano di cui non si conosce l’identità e sono compiuti vari saccheggi nelle abitazioni (vedi scheda “Strada Enego-Foza”). Il 22.2.1945, per rappresaglia all’attentato partigiano al Ponte Vecchio di Bassano, Perillo ordina la fucilazione di tre partigiani detenuti: “Il 22 febbraio u.s. -

VICENTINO AMBIENTE SRL Via Lago Di Pusiano, 4 36015 Schio (VI) Italia
Spett.le ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL Via Lago di Pusiano, 4 36015 Schio (VI) Italia +39 0445 575707 int. 413 fax +39 0445 575813 OGGETTO: CURRICULUM PROFESSIONALE STUDIO TECNICO LISSA GIORGIO E ROBERTO SNC I sottoscritti Giorgio e Roberto Lissa hanno il piacere di fornire le proprie referenze relativamente alle prestazioni professionali fornite a vari enti pubblici e privati nel campo degli Impianti Elettrici e delle Fonti Rinnovabili. Dal 1962 al 1966 dipendente di azienda installatrice di impianti elettrici con incarico di progettista e direttore di cantiere, dal 1967 al 1974 partecipazione in altra azienda installatrice di impianti elettrici con incarico di direttore di cantiere; dal 1967 al 2000 esercizio della libera professione come progettista di impianti elettrici, direttore dei lavori, collaudatore in Italia ed in vari paesi nel mondo quali: Arabia Saudita, Giordania, Russia, Ucraina, Armenia. Dal 2000 associato al figlio. Lo studio si occupa di progettazione e consulenza nel settore elettrico e delle fonti rinnovabili, sicurezza elettrica e sicurezza nei luoghi di lavoro DLgs 81/08, prevenzione incendi Lg 818/89. Attualmente operiamo nelle Commissioni di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli nei seguenti comuni: - Comune di Villaverla - Comune di Posina - Comune di Torrebelvicino Segue un elenco delle principali progettazioni svolte negli ultimi 10 anni - PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO – LUOGHI DI CULTO . Albergo Erica di Asiago (VI) . Palazzo Kursaal e teatro in Merano (BZ) . Cinema teatro parrocchiale di Malo (VI) . Cinema teatro comunale Tonezza del Cimone (VI) . Auditorium Fonato in Thiene (VI) . Sala consiliare Provincia di Vicenza . Sala corsi e conferenze Pasubio rete Gas in Schio (VI) . Chiesa Patronato San Gaetano Thiene (VI) . -

Episodio Di Marano Vicentino 29-8-1944 Nome Del Compilatore
Episodio di Marano Vicentino 29-8-1944 Nome del Compilatore: Piero Casentini I.STORIA Località Comune Provincia Regione Strada per Schio Marano Vicentino Vicenza Veneto Data iniziale: 6/8/1944 Data finale: 29/8/1944 Vittime decedute: 1 Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 1 1 1 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 1 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie) 1. Citton Marco, nato a Semonzo del Grappa (TV) il 22/7/1925; partigiano. Altre note sulle vittime: Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: Descrizione sintetica (max. 2000 battute) Marco Citton, al momento dell’Armistizio studente a Bassano del Grappa presso l’Istituto magistrale “Mario Tomolo”, si unì successivamente alla Resistenza. Collegato ai partigiani stanziati in montagna, operava per loro rifornendoli di armi e munizioni. Intorno alle ore 10 del 6 agosto 1944 venne arrestato sulla strada tra Semonzo e Mussolente mentre in bicicletta trasportava un mitra Sten e una pistola Beretta. Disarmato e arrestato, venne prima condotto a Bassano del Grappa e successivamente nelle carceri tedesche di Marano Vicentino. Qui venne interrogato e probabilmente torturato. La sera del 29 agosto 1944 venne portato fuori, lungo la strada che conduce a Schio, scortato da alcuni militari del 263° Battaglione Orientale. Questi ultimi gli fecero credere di essere libero: il giovane partigiano iniziò a camminare verso nord, ma dopo poche decine di metri venne freddato da alcuni colpi sparatigli alle spalle.