Area Stralcio Torrente Sangone Relazione Generale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Slope Instability and Flood Events in the Sangone Valley, Northwest Italian Alps
77 STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA Vol. XLIV, 2010: 77–112 PL ISSSN 0081-6434 LANDFORM EVOLUTION IN MOUNTAIN AREAS 1 1 1 MARCELLA BIDDOCCU , LAURA TURCONI , DOMENICO TROPEANO , 2 SUNIL KUMAR DE (TORINO) SLOPE INSTABILITY AND FLOOD EVENTS IN THE SANGONE VALLEY, NORTHWEST ITALIAN ALPS Abstract. Slope instability and streamflow processes in the mountainous part of the SanGone river basin have been investiGated in conjunction with their influence on relief remodellinG. ThrouGh histor- ical records, the most critical sites durinG extreme rainfalls have been evidenced, concerned natural parameters and their effects (impact on man-made structures) reiterated over space and time. The key issue of the work is the simulation of a volume of detrital materials, which miGht be set in motion by a debris flow. Two modellinG approaches have been tested and obtained results have been evaluated usinG Debris © (GEOSOFT s.a.s.) software. Simulation of debris flow in a small sub-catchment (Tauneri stream) was carried out and the thickness of sediment “packaGe” that could be removed was calculated in order to assess the debris flow hazard. The Turconi & Tropeano formula (2000) was applied to all the partitions of the SanGone basin in order to predict the whole sediment volume which miGht be delivered 3 to the main stream durinG an extreme event and the result beinG 117 m /hectare. Key words : landslip, torrential flood, debris flow, predictive model INTRODUCTION The Alpine valleys, throughout centuries, are in search of an equilibrium between anthropogenic activity and natural processes; interventions due to ameliorating productivity, accommodation and safety conditions for Man and environment often were done overlapping or contrasting the slowly-operating exogenous agents. -

Rapporto Preliminare Per Le Verifiche Di Assoggettabilita’ a Vas
COMUNE DI MONCALIERI CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO PIANO URBANO DEL TRAFFICO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA progettazione Certificato UNI EN ISO 9001 direzione tecnica n° 24163/01/S emesso da associato TAU trasporti e ambiente urbano srl via Oslavia, 18/7 p.iva e c.f. 05500190961 20134 Milano t +39 02 26417244 [email protected] t +39 02 26417284 [email protected] f +39 02 73960215 www.t-au.com codifica elaborato commessa fase livello tipo prog rev nr scala 3701 PUT A RS 02 A 4 - oggetto RAPPORTO PRELIMINARE PER LE VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS rev data autore verifica approvazione A 19.01.2018 Valentina Zangirolami Marco Salvadori Giorgio Morini B C D La proprietà intellettuale di questo documento è riservata alla società Tau Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. ai sensi di legge. Il presente documento non può pertanto essere utilizzato per alcun scopo eccetto quello per il quale è stato realizzato e fornito senza l'autorizzazione scritta di Tau Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. né venire comunicato a terzi o riprodotto. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge. COMUNE DI MONCALIERI PIANO URBANO DEL TRAFFICO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Documento tecnico per la valutazione di assoggettabilità INDICE 1. PREMESSA ................................................................................................. 4 2. QUADRO NORMATIVO ............................................................................... 7 2.1. Normativa comunitaria ....................................................................... -

Views with Community Members
Fontefrancesco and Pieroni Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2020) 16:58 https://doi.org/10.1186/s13002-020-00402-3 RESEARCH Open Access Renegotiating situativity: transformations of local herbal knowledge in a Western Alpine valley during the past 40 years Michele F. Fontefrancesco1 and Andrea Pieroni1,2* Abstract Background: Mountain environments are fragile socio-ecological systems and the conservation of their biological and cultural diversities— seen as co-evolving, strongly intertwined entities—represents a crucial issue for fostering their sustainability. Very few ethnobiological studies have assessed in the mountainous regions of Europe how local botanical knowledge, which represents a vital portion of the local environmental knowledge (LEK), changes over time, although this may be quintessential for a better understanding of the factors influencing how knowledge and practices are shaped, eroded, or even re-created. Methods: In the current study, we compared the gathering and use of local medicinal plants in the Upper Sangone Valley, Western Italian Alps, Piedmont (NW Italy) as described in a field study conducted in the mid- seventies and published in 1977 and those arising from field research that we conducted in the spring of 2015 and 2018, during which time ethnobotanical and ethnomycological information concerning both folk medicinal and wild food uses was obtained via 47 in-depth open and semi-structured interviews with community members. Results: In total, one hundred thirty folk taxa represent the past and present medicinal and wild food plant/ mushroom heritage of the Sangone Valley: 26 herbal taxa were recorded 40 years ago only; 68 herbal and wild food taxa have been recorded in the current study only; and 36 herbal taxa have been continuously used during the last 40 years. -

Comune Di Trana
Ricerca e consulenza in geotecnica, analisi dei rischi naturali, pianificazione territoriale ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– COMUNE DI TRANA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. PROGETTO DEFINITIVO STUDIO GEOLOGICO per l’adeguamento degli elaborati geologico-tecmici secondo i criteri della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e per le verifiche di compatibilità con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in data 26 aprile 2001 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Sesta Revisione) RIFERIMENTI NORMATIVI L.R. 5 dicembre 1977, N. 56 e succ. mod. e int. Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e relativa N.T.E. dicembre 1999 ADBPO – PAI. Delib. Comit. Istit. N° 18 del 26 aprile 2001 Settembre 2017 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Via Genova 192 - 10127 Torino · 0110260610 · [email protected] dr. ALMO OLMI Studio di Geologia - Torino INDICE pag. PREMESSA ALLA PRIMA STESURA (marzo 2010) 3 PREMESSA ALLA PRIMA REVISIONE (settembre 2012) 4 PREMESSA ALLA SECONDA REVISIONE (giugno 2014) 4 PREMESSA ALLA TERZA REVISIONE (giugno 2015) 5 PREMESSA ALLA QUARTA REVISIONE (aprile 2016) 6 PREMESSA ALLA QUINTA REVISIONE (febbraio 2017) 6 PREMESSA ALLA SESTA REVISIONE (settembre 2017) 7 1. RICERCA DATI E DOCUMENTAZIONI 8 1.1 DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE – BANCHE DATI PUBBLICHE – STUDI GEOLOGICI ED IDRAULICI GENERALI 1.2 STUDI E PROGETTI PER INTERVENTI D’INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA 9 1.3 DOCUMENTAZIONE STORICA SUI FENOMENI D’INSTABILITÀ 11 2. DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA 13 2.1 CARTOGRAFIA DI BASE 2.2 DOCUMENTAZIONE AEROFOTOGRAFICA 2.3 CARTOGRAFIA GEOLOGICA 3. RILIEVI GEOMORFOLOGICI 14 4. -

Piano Regolatore Generale Comunale
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO CITTA’ DI GIAVENO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE (art. 17 1° comma L.R. 56/77 e s.m.i. come sostituito all’art. 1 L.R. 29 Luglio 1997 n°41) PROGETTO DEFINITIVO con modifiche ex officio di cui alla D.G.R. 28/11/2011 n°28-2935 pubblicata sul B.U.R. n°49 del 7/12/2011 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA G10 Dicembre 2011 Progetto : arch. Enrico Bonifetto Via Brugnone n° 12 - 10126 Torino tel/fax 0116693203 Consulenza geologica: geol. Giuseppe Genovese geol. Pietro Campantico Studio Genovese & Associati Via Camogli n. 10 – 10134 Torino tel/fax 0113199507 e mail: [email protected] Il Sindaco il Segretario Comunale l’Assessore all’Urbanistica il responsabile del procedimento Piano Regolatore Generale Comunale di GIAVENO (TO) : Prima Revisione – Progetto Definitivo Relazione geologica illustrativa 1. PREMESSA ........................................................................................................................3 2. FINALITA’ E METODOLOGIA DELLO STUDIO ................................................................... 5 3. INTRODUZIONE ALL’INQUADRAMENTO TERRITORIALE................................................. 7 4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E PAESAGGISTICO ...................................................... 8 5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ....................................................................................... 9 5.1 IL SUBSTRATO PRE-QUATERNARIO: IL MASSICCIO DORA-MAIRA..........................................................9 5.2 I DEPOSITI QUATERNARI ....................................................................................................... -

Masterplan Sangone
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2009 Progetto Secondo Classificato: “Agripark Sangone” D’Alessandro, Sara ; Mitolo, Roberto ; Solly, Emily F ; Tabone, Carlo Maria Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-150423 Book Section Published Version Originally published at: D’Alessandro, Sara; Mitolo, Roberto; Solly, Emily F; Tabone, Carlo Maria (2009). Progetto Secondo Classificato: “Agripark Sangone”. In: Ronco, Roberto; et al,. Concorso di progettazione : Contratto di Fiume del bacino del torrente Sangone. Masterplan del Piano d’Azione. Torino: Università di Torino, 14-16. Programma provinciale IN.F.E.A. 2008-2009 IDRA Immaginare Decidere Riqualificare Agire | II edizione concorso di progettazione Contratto di Fiume del bacino del torrente Sangone Masterplan del Piano d’Azione Città di Comune di Comune di Città di Comune di Comune di Comune di Comune di Città di Orbassano Bruino Reano Giaveno Sangano Rivalta di Torino Trana Valgioie Nichelino Indice 7 1. Il progetto di sensibilizzazione IN.F.E.A. “IDRA-immaginare, decidere, riqualificare, agire” Cinzia Zugolaro, Valeria di Marcantonio 8 1.1. Il bando di concorso di progettazione: il Masterplan del Piano d’Azione del Contratto di Fiume del bacino del torrente Sangone 9 2. I Masterplan Roberta Ingaramo e Angioletta Voghera 10 2.1. Progetto Primo Classificato: “Spazio Sangone” Agnese Accotto, Sabrina Bergamo, Tiziano Fracas, Andrea Pelleriti, Luigi Cristian Sarais 14 2.2. Progetto Secondo Classificato: “Agripark Sangone” Sara D’Alessandro, Roberto Mitolo, Emily Solly, Carlo Maria Tabone 16 2.3. -

CHALET VILLA ORTENSIA: Your Dream House in Italy
CHALET VILLA ORTENSIA: Your dream house in Italy The villa, originally built in 1967, already then with finishes of great value, was completely renovated in 2016 and it has been ranked as “A” energy label. It is detached, free on four sides, in a dominant position with stunning views of the Alps and Monviso mount, without buildings on the rear side and well spaced from the neighbouring properties on the sides. It is conveniently located along the SP 188, in Borgata Levrette of Valgioie, a only villas residential area, about 800 meters from the village center (Borgata Chiapero), where you can find a grocery store, ATM, library, church, bar, restaurant, town hall and elementary school. It has a pedestrian entrance and a driveway gate with one or two uncovered parking spaces. It has three apartments of different sizes, on two floors plus recreation room and attic (not habitable, used as a technical room). They are all furnished with essential furniture (kitchens, beds, wardrobes, washing machines, etc.) and are therefore immediately livable. Among the most significant renovation works, the perimeter thermal insulation by blowing, roof insulation, all the windows and doors were replaced with low-emission PVC ones, all the systems (electrical, thermal, water) were replaced. All the original ceramic floor and wall tiles have been changed to porcelain stoneware, with a marble-like or parquet-like look. The entire facade was repainted, the front one was plastered and painted to hide the klinker that aged its appearance. Even the interior has just been repainted, sanitized and thoroughly cleaned, and has not been inhabited since. -

The Turin Fluvial Terraces As Evidence of the New Holocene Setting of the Po River
Journal of Maps ISSN: (Print) 1744-5647 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tjom20 The Turin fluvial terraces as evidence of the new Holocene setting of the Po River M. Gabriella Forno & Franco Gianotti To cite this article: M. Gabriella Forno & Franco Gianotti (2020): The Turin fluvial terraces as evidence of the new Holocene setting of the Po River, Journal of Maps, DOI: 10.1080/17445647.2020.1768447 To link to this article: https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1768447 © 2020 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group on behalf of Journal of Maps View supplementary material Published online: 01 Jun 2020. Submit your article to this journal Article views: 16 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tjom20 JOURNAL OF MAPS https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1768447 The Turin fluvial terraces as evidence of the new Holocene setting of the Po River M. Gabriella Forno and Franco Gianotti Department of Earth Sciences, University of Turin, Torino, Italy ABSTRACT ARTICLE HISTORY A detailed geomorphological mapping of the Po River fluvial terraces into Turin was performed Received 16 October 2019 through a field survey. Although Turin is crossed by the Po River, most of the town is built on the Revised 27 April 2020 extended alpine outwash fans linked to its tributaries (essentially fed by the Dora Riparia Basin), Accepted 6 May 2020 – made by 20 60 m thick gravel with sand lenses, or on erosional terraces (T1 and T2) shaped by KEYWORDS the Po River into these sediments. -

Giro Dell'orsiera” Includes a Six-Day Trekking with Overnight Stay at the Five Staffed Huts in the Orsiera Rocciavrè Natural Park
“GIRO DELL’ORSIERA” Official guide (update 2021) A six-day trekking in the Orsiera Rocciavrè Natural Park Val Sangone – Val Chisone – Valle di Susa Trekking in Orsiera Rocciavrè Natural Park - Photo by M. Cavallo The “Giro dell'Orsiera” includes a six-day trekking with overnight stay at the five staffed huts in the Orsiera Rocciavrè Natural Park. The itinerary offers a broad view of the terrain as well as the historical and cultural aspects of the protected area. It is divided into sections with well-marked trails and moderate altitude differences that hikers with average training can easily follow. There are opportunities for frequent breaks at campsites, glacial lakes, and alpine farms where it is possible to taste the traditional cheese. The sections: access to reception facilities The hiking tour starts in Borgata Molè (Coazze) but you can also begin from any of the following stops. We suggest starting at Forno di Coazze/Molè, in Val Sangone, because it is easily accessible by car and it is half-way between the huts at Val Gravio (Val Susa) and Balma (Val Sangone), which would otherwise be too far to connect in a single day. For those using any other access to the Orsiera Tour (ex. Cortavetto di San Giorio in Val Susa, Prà Catinat in Val Chisone, the train stations in Bussoleno and Borgone) we suggest dividing the tour between the Val Gravio Refuge and the Balma Refuge in two separate steps, for example staying in the Alpine House “Evelina Ostorero” in Forno di Coazze. Borgata Molè (Coazze) altitude: 1087 m above sea level The Molè village is reached by paved road from the Sanctuary of Forno di Coazze (0.8 km) and it is possible to park the car in the area near the buildings. -

Master of Science in Architecture Honors Theses
POLITECNICO DI TORINO SECOND SCHOOL OF ARCHITECTURE Master of Science in Architecture Honors theses Recovering marginal areas: the case of Firsat in Moncalieri by Luca Mercutello and Matteo Moscone Tutor: Massimo Camasso The aim of the work is the development of a methodology feasible in those parts of the city usually defined as "marginal areas." They are often intercluse farmland, outdated by town expansion, excluded from the countryside, but not incorporated into the building fabric, awaiting utilizations that are now unlikely. The site chosen for the project, located in the west suburb of Moncalieri, along the border with the town of Nichelino, is a disused industrial area where it is expected by the City the location of new settlements housing residence, commercial and trade. It owes its condition of marginality to the fact of rising beyond a series of infrastructural and natural barriers: the Po river, the Sangone torrent, the rail (lines Turin-Genoa and Turin-Pinerolo branch), and the entrance of the motorway Turin-Savona. At the centre of the project area stand the establishment of the old Firsat, which is currently in terms of strong degradation. Notwithstanding the industry is, because of its architectural elements, a landmark for the surrounding areas: the coverage consists of two orders of concrete hyperbolic paraboloids. The goal that the project aims to achieve is to connect -or reconnect- this portion of territory with what around it, thus giving back the city a missing part. In our analysis, two different meanings were given to the concept of connection. The first, material, is related to roads, routes, alignments, location of physical objects and their size. -
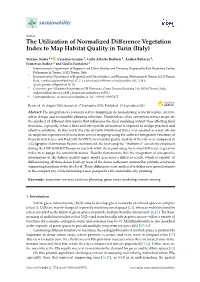
The Utilization of Normalized Difference Vegetation Index to Map Habitat Quality in Turin
sustainability Article The Utilization of Normalized Difference Vegetation Index to Map Habitat Quality in Turin (Italy) Stefano Salata 1,* , Carolina Giaimo 2, Carlo Alberto Barbieri 2, Andrea Ballocca 3, Francesco Scalise 3 and Giulio Pantaloni 2 1 Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning, Responsible Risk Resilience Centre, Politecnico di Torino, 10125 Torino, Italy 2 Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning, Politecnico di Torino, 10125 Torino, Italy; [email protected] (C.G.); [email protected] (C.A.B.); [email protected] (G.P.) 3 Consorzio per il Sistema Informativo-CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino, Italy; [email protected] (A.B.); [email protected] (F.S.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-011-090-7475 Received: 26 August 2020; Accepted: 17 September 2020; Published: 19 September 2020 Abstract: The integration of ecosystem service mapping in decision-making is crucial to place effective urban design and sustainable planning solutions. Nonetheless, often ecosystem service maps are the product of different data inputs that influences the final modeling output thus affecting final decisions, especially when a finer and site-specific assessment is required to design practical and effective solutions. In this work, the city of Turin (Northwest Italy) was selected as a test site for an empirical experiment of ecosystem service mapping using the software Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST): two habitat quality models of the city were compared in a Geographic Information System environment, the first using the “traditional” sensitivity employed during the LIFE SAM4CP European research while the second using the natural difference vegetation index to re-assign the sensitivity scores. -

Relazione Tirocinio Sangone.Pdf
Politecnico di Torino DITIC - Department of Hydraulics, Transport and Civil Infrastructures Caratterizzazione fisiografica, climatica e del suolo del bacino del Sangone per applicazione di modelli idrologico distribuiti Relazione di tirocinio Relazione di tirocinio Elena Diamantini Prof. Pierluigi Claps (tutor accademico) Ing. Mariella Graziadei (tutor aziendale) Giugno 2014 Sommario DESCRIZIONE BACINO .................................................................................................................................. 2 1.1. Conformazione morfologica ........................................................................................................... 2 1.2. Suoli ............................................................................................................................................... 5 1.3. Vegetazione ..................................................................................................................................12 1.4. Situazione monitoraggio ...............................................................................................................16 DATI ...........................................................................................................................................................25 1.5. Suolo ............................................................................................................................................25 1.6. Satellitari ......................................................................................................................................27