Rapportofinale Ita.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
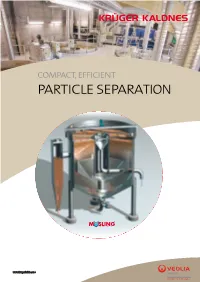
Particle Separation
COMPACT, EFFICIENT PARTICLE SEPARATION www.krugerkaldnes.no Unique separation equipment The MUSLING® flotation equipment was developed during the 1980’s originally for removing fat and oil from fish-processing sewage outlets. Now, after more than 20 years experience, the MUSLING® has become synonymous with the treatment for both industrial and communal sewage systems. MUSLING® continually separates particles from all types of flowing liquids. Its unique hydraulic design produces a maximum flotation effect. The MUSLING® flotation efficiency is the result of a hydraulic action that influences the velocity and direction of the liquid so that particle matter becomes separated at the surface. High capacity One of the many advantages of the MUSLING® is that it can handle a large flow of liquid in a relatively small space. It can separate particle matter at surface speeds of up to 15 m/h. The result - equipment that is compact, efficient and extremely cost- effective The MUSLING® can be used for the treatment of all forms of liquid-flow systems including traditional sewage cleaning, drinking water treatment, industrial outlet separation and recycling plants where products can be extracted and returned to the production process. An environmental advantage The MUSLING® can be used as a pure mechanical plant for the removal of fat and oils. On the other hand it can be part of a chemical cleaning system or a biological treatment process. The common factor here is that the MUSLING® is always the particle-removal element. An outside influence on the separation process The flotation particle separation process of is often dependent on what is called “dispersion”. -

Hva Er Viktig for Deg-Dagen 6. Juni 2018
1 Summary ‘What matters to you?’ day in Norway 2019 ks.no/pasientforlop 27.06.2019 2 Background • It started in Norway in 2014. Participants in Gode pasientforløp (Learning networks for whole, coordinated and safe pathways in the municipalities) were very positive about the ‘ What matters to you? ’ message, and it was decided to conduct such a day in Norway. • Gode pasientforløp is carried out by KS (The Norwegian Association of Local and Regional Authorities) in collaboration with NIPH (the Norwegian Institute of Public Health). • An article in the New England journal of Medicine i 2012 introduced the question ‘What matters to you?’ • One of the goals in Gode pasientforløp is to strengthen the role of the user in improvement of patient pathways. 27.06.2019 3 Buttons • KS has distributed 60,605 buttons to 172 municipalities (of a total of 422), including all 15 districts in Oslo in 2019 • 31 hospitals have also ordered buttons and celebrated the day • A total of approx. 200,000 buttons has been distributed since 2014 The first buttons New design in 2017 Norway has two written standard, and in 2018 we also offered buttons in Nynorsk as well as in Sami language. 27.06.2019 4 The Ministry of Health and Care Services produced their own film 27.06.2019 5 ‘What matters to you?’ films Gode pasientforløp have produced several short videos where the participants either receives or gives health care services • Solveig* – approx. 9,2 k views på FB • Silje – approx. 8,2 k views på FB • Marius* – approx. 2,6 k views på FB • Gro* • Torbjørn In addition a longer film* (4:23) with excerpts from all the individual films has been produced * English subtitles 27.06.2019 6 Activities all over Norway Sør-Varanger Municipality Åsnes Municipality 27.06.2019 7 Activities all over Norway, contd. -

Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
E WIPO/STrad/INF/5 ORIGINAL: ENGLISH DATE: AUGUST 30, 2010 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications GROUNDS FOR REFUSAL OF ALL TYPES OF MARKS Document prepared by the Secretariat INTRODUCTION 1. From its twenty-first session (June 22, 2009 to June 26, 2009) to its twenty-third session (June 30, 2010 to July 2, 2010), the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) considered a number of working documents dealing with grounds for refusal of all types of marks (see documents SCT/21/2, SCT/22/2, and SCT/23/2). 2. The documents were based on information provided by SCT Members in their replies to the WIPO Questionnaire on Trademark Law and Practice, as presented in WIPO document WIPO/STrad/INF/1 (hereinafter referred to as “the Questionnaire”), and in WIPO documents SCT/16/4, SCT/17/4 and SCT/18/3 referring to trademark opposition procedures. 3. In addition, the following SCT Members provided written submissions on specific aspects of their law and practice concerning grounds for refusal: Australia, Belarus, Brazil, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Guatemala, Hungary, Japan, Latvia, Mexico, Norway, Pakistan, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Singapore, Slovenia, Sweden, The former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom, United States of America, Viet Nam, and the European Union (EU) (27). The African Intellectual Property Organization (OAPI) also submitted its contribution. The full text of the submissions is posted on the SCT Electronic Forum webpage. WIPO/STrad/INF/5 page 2 4. -

Judgment of the Court
REPORT FOR THE HEARING in Case E-5/96 REQUEST to the Court under Article 34 of the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice by Borgarting lagmannsrett's (Borgarting Court of Appeal) for an advisory opinion in the case pending before it between Ullensaker kommune and Others and Nille AS on the interpretation of Article 11 and 13 of the EEA Agreement. I. Introduction 1. By an order dated 21 June 1996, registered at the Court on 26 June 1996, Borgarting lagmannsrett, a Norwegian Court of Appeal, made a request for an advisory opinion in a case brought before it by Ullensaker municipality, Nes municipality, Eidsvoll municipality, Sørum municipality and Sunndal municipality (the appellants) against the respondent Nille AS (Nille). By a Ruling of 2 September 1996 the appeal on the part of Sunndal municipality was terminated. II. Legal background 2. The questions submitted by the Norwegian court concern the interpretation of Article 11 and Article 13 of the EEA Agreement. 3. Article 11 EEA, which mirrors Article 30 of the EC Treaty provides: "Quantitive restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties". 4. Article 13 EEA provides a derogation from Article 11 EEA under the same conditions as Article 36 EC: "The provisions of Article 11 and 12 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. -

Sustainability Report 2008 KLP and Society Page 3
KLP AND SOCIETY PAGE 1 Together we generate values for the future: Sustainability report 2008 KLP AND SOCIETY PAGE 3 Table of contents 4 Foreword by our CEO 6 Values and foundations 10 Municipal high-risk sport 12Practicing what they preach 14 Leaping off the KLP list 16 Competition for the Blue Cross 18 Report 2008 How? 20 Customers 24 The environment Our customers have entrusted more than 200 billion 27 Society Norwegian kroner to us. These funds represent future pensions 32 The workplace 36 Plan of Action 2009 and compensation payments for public sector employees. By 38 GRI table incorporating strategies related to the climate, nature and society 39 Organisation and management in our management of these funds, we are making a major con tribution to a safer and more predictable future. But we cannot - achieve such ambitious goals alone. We rely on close cooperation with customers, owners, the companies in which we invest and numerous other partners to build the foundations for a sound and long-term process of value creation. PAGE 4 KLP AND SOCIETY KLP AND SOCIETY PAGE 5 However, there’s no A reliable point preaching to others if you can’t practice what you partner preach. In June 2008, KLP Skadeforsikring As every good sailor knows, a strong anchor can keep you was the first insurance safe when the storm comes. As a responsible administrator of company ever to customer funds in times of financial unrest, and as a shining achieve Eco-Light- Eco-Lighthouse in the era of climate change, KLP reaps the house certification. -

Our County, Our Story; Portage County, Wisconsin
Our County Our Story PORTAGE COUNTY WISCONSIN BY Malcolm Rosholt Charles M. White Memorial Public LibrarJ PORTAGE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS STEVENS POINT, \VISCONSIN 1959 Copyright, 1959, by the PORTAGE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AT WORZALLA PUBLISHING COMPANY STEVENS POINT, WISCONSIN FOREWORD With the approach of the first frost in Portage County the leaves begin to fall from the white birch and the poplar trees. Shortly the basswood turns yellow and the elm tree takes on a reddish hue. The real glory of autumn begins in October when the maples, as if blushing in modesty, turn to gold and crimson, and the entire forest around is aflame with color set off against deeper shades of evergreens and newly-planted Christmas trees. To me this is the most beautiful season of the year. But it is not of her beauty only that I write, but of her colorful past, for Portage County is already rich in history and legend. And I share, in part, at least, the conviction of Margaret Fuller who wrote more than a century ago that "not one seed from the past" should be lost. Some may wonder why I include the names listed in the first tax rolls. It is part of my purpose to anchor these names in our history because, if for no other reas on, they were here first and there can never be another first. The spellings of names and places follow the spellings in the documents as far as legibility permits. Some no doubt are incorrect in the original entry, but the major ity were probably correct and since have changed, which makes the original entry a matter of historic significance. -

Økologisk Tilstand Sagstuåa, Rapport LNR. 6219-2011
6219-2011 - Økologisk tilstand i Sagstuåa, Nes RAPPORT L.NR. 6219-2011 ØkologiskRAPPORT tilstand LNR i Sagstuåa, 6219-2011 ØkologiskNes tilstand kommune i Sagstuåa, Nes kommune Sagstuåa ved Auli mølle (foto: M.Lindholm/NIVA) (foto: Auli mølle ved Sagstuåa Sagstuåa ved Auli mølle (foto: M.Lindholm/NIVA). Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns vei 3 Sandvikaveien 41 Postboks 2026 Postboks 1266 0349 Oslo 4879 Grimstad 2312 Ottestad 5817 Bergen 7462 Trondheim Telefon (47) 22 18 51 00 Telefon (47) 22 18 51 00 Telefon (47) 22 18 51 00 Telefon (47) 2218 51 00 Telefon (47) 22 18 51 00 Telefax (47) 22 18 52 00 Telefax (47) 37 04 45 13 Telefax (47) 62 57 66 53 Telefax (47) 55 23 24 95 Telefax (47) 73 54 63 87 Internett: www.niva.no Tittel Løpenr. (for bestilling) Dato Økologisk tilstand i Sagstuåa, Nes kommune NIVA-rapp. 6219-2011 5.10.2011 Sider Pris Prosjektnr. Undernr. 24 O - 11177 Forfatter(e) Fagområde Distribusjon Markus Lindholm Vannressursforvaltning Fri Geografisk område Trykket Akershus Oppdragsgiver(e) Oppdragsreferanse Nes kommune Leiv Knutson Sammendrag NIVA har vurdert økologisk tilstand i vassdraget Sagstuåa i Nes kommune i Akershus. På bakgrunn av vassdragets utforming, konkluderer vi med at vassdraget etter vanndirektivets kriterier må defineres som to ulike vannforekomster, med ulike miljømål. Vannkjemiske funn tilsier at den nedre delen av Sagstuåa er utsatt for forurensning knyttet til næringssalter fra bebyggelse og landbruk. Basert på opplysninger fra Nes kommune har vi satt opp et forenklet kilderegnskap for fosforavrenning til vassdraget. -

En Studie Av Skredaktiviteten I Arnegårdslia, Nes Kommune, Hallingdal
Masteroppgave, Institutt for geofag En studie av skredaktiviteten i Arnegårdslia, Nes kommune, Hallingdal Utløsende årsaker og menneskelig påvirkning Monika Rødin Lund En studie av skredaktiviteten i Arnegårdslia, Nes kommune, Hallingdal Utløsende årsaker og menneskelig påvirkning Monika Rødin Lund Masteroppgave i geofag Studieretning: Miljøgeologi og Geofarer Institutt for geofag Matematisk-naturvitenskaplig fakultet UNIVERSITETET I OSLO 3.6.2013 © Monika Rødin Lund, 2013 Dette eksamensarbeidet er publisert elektronisk i DUO – Digitale Utgivelser ved UiO http://www.duo.uio.no Det er også katalogisert i BIBSYS (http://www.bibsys.no/) All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission. Forsidebilde: Skredet ved Oslo Lysverker boligene 23. mai 2013 (Foto: Politiet). Sammendrag Sommeren 2007 og 2011 ble flere store jordskred utløst i Arnegårdslia i Nes kommune, Hallingdal, noe som førte til store materielle skader. Målet med denne oppgaven har vært å undersøke jordskredaktiviteten i denne dalsiden for å få en forståelse av hva som forårsaket disse hendelsene og når og hvor neste skred vil inntreffe. Gjennom feltstudier har dalsidens raviner og skredavsetninger blitt kartlagt. Observerte nedbørmengder har blitt sammenlignet med gitte terskelverdier for å studere nedbørens betydning for utløsningen av hendelsene i 2007 og 2011. Gjentaksintervallet for utløsende nedbørmengder har også blitt beregnet for å kunne gi en indikasjon på når neste skredhendelse kan inntreffe. Flere analyser har blitt foretatt for å undersøke skogsbilveiens betydning i forhold til dens påvirkning på utløsningen av skredene i 2007 og 2011, og fremtidige skred. De mange ravinene og skredavsetningene gir et bilde av den store skredaktiviteten som har vært i dalsiden. -

Søk Etter Heroringvinge Coenonympha Hero I Norge I 2013 Og 2014
1070 Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 Anders Endrestøl Roald Bengtson NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsk- nings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. NINA Temahefte Som navnet angir behandler temaheftene spesielle emner. Heftene utarbeides etter behov og se- rien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstil- linger i samfunnet. NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med mer vekt på illustrasjoner enn NINA Rapport. NINA Fakta Faktaarkene har som mål å gjøre NINAs forskningsresultater raskt og enkelt tilgjengelig for et større publikum. De sendes til presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivå, politikere og andre spesielt interesserte. Faktaarkene gir en kort framstilling av noen av våre viktigste forsk- ningstema. Annen publisering I tillegg til rapporteringen i NINAs egne serier publiserer instituttets ansatte en stor del av sine viten- skapelige resultater i internasjonale journaler, populærfaglige bøker og tidsskrifter. Søk etter heroringvinge Coenonympha -
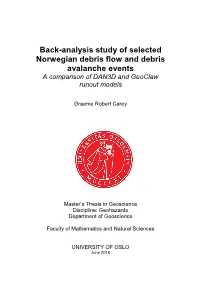
Back-Analysis Study of Selected Norwegian Debris Flow and Debris Avalanche Events a Comparison of DAN3D and Geoclaw Runout Models
Back-analysis study of selected Norwegian debris flow and debris avalanche events A comparison of DAN3D and GeoClaw runout models Graeme Robert Carey Master’s Thesis in Geoscience Discipline: Geohazards Department of Geoscience Faculty of Mathematics and Natural Sciences UNIVERSITY OF OSLO June 2018 ii Back-analysis study of selected Norwegian debris flow and debris avalanche events A comparison of DAN3D and GeoClaw runout models Graeme Robert Carey Master’s Thesis in Geoscience Discipline: Geohazards Department of Geoscience Det Matematisk-naturvitenskapelige Fakultet Universitetet i Oslo June 2018 iii iv © Graeme Carey, 2018 Supervisors: José Mauricio Cepeda (NGI), Anders Solheim (NGI/UIO) Back-analysis study of selected Norwegian Debris Flow and Avalanche Events: a comparison of DAN3D and GeoClaw runout models http://www.duo.uio.no/ Print: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Cover photo: Southern Oldedalen, seen from the initiation zone of Oldedalen 1. Graeme Carey, 2017. v Abstract Debris flows and debris avalanches represent a large threat to society in Norway. The intensity and frequency of these events is expected to increase over the course of the next 50 years due to changing precipitation patterns related to global climate change. Models are continually being developed and tested to better understand and characterise these events. An important part of creating regional and local-scale hazard maps is understanding the potential runout distance and velocity that can be achieved by these events. This thesis provides a detailed study of four landslide events in western Norway (two debris flows and two debris avalanches) additionally, it compares two software packages used for landslide back-analysis. -
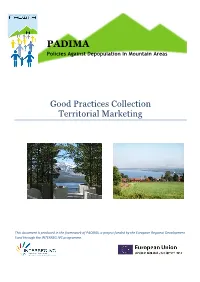
Collection of Good Practices on Territorial Marketing
1 PADIMA Policies Against Depopulation In Mountain Areas Good Practices Collection Territorial Marketing This document is produced in the framework of PADIMA, a project funded by the European Regional Development Fund through the INTERREG IVC programme. 2 Contents Map: Interreg IV C Joint Secretariat ........................................................................................................ 3 Background document for speakers and participants ............................................................................ 4 Introduction to the good practice collection ...................................................................................... 7 Chapter 1 Territorial marketing and advertising ..................................................................................... 9 Campaigns ........................................................................................................................................... 9 1) Light in the windows ................................................................................................................... 9 2) Like to live in Krødsherhad ....................................................................................................... 13 3) Contact 1 ................................................................................................................................... 17 4) Move to the Mountain Region .................................................................................................. 20 5) The Netherlands project .......................................................................................................... -

11 PERSONVERNERKLÆRING Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum
Norsk (bokmål): s. 1 – 5 English version: pages 5 - 11 PERSONVERNERKLÆRING Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker (her: ”kommunene", "vi" eller "oss") respekterer din personlige integritet og sørger for at du kan føle deg trygg i hvordan dine personopplysninger blir behandlet hos oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger når du bruker tjenesten VISIBA ("Tjenesten"). Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan hevde rettighetene dine. Din bostedskommune er ansvarlig for personopplysninger som behandles i tjenesten. Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål om dine personopplysninger. 1. PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN Følgende personopplysninger blir samlet inn og behandlet av oss i forbindelse med bruken av tjenesten: Informasjon du gir oss o Personopplysninger og kontaktinformasjon. Når du oppretter din brukerkonto i Tjenesten, må du gi oss informasjon som navn, personnummer, e-postadresse, mobilnummer osv. o Helseinformasjon. Når du bruker tjenesten, kan du dele informasjon om din fysiske og mentale helse. Dette kan for eksempel omfatte informasjon knyttet til sykdommen din, din sykehistorie eller din fysiske (f.eks. utslett) eller biomedisinske tilstander (f.eks. blodverdier). Helseinformasjon kan samles inn blant annet når du muntlig eller skriftlig forteller det til helsesykepleieren, konsulenten, psykologen eller andre personer du kommer i kontakt med i Tjenesten ("terapeuten"). Helseinformasjon kan også samles inn når du svarer på skjema-spørsmål eller laster opp bilder eller andre filer i tjenesten. o Betalingsinformasjon. Hvis du foretar betalinger i tjenesten, vil kreditt- og debetkortinformasjonen din (navn, kortnummer, gyldighet og CVC / CVV-kode) bli samlet inn. o Informasjon kan også samles inn hvis du gir tilbakemelding i tjenesten.