Orcomeno Minia in Etá Arcaica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
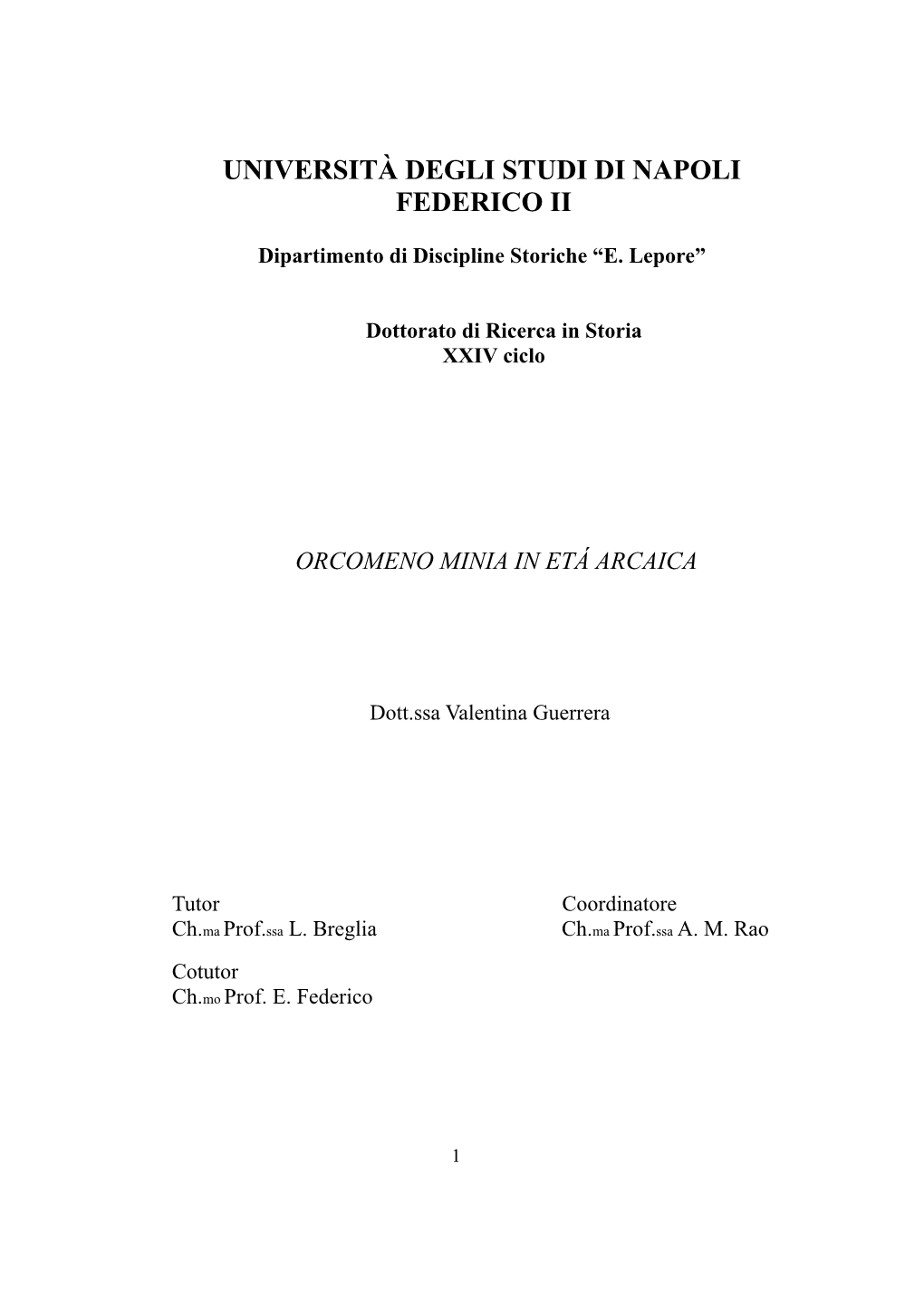
Load more
Recommended publications
-

97631 Aegeum I.Ps
AEGAEUM 37 Annales liégeoises et PASPiennes d’archéologie égéenne PHYSIS L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LA RELATION HOMME-MILIEU DANS LE MONDE ÉGÉEN PROTOHISTORIQUE Actes de la 14e Rencontre égéenne internationale, Paris, Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 11-14 décembre 2012 Edités par Gilles TOUCHAIS, Robert LAFFINEUR et Françoise ROUGEMONT PEETERS LEUVEN - LIEGE 2014 997631_Aegaeum7631_Aegaeum 3737 vwk.inddvwk.indd Sec11Sec11 111/12/141/12/14 008:268:26 Illustration de couverture: Institut National d’Histoire de l’Art : la galerie Colbert avec, au premier plan, la statue de bronze d’Eurydice mordue par un serpent, œuvre de Charles-François Leboeuf, dit Nanteuil (1822) (cliché Cyrille Galinand). A catalogue record for this book is available from the Library of Congress. D/2014/0602/104 Impression et dépositaire : PEETERS Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven (Belgique) © A.s.b.l. Aegaeum, Aux Piédroux 120, B-4032 Liège (Belgique) et Program in Aegean Scripts and Prehistory (PASP), The University of Texas at Austin, 2014 ISBN 978-90-429-3195-4 Reproduction et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation de l’éditeur, pour tous pays. 997631_Aegaeum7631_Aegaeum 3737 vwk.inddvwk.indd Sec12Sec12 111/12/141/12/14 008:268:26 SOMMAIRE Préface 11 A. Cadre naturel : Georgia KOURTESSI-PHILIPPAKIS, Local vs exogène ? L’impact du milieu naturel sur la composition des assemblages lithiques néolithiques en Grèce 15 Georgia STRATOULI, Anaya SARPAKI, Maria NTINOU, Eleni KOTJABOPOULOU, Tatiana THEODOROPOULOU, Vasilios MELFOS, Niels H. ANDREASEN, Panagiotis KARKANAS, Dialogues Between Bioarchaeological, Geoarchaeological and Archaeological Data: Approaches to Understanding the Neolithic Use of Drakaina Cave, Kephalonia Island, Western Greece 23 Erika WEIBERG, Timing, Perception and Response. -

Trends in Classics
2014!·!VOLUME 6!· NUMBER 2 TRENDS IN CLASSICS EDITED BY Franco Montanari, Genova Antonios Rengakos, Thessaloniki SCIENTIFIC COMMITTEE Alberto Bernabé, Madrid Margarethe Billerbeck, Fribourg Claude Calame, EHESS, Paris Philip Hardie, Cambridge Stephen Harrison, Oxford Stephen Hinds, U of Washington, Seattle Richard Hunter, Cambridge Christina Kraus, Yale Giuseppe Mastromarco, Bari Gregory Nagy, Harvard Theodore D. Papanghelis, Thessaloniki Giusto Picone, Palermo Kurt Raaflaub, Brown University Bernhard Zimmermann, Freiburg Brought to you by | Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz Authenticated Download Date | 11/7/14 11:19 PM ISSN 1866-7473 ∙ e-ISSN 1866-7481 All information regarding notes for contributors, subscriptions, Open access, back volumes and orders is available online at www.degruyter.com/tic Trends in Classics, a new journal and its accompanying series of Supplementary Volumes, will pub- lish innovative, interdisciplinary work which brings to the study of Greek and Latin texts the insights and methods of related disciplines such as narratology, intertextuality, reader-response criticism, and oral poetics. Trends in Classics will seek to publish research across the full range of classical antiquity. Submissions of manuscripts for the series and the journal are welcome to be sent directly to the editors: RESPONSIBLE EDITORS Prof. Franco Montanari, Università degli Studi di Genova, Italy. franco. [email protected], Prof. Antonios Rengakos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. [email protected] EDITORIAL -

The Western Silk Road in Greece
The Western Silk Road in Greece Kostopoulou Stella Scientific Supervisor Kyriakou Dimitrios Malisiova Sevasti Sofianou Evina Toufengopoulou Anastasia Xanthopoulou–Tsitsoni Valia Silk Road Programme 2016 Western Silk Road Tourism Initiative A UNWTO-EU Initiative This study is part of the Western Silk Road Tourism Development Initiative, a joint cooperation between the World Tourism Organization (UNWTO) and the Directorate- General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG Grow) of the European Commission (EC). Western Silk Road in Greece Research Team Stella Kostopoulou is Associate Professor of Regional and Tourism Development at the Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). She has also taught at Cyprus University of Technology, Hellenic Open University, International Hellenic University, Democritus University of Thrace, University of Thessaly, and gave lectures and seminars at Universities abroad (Peking University, La Trobe University, York University). She is Departmental ECTS/Erasmus/LLP Coordinator of the Stella Kostopoulou Department of Economics, AUTh. Her research interests Associate Professor include regional economics and planning, tourism Aristotle University of Thessaloniki development, cultural industries and local development. She Department of Economics has participated in 70 international and national Tel: +30 2310 996423, +30 6932236366 conferences and published in international journals. E-mail: [email protected] Dimitrios Kyriakou is an Economist and PhD Candidate in Tourism and Regional Development at the Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Greece. He holds a BSc in Economics and Regional Development (Panteion University, Greece), an MBA in Business Finance Management (The University of Liverpool, UK) and an MSc in Tourism Management (University of Surrey, UK). He is member of the teaching team in the undergraduate courses “Tourism Development”, “Regional Development” and “Economic Geography”, Department of Economics, AUTh. -
John Pappajohn Centers Celebrate 20Th Anniversary
S O C V st ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ W ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ E 101 ΑΠΟ ΤΟ 1915 The National Herald anniversa ry N www.thenationalherald.com A wEEKly GREEK-AmERIcAN PUblIcAtION 1915-2016 VOL. 19, ISSUE 989 September 24-30 , 2016 c v $1.50 Pence John Pappajohn Meets with Centers Celebrate Arch. 20th Anniversary Demetrios By Demetris Tsakas universities in 1996, at a time when entrepreneurial activity in Rebuilding St. DES MOINES, IA – The state of Iowa was at a standstill, busi - Iowa and the five universities nesses were closing one after Nicholas Church, that benefited from the generos - the other and the agricultural ity, wisdom, vision, and deter - sector was in despair. family discussed mination of John Pappajohn As he pointed out in his held a celebration at the Des speech during the ceremony, TNH Staff Moines Marriott Hotel on Sep - Pappajohn recognized the crisis tember 15 for the 20th anniver - as an opportunity and, along NEW YORK – His Eminence sary of the establishment of the with his wife Mary, decided to Archbishop Demetrios of Amer - John Pappajohn Entrepreneurial initially offer $1 million dollars ica received a visit on Septem - Centers. to each of the five universities ber 15 in his office at the Head - Founded in 1996 at Drake for the creation of the Entrepre - quarters of the Greek Orthodox University, Iowa State Univer - neurial Centers. The couple was Archdiocese of America, from sity, North Iowa Area Commu - not content with just the dona - Indiana Governor Mike Pence, nity College, the University of tion, but managed to transform the Vice-Presidential nominee of Iowa, and the University of their own vision and way of do - the Republican Party. -
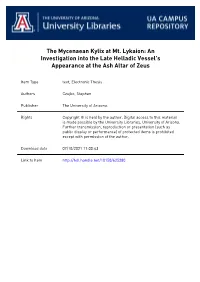
The Mycenaean Kylix at Mt. Lykaion: an Investigation Into the Late Helladic Vessel's Appearance at the Ash Altar of Zeus
The Mycenaean Kylix at Mt. Lykaion: An Investigation into the Late Helladic Vessel's Appearance at the Ash Altar of Zeus Item Type text; Electronic Thesis Authors Czujko, Stephen Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 07/10/2021 11:00:43 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/625280 THE MYCENAEAN KYLIX AT MT. LYKAION: AN INVESTIGATION INTO THE LATE HELLADIC VESSEL’S APPEARANCE AT THE ASH ALTAR OF ZEUS By: Stephen Czujko __________________________________________ Copyright © Stephen Czujko 2017 A Thesis Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF CLASSICS In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2017 1 STATEMENT BY AUTHOR The thesis titled “The Mycenaean Kylix at Mt. Lykaion: An Investigation Into The Late Helladic Vessel’s Appearance At The Ash Altar of Zeus” prepared by Stephen Czujko has been submitted in partial fulfillment of requirements for a master’s degree at the University of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that an accurate acknowledgement of the source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by the copyright holder. -

Pellana 2014
PELLANA ΠΕΛΛΆΝΑ Wikipedia, the free encyclopaedia http://en.wikipedia.org/wiki/Pellana State: Laconia Country: Greece Population: 250 Coordinates 37°12′N 22°19′E Time zone: EET/EEST (UTC+2/3) Pellana (Greek: ἡ Πέλλανα, Paus. iii. 20. 2; τὰ Πέλλανα, Strabo viii. p. 386; Πελλήνη, Xen. Hell. vii. 5. 9; Polyb. iv. 81, xvi. 37;Plut. Agis, 8), was a city of Laconia, on the Eurotas river, and on the road from Sparta to Arcadia. According to archaeologist Theodore Spyropoulos, Pellana was the Mycenaean capital of Laconia. It is also a former municipality in Laconia, Peloponnese, Greece. Since the 2011 local government reform it is part of the municipality Sparta, of which it is a municipal unit. The seat of the municipality was in Kastoreio. Today, Pellana is a small village in North Laconia, and it is located 27 kilometers north of Sparta, 5 kilometers west of the main road that connects Sparta with Tripoli. It is built on a hill that is an extension of the Taygetos mountains in the Peloponnese. Pellana is built on an area of 11 square kilometers, and is 370 meters above the sea level. The population of the modern village of Pellana peaked in the 1940s, and ever since it has been reduced to in excess of 200 inhabitants. The town suffered badly during the second world War, especially during the Greek Civil war where brother fought brother and father against sons and daughters. It is a town that has lost more than its fair share of people as a result of the disastrous civil war. -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Life after the Palaces: A Household Archaeology Approach to Mainland Greece during Late Helladic IIIC Permalink https://escholarship.org/uc/item/3kf172rc Author Van Damme, Trevor Matthew Publication Date 2017 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Life after the Palaces: A Household Archaeology Approach to Mainland Greece during Late Helladic IIIC A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Archaeology by Trevor Matthew Van Damme 2017 © Copyright by Trevor Matthew Van Damme 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Life after the Palaces: A Household Archaeology Approach to Mainland Greece during Late Helladic IIIC by Trevor Matthew Van Damme Doctor of Philosophy in Archaeology University of California, Los Angeles, 2017 Professor Sarah P. Morris, co-chair Professor John K. Papadopoulos, co-chair My dissertation examines the period after the collapse of the Mycenaean palatial system until the beginning of the Early Iron Age (1200–1050 BC). Traditionally identified as a ‘Dark Age,’ this period has been characterized as one of decline, stagnation, and relative egalitarianism in contrast with the palatial period. Recent research has begun to contradict these assumptions, demonstrating that international contacts continued in the post-palatial period and many communities continued to thrive. Drawing on the growing field of post-collapse literature and integrating elements of resilience and urban theory, my dissertation poses the following interrelated questions: Why do certain communities survive collapse? What made a resilient community? And what influenced the settlement pattern identified in the post-palatial period? I argue that the perception of abundance ii (whether in terms of resources, opportunities, information, or technologies) played an integral role in shaping the landscape of Greece.