Dottorato in Scienze Storiche, Archeologiche E Storico-Artistiche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
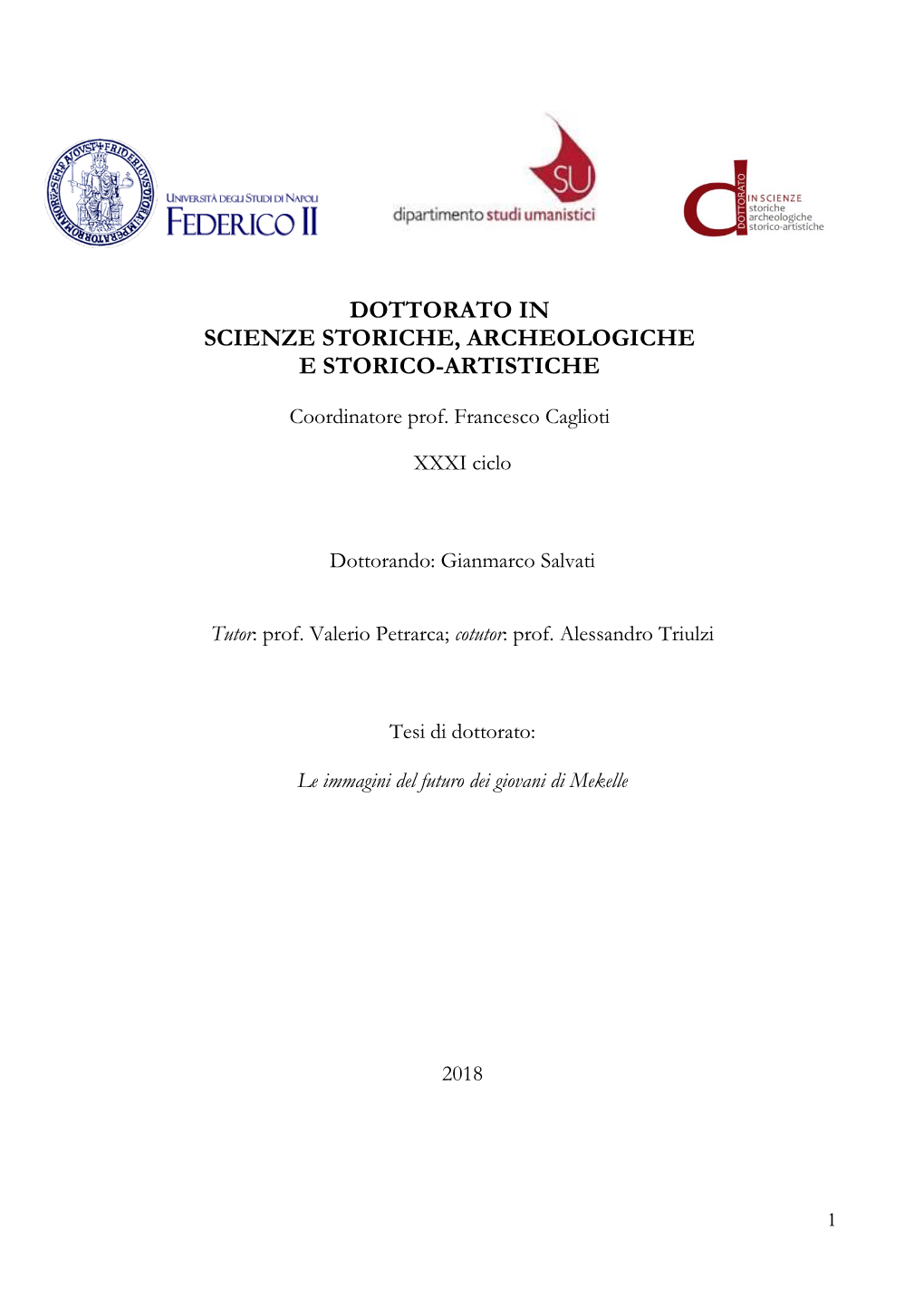
Load more
Recommended publications
-

An Abstract of the Thesis Of
AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Micknai Arefaine for the degree of Master of Arts in Applied Anthropology presented on June 6, 2019. Title: Injera in the Kapitalocene: Understanding Women’s Perceptions of Change in Mekelle, Ethiopia Abstract approved: ______________________________________________________ Kenneth Maes Women’s lives in one of the oldest neighborhoods in Mekele, Ethiopia are very organized, systematic, and sophisticated. The women in this study model, express, and reflect the values of community, trust, care, stability, and futurity through their perceptions and sentiments regarding social and political change. I document how these values are reflected in their social reproduction and protection of injera as a staple of Ethiopian cuisine. The preparation of injera occurs in a sacred and gendered spatio-temporal location that is only accessible to women and children, and hopefully, in some small way, the readers of this thesis. This research serves to examine the micropolitics of everyday life as it occurs between women. Injera Epistemology is an emergent theoretical framework inspired in part by the work of Meredith Abarca, Emiko Ohnuki-Tierney, and Shawn Wilson. I use this framework to situate three women’s stories within the grander narrative of women’s empowerment in Ethiopia and beyond. ©Copyright by Micknai Arefaine June 6, 2019 All Rights Reserved Injera in the Kapitalocene: Understanding Women’s Perceptions of Change in Mekelle, Ethiopia by Micknai Arefaine A THESIS submitted to Oregon State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Presented June 6, 2019 Commencement June 2020 Master of Arts thesis of Micknai Arefaine presented on June 6, 2019. -

0150600020 ^S^R
Représentât! 0150600020 Reçu CLT CIH ITH ICH-02 - Form Le ' 2 1 SEP. United Nations . Intangible Educational, Scientific and . Cultural Cultural Organization . Héritage N0........... ^<-.. REPRESENTATIVE LIST 0F THE TANGIBLE CULTURAL HERITAGE 0F HUMA ITY Deadline 31 March 2020 for possible inscription in 2021 Instructions for completing thé nomination form are available at: htt s://ich. unesco. or /en/forms Nominations not complying with those instructions and those found below will be considered incomplète and cannot be accepted. A. State(s) Party(ies) For multinational nominations, States Parties should be listed in thé order on which they hâve mutually agreed. Ethiopia B. Name of thé élément B.1. Name of thé élément in English or French Indicatethé officiai name of thé élémentthat will appearin published matehal. Not to exceed 200 characters Ashenda, Ashendye, Aynewari, Maria, Shadey, Solel - Ethiopian Girls' Festival B.2. Name of thé élément in thé language and script of thé community concerned, if applicable Indicate thé officiai name of thé élément in thé vernacular language corresponding to thé officiai name in English or French (point B. 1). Not to exceed 200 characters l\m^. hî^^^!\^ïcPôs-a1Cf^S. y.^^-<!h.:t-^f 6^^^f- h-fl^ na,A B.3. Other name(s) of thé élément, if any In addition to thé officiai name(s) of thé élément(point B.1), mention alternate name(s), if any, by which thé élémentis known. In addition to thé officiai name of thé élément mentioned at point B2, thé festival is known by other alternate names among différent towns, cities, nations and nationalities of Northern Ethiopia. -

Assessment of Promotional Mixes Practice of Tigray Tourism Industry, Ethiopia
GeoJournal of Tourism and Geosites Year XIV, vol. 36, no. 2spl, 2021, p.597-602 ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 DOI 10.30892/gtg.362spl06-688 ASSESSMENT OF PROMOTIONAL MIXES PRACTICE OF TIGRAY TOURISM INDUSTRY, ETHIOPIA Demoz AREFAYNE* Aksum University, Department of Management, Ethiopia, e-mail: [email protected] Leake LEGESSE Aksum University, Department of Marketing Management, Ethiopia, e-mail: [email protected] Daniel ALEMSHET Aksum University, Department of Tourism Management, Ethiopia, e-mail: daniofaxum@gmail. com Citation: Arefayne, D., Legesse, L., & Alemshet, D. (2021). ASSESSMENT OF PROMOTIONAL MIXES PRACTICE OF TIGRAY TOURISM INDUSTRY, ETHIOPIA. GeoJournal of Tourism and Geosites, 36(2spl), 597–602. https://doi.org/10.30892/gtg.362spl06-688 Abstract: Tigray Regional State has significant tourism potentials. However, it is unable to exploit the existing tourism products using a promotional strategy. Therefore, the purpose of this study is to assess the promotional practice of the Tourism industry. This study applied a quantitative study design. The data was collected from 180 foreign and domestic tourists. The findings of the study indicated that Tigray tourism office frequently used television and radio promotional Media which are the most traditional, but infrequently used modern promotional tools (Websites, Short Mobile Messages (SMS), word of mouth, public relation). Sales Promotion and Public Relations mixes are mostly applied promotional elements in Tigray tourism sites. Key words: Tourism, Promotional mix, Marketing mixes, Tigray, Ethiopia * * * * * * INTRODUCTION Tourism is an ever expanding service industry with latent vast growth potential and has become one of the largest and dynamically developing sectors of nations (Nurhssen, 2016). Therefore, observably in most developed countries, the smokeless industry has the lion's share in the overall economic growth and development of a country. -

List of Panels for ICES20
List of Panels for ICES20 01 Archaeology, Paleoanthropology & Heritage 0101 Inter-Disciplinary Interconnections for the Scientific Growth of Ethiopian Archaeology 0102 Practices of Archaeological Researches and Conservation of Archaeological Sites in Ethiopia 0103 The Aksumite Ceramics to Reconstruct Social and Trade Intra-Interconnections The Foreign Projects Meet the Ethiopian Universities. Several Cases of Studies in Ethnology, 0104 Ethnography, Linguistics, Archaeology, and Experimental Researches. 0199 Archaeology, Paleoanthropology & Heritage – General Panel 02 Arts & Architecture Contemporary Ethiopian Art Scene: Drawing Heritages from the Past, and (Being Engaged in) New 0201 Aspects in Art 0202 Ethiopian Christian Art: Defining Styles, Defying Definitions 0203 Ethiopia's ecclesiastical painting traditions: influences, development, technology, and conservation 0204 Ethnomusicology Studies in Ethiopia 0205 Multifaceted Customs and Cultures of Ashenda, Ayniwari, Shadey, Solel 0206 Museums and Development in Ethiopia 0207 Music and the Dynamics of Contact in Ethiopia 0208 Musical Instruments and Performance of Peripheral Societies of Ethiopia Personal Adornment in Ethiopia: Regional and Global Influences on Local, Regional and National 0209 Dress, Jewelry and Tattoo/Body Painting. 0210 The New Rock-Hewn Churches of Ethiopia: Continuity or Revival? 0211 Traditional Building Technology and Comparison with Abroad 0212 Transnational Entanglements of Cultural Festivals in Ethiopia and the Horn of Africa “Art History, Church Architecture, Liturgical Development and Historical Issues in Tigray”: Inter- 0213 Disciplinary Researches 0299 Arts & Architecture – General Panel 03 Economics & Development Studies 0301 Ch’at in Ethiopia 0302 Development and Aid: From Conceptualisation to Implementation. 0303 Development and Labour on the Horn: Outlining the Contours of a Key Relationship 0304 Enabling Infrastructures, Redefining Territories: Ethiopia’s Regions Beyond Rural or Urban Bias Lands of the Future. -

A Shift from Peasant to Intellectual-Led Political Opposition in Tigray During the Imperial Regime (Up to 1974)
Vol. 6(8), pp. 129-140, October, 2014 DOI: 10.5897/AJHC2014.0196 Article Number: 5F3F1F947379 African Journal of History and Culture ISSN2141-6672 Copyright © 2014 Author(s) retain the copyright of this article http://www.academicjournals.org/AJHC Review A shift from peasant to intellectual-led political opposition in Tigray during the imperial regime (up to 1974) Atsbha Gebreigziabher Asmelash History and Heritage Management, College of Social Science and Humanities Debre Markos University, Ethiopia. Received 24 April 2014: Accepted 6 August, 2014; This paper examines how the educated people of Tigray took over the illiterate ones to fight against the imperial government. Local songs, poems and sayings used against Emperor Haileslasie are discussed. Following the liberation of Ethiopia from the Italian occupation in 1941, Emperor Haileslasie introduced a number of reforms, many of which were rejected by the people of Ethiopia. The imperial government used different measures including force to implement its policies. This created resentment in the people over whom repressive actions were undertaken. What happened in Tigray in 1942/43 is a good example. The Qedamay (First) Woyane Rebellion of 1942/43 broke out due to high taxation, maladministration, corruption, political feud etc. Although the rebellion failed because British Royal Arms intervened, the people did not remain submissive to the regime. A number of Tegaru University students from different Awrajas of Tigray joined Hailslasie I University at different times. The university served as an academic and political school where they agreed on how to save their communities from miserable lives. They formed an organization called Tigrean University Students Association (TUSA) that served them as an umbrella and binding pot. -

Enhancing Livability of Squares and Streets: the Case of Romanat District, Mekelle CBD, Mekelle, Tigray
Enhancing Livability of Squares and Streets: The Case of Romanat District, Mekelle CBD, Mekelle, Tigray. M.Sc. thesis in Environmental Planning and Landscape Design Author: Sara Amare Advisors: Hailu Worku (Ph.D.) : Fasil Giorghis (M.Sc.) Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development, Addis Ababa University May, 2014 Addis Ababa, Ethiopia This thesis is submitted to the Ethiopian institute of Architecture, Building Construction and City Development (EiABC), Addis Ababa University; in the Partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Science in Environmental Planning and Landscape Design. Title of Thesis: Enhancing Livability of Squares and Streets: the case of Romanat District, Mekelle CBD, Tigray. By: Sara Amare May, 2014 Approved by Board of Examiners:- Hailu Worku (Ph.D.) ____________________ _____________ Advisor Signature Date Fasil Giorghis (M.Sc.) _________________ ____________ Advisor Signature Date Heyaw Terefe (Ph.D.) ___________________ ______________ Internal Examiner Signature Date DestaAlem Haileselassie (M.Sc.) ___________________ ______________ External Examiner Signature Date Fisseha Wegayehu (Ph.D.) ____________________ ______________ Chair Person Signature Date DECLARATION I hereby declare that all the information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this -

Mekelle University College of Business and Economics Department of Management
MEKELLE UNIVERSITY COLLEGE OF BUSINESS AND ECONOMICS DEPARTMENT OF MANAGEMENT Community Participation in Tourism Development in Amhara Region: Evidence from Lalibela Town A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Award of Master of Art Degree in Development Studies. By: Dagnachew Girma ID NO CBE/PS-043/02 Principal Advisor: Abebe Ejigu (Ph.D) Co Advisor: Asmachew Mesfin, (Lecturer) June, 2013 Mekelle, Ethiopia Declaration I declare that this work entitled Community Participation in Tourism Development in Amhara Regional State: evidence from Lalibela Town is my original work, has not been presented earlier for the award of any degree or diploma to any other university and that all sources of materials used for this thesis have been duly acknowledged. I have produced it independently except the guidance and suggestion of my research advisors. Name of the Advisor: Abebe Ejigu Co-advisor Asmachew Mesfine (Lecturer) Signature: --------------------- Signature: --------------------- Date: ---------------------------- Date: ---------------------------- Approved by the examination board: _____________ _____________ __________ Name signature Date Chair, the examining board: _____________ _____________ __________ Name signature Date External Examiner: _____________ _____________ __________ Name signature Date Internal Examiner: _____________ _____________ __________ Name signature Date i Acknowledgment I am deeply grateful to my principal advisor Abebe Ejigu (PhD) for his invaluable and unreserved professional suggestions and guidance for the research paper, that without his assistance, successful accomplishment of this research paper would have been very difficult. My specials thanks also goes to my co-advisor Asmachew Mesfin (MA) for this important comments and significant suggestion during the research process It is a pleasure to extend my gratitude to my family Girma Dereje, Mekonen Girma, Alemnesh Girma, Mahary Girma, Mulunesh Brhanu, and Nega Addis who have all encouraged and supported me in completing my reaserch. -

The Emergence and Transformation of Tigrayan Nationalism
The Emergence and Transformation of Tigrayan Nationalism Lema Lema (PhD )07-28-20 [email protected] Abstract Since the new federal government came to power in 2018, it is pursuing a more centralized policy that undermines self-government, isolates some stateslike Tigray in what appears to be a federation without Tigray. Tigray, a state that was at the fore front of the struggle for self- government is challenging this trendand asking, if this is the new reality, why staying in a union? There is an ongoing tension between the two governments which if not managed carefully could lead to clash of nationalisms.The article diagnoses this tension tracing its origins and its recent transformation. Whether Tigray will settle for a multination federalism within in Ethiopia as it did in 1991 or secederemains an open question but could lead to fragmentation unless the federal government addresses Tigray’s concerns through appropriate institutional and policy options.The study is informed by the theories of ethno national based conflicts andthe idea of search for dignity and collective self-esteem that groups find when treated as secondary citizens in their country.The research is based on an extensive field work conducted in Tigray for three weeks. Data were collected through interviews with thirty one key informants and eleven focus group discussions each containing ten members composed of different sections of society. Key words: ethno federation in Ethiopia; nationalism in Tigray; self-government; ethnic conflict 1. Socio Political Context of Tigray and its Link with Post-1991 Ethiopia and the Horn Tigray regional state is found in the northern part of Ethiopia and shares common borders with Eritrea in the North, Afar regional state in the East, Amhara regional state in the South and the Sudan in the West. -

Intersections: Ethiopia, Peace Corps, and a Fulbright Experience Janet Lee Regis U, [email protected]
Jesuit Higher Education: A Journal Volume 7 | Number 2 Article 10 11-2018 Intersections: Ethiopia, Peace Corps, and a Fulbright Experience Janet Lee Regis U, [email protected] Follow this and additional works at: https://epublications.regis.edu/jhe Part of the Education Commons Recommended Citation Lee, Janet (2018) "Intersections: Ethiopia, Peace Corps, and a Fulbright Experience," Jesuit Higher Education: A Journal: Vol. 7 : No. 2 , Article 10. Available at: https://epublications.regis.edu/jhe/vol7/iss2/10 This Reflection is brought to you for free and open access by ePublications at Regis University. It has been accepted for inclusion in Jesuit Higher Education: A Journal by an authorized administrator of ePublications at Regis University. For more information, please contact [email protected]. Lee: Intersections Intersections: Ethiopia, Peace Corps, and a Fulbright Experience Janet Lee Dean of the Library Regis University [email protected] I don’t remember the exact moment I decided I in the 1970s, in my case the village, Emdeber, would join the Peace Corps. I just knew I would among the sebat bet (seven house) Gurage people. go. Somewhere. Anywhere. Imagine me, small town girl from small town America off to see the Since my return to Colorado, to school, to work, I world. When I received the formal acceptance my have thought about Ethiopia every single day, senior year of college, I tore open the envelope without exception. Like Maria, I have been known and read that I would be going to Ethiopia. My to walk up to complete strangers—be they friend asked, “Where is Ethiopia?” and I students, hotel staff, airport employees, drivers, responded, “I think it’s in Africa.” Ethiopia, the the guy at the local sandwich shop—and greet land of ancient kingdoms, the Ark of the them in Amharic, the official language of the Covenant, its own written language, castles and government. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting Template
THE LIFE AND DEATH OF MEDIEVAL ETHIOPIAN PRIESTS: A BIOARCHAEOLOGICAL AND OSTEOLOGICAL INVESTIGATION OF HUMAN MUMMIES FROM ABUNE MELKETSADIK AND YIMREHANE CAVE MONASTERIES, ETHIOPIA By ABIYOT DEBEBE SEIFU A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2016 © 2016 Abiyot Debebe Seifu To all Ethiopian Christians martyrs Killed by ISIS in Libya, to my father, to my sisters, and to Hanna Amare ACKNOWLEDGMENTS I thank my committee chair, Dr. Steven Brandt, first and foremost for his extraordinary support, advice, and patience these past few years. He was always there, every step of the way and also helped me to develop critical thinking. This dissertation would not be possible without his support and guidance. I would also like to thank my doctoral committee for their advice on the area of their specialization throughout the entire PhD process. I am grateful to the National Geographic Society, Waitt Grants Program, for providing funding for the field work and I would particularly like to thank the Waitt Program Coordinator, Fabio Esteban Amador. I am grateful for the generous assistance of the Department of Anthropology for providing financial assistance for my fieldwork. In particular, I am indebted to Dr. Susan deFrance for her unwavering support. I am also grateful for the countless support of Juanita Bagnall, Karen Jones and Pamela Freeman. I am also grateful to the African Studies for the fellowship and funding my dissertation providing. In particular, I am grateful for Dr. Leonardo Villalon, Dr. -

Analyzing the Upshots of Development Induced
© 2020 IJRAR August 2020, Volume 7, Issue 3 www.ijrar.org (E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138) Analyzing the Upshots of Development Induced Displacement and Rehabilitation Mechanisms on the Livelihood of Peri-Urban Households in Ayder sub-city, Mekelle City Tadesse Tekle Kahsay1 and Kassaye Fentahun Tamir2 1 Lecturer, Department of Geography and Environmental Studies, Adigrat University, Adigrat, Ethiopia 2 Assistance Lecturer, Department of Geography and Environmental Studies, Adigrat University, Adigrat, Ethiopia Abstract The study was conducted to analyses the consequences of development induced displacement and rehabilitation mechanisms on the livelihood of peri-urban households in Ayder sub-city. Displaced farmers in Ayder sub-city in kebelle Mariam- Dehan residential were considered for the study. The study was initiated with objectives to assess the effects of development induced displacement on the livelihood of peri-urban households and to explore the upshots of rehabilitation mechanisms on the livelihood of displaced peri-urban households. Accordingly, a data was collected from displaced farmers. Primary and secondary data were collected from different sources. Structured questionnaire, in-depth interview, key informants interview and observation were the main sources of primary data. Similarly, proclamations, regulations and guidelines on expropriation land for public purposes & payment of compensation, journals, thesis and websites were reviewed to gather the secondary data. The structured questionnaire was filled by the randomly selected 80 sample respondents through the data collectors. But the sample respondents for in-depth interview and key informant interview were selected purposefully. The in-depth interview was collected by the principal and co-investigator of the study & so did the interview held with sub –city municipality workers. -

Regarded As Thй Festival As Thй Cultural
0160600007 / iTH Le -1 ........... ^^ Format for National Register of thé Intangible Cultural Héritages of Ethiopia Register No. 0006 l. Background Ethiopia is thé cradle for thé ancient civilization as well as number of intangible social values; among thé cultural héritages it has thé cultural festivity sung by girls in thé northern part of thé country. This festival of girls is named [Ashenda Ashendye Aynewari Maria Shadey Solel - Ethiopian Girls Festival]. This festival is an open air élément celebrated as thé day of thé liberty of women. This traditional festival is celebrated annually from August 22-24 after thé Tsome-Filseta' lent season is aver. 2. Intangible héritage inforination 2. 1 Doniain of thé héritage Social practice, rituals and festive event; performing art; and oral traditions and expressions; including language as avehicle of thé intangible cultural héritage. 2.2 Name of thé élément, as used by thé community or group concerned: [Ashenda Ashendye Aynewari Maria Shadey Solel - Ethiopian Girls Festival]. 2. 3 Thé héritage belongs to thé community (ies), group(s) or individuals concerned: This Intangible Héritage belong to thé ethnie groups in thé Amhara and Tigray régional states of Ethiopia. 2.4 Description of thé élément: Thé Festival of Girls and Women is among cultural festivals widely celebrated in Amhara and Tigray régions of Ethiopia. Based up on thé green leaf girls and women tie to their waist during thé célébration, thé festival is referred: In Amhara région; Ashandiye in Lasta Lalibela and Gonder; Shaday in Waghemra Zone, Solel in Raya-Kobo and in Tigray Région; Ashanda in Enderta, Tembien and surroundings; Marya in Adigrat area and Ayiniwari at Axum and environs.