Dialoghi Mediterranei
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

It-Tlettax-Il Leġiżlatura Pl 6822
IT-TLETTAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 6822 Dokument imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Numru 478 tat-23 ta’ Ġunju 2021 mill-Ministru għall-Ġustizzja, l- Ugwaljanza u l-Governanza. ___________________________ Raymond Scicluna Skrivan tal-Kamra European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ STUDIES No. 23 Edition 2016 (2014 data) An overview Go to the website of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) http://www.coe.int/cepej You will especially find a dynamic online database that allows you to access to complete data used in this report and our Newsletter, to which you can subscribe. 2 Table of contents 1 Introduction 5 2 Budget 7 2.1 Budget of Judicial systems ................................................................................................ 7 2.2 Legal aid ............................................................................................................................ 12 3 Professionals 16 3.1 Judges ............................................................................................................................... 17 3.2 Prosecutors ....................................................................................................................... 23 3.3 Non-judge staff ................................................................................................................. 30 3.4 Staff attached to the public prosecution services ......................................................... 34 3.5 Lawyers ............................................................................................................................ -

National Report on the Follow-Up to the Regional Implementation
National Report on the Follow-Up to the Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) in Albania during the period 2012-16 Executive summary Approximately 500 to 700 words (1-1.5 A4 pages, single-spaced). Please provide an executive summary according to the structure below: Methods used for this report; in particular, details of the bottom-up participatory approach used, if any Brief review of national progress in fulfilling (or lagging behind) the commitments of MIPAA/RIS. Include three to five major achievements since 2012 and three to five important aspects to be improved in the future Conclusion. This is the second report of Albania on regard of Madrid Plan on Ageing. For the first time, it is assured a high degree of participation from diverse sources and actors. Besides, using a number of reports, studies and analyses on ageing, produced since 2012 more than 20 stakeholders were invited to contribute with their information and experiences about progress and challenges during implementation of MIPAA/RIS. The instrument for stakeholders prepared by UNECE secretariat was translated into Albanian and discussed in two meetings with all relevant actors; one meeting dedicated to ministries and other state institutions and the other to non-governmental organizations. Albanian population ageing is characterized by relatively late demographic transition and high emigration rate. Albania has been acting in many areas since the Vienna Conference and its government has put ageing issues into its main priorities. A good example of it is the mainstreaming of ageing issues into the principal political document of the country such as strategy for development and integration 2015-2020, as well as, in the new Social Inclusion Policy Document 2016-2020. -
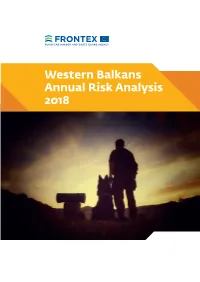
Frontex · Western Balkans Annual Risk Analysis 2018 Table of Contents
Western Balkans Annual Risk Analysis 2018 Western Balkans Annual Risk Analysis 2018 Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland T +48 22 205 95 00 F +48 22 205 95 01 [email protected] www.frontex.europa.eu Warsaw, April 2018 Risk Analysis Unit Frontex reference number: 10807/2018 PDF TT-AD-18-001-EN-N ISBN 978-92-9471-192-2 doi:10.2819/41268 Cover photo: Romanian border police All rights reserved. DISCLAIMERS This is a Frontex staff-working document. Its contents do not imply the expression of any opinion whatso- ever on the part of Frontex concerning the legal status of any country, territory or city or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. All maps, charts, figures and data included in this presentation are the sole property of Frontex and any unauthorised use is prohibited. Frontex disclaims any liability with respect to the boundaries, names and designations used on the map. Throughout this report, all references to Kosovo are marked with an asterisk (*) to indicate that this des- ignation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. ACKNOWLEDGMENTS The Western Balkans Annual Risk Analysis 2018 has been prepared by the Frontex Risk Analysis Unit. During the course of developing this product, many colleagues at Frontex and outside contributed to it and their assis- tance is hereby acknowledged with gratitude. 2 of 52 Frontex · Western Balkans Annual Risk Analysis 2018 Table of Contents Executive summary #5 1. -

Corruption Assessment Report Albania
CORRUPTION ASSESSMENT REPORT ALBANIA Copyright © 2016, Albanian Center for Economic Research (ACER), South-East Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI) Acknowledgments This report was prepared by ACER under guidance from the Center for the Study of Democracy (CSD, Sofia - Bulgaria) within the framework of SELDI network. Research coordination and report preparation: Zef Preci (ACER) Brunilda Kosta (ACER) Eugena Topi (ACER) Lorena Zajmi (ACER) Field research: Fatmir Memaj (Albanian Socio-Economic Think Tank, ASET) Dhimiter Tole (Faculty of Economy, University of Tirana) Sincere thanks are expressed to the staff engaged with dedication and professionalism in the field work carried for the project survey. Project Associates in Albania: House of Europe, Tirana (Albania) Associated partners in Albania: Albanian Media Institute (AMI), Albania Institute for Democracy and Mediation, Albania We would like to acknowledge the contribution to the report of Mr. Ruslan Stefanov (CSD) and Ms Daniela Mineva (CSD). The survey, in which the current report is based, has followed the Corruption Monitoring System methodology. Mr. Alexander Gerganov (Vitosha Research) has provided methodological guidance and instructions in carrying out the survey and delivering the results. This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the SELDI initiative and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. 1 Project Title: Civil Society -

Employment Conditions of Journalists in Albania, Bosnia-Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia - Regional Report - March 2015
The Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability Programme, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI Employment conditions of journalists in Albania, Bosnia-Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia - Regional Report - March 2015 South-East European Partnership for Media Development This project is funded by A project implemented by The European Union Center for Independent Journalism South-East European Partnership for Media Development SEE Partnership for Media Development is implemented by a consortium of media organizations from Albania, Bosnia-Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania. Media professionals from Kosovo and Turkey will also be involved. The Project is co-financed by the European Commission, the Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability Programme, Europe Aid/134613/C/ACT/MULTI The SEENPM members that are part of the project: Albanian Media Institute, Mediacenter for Media and Civil Society Development (BiH), Media Initiatives – Association for Media Development and Promotion of Professional Journalism (BiH), Macedonian Institute for Media (Macedonia), Montenegro Media Institute (Montenegro), Media Center (Serbia), Media and Reform Centre Nis (Serbia), Media Development Center (Bulgaria). A project implemented This project is funded The European Commission is the EU’s executive body. By the Center for Independent by the European Union Journalism “The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link Delegation of together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement Address: Bd. Regina Elisabeta, no. The European Union In Romania of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development 32, sect V, str. -

The Visegrad Four and the Western Balkans Six5
European Scientific Journal October 2015 /SPECIAL/ edition Vol.1 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 VISEGRAD MEETS VISEGRAD: THE VISEGRAD FOUR AND THE WESTERN BALKANS SIX5 Denisa Ciderova Dubravka Kovacevic University of Economics in Bratislava, Slovak Republic Abstract Enlargements of the European Union (EU) over the recent decade have not just expanded its territory or increased the headcount of its Single Market; by almost doubling the number of its Member States (MSs) the EU faces multifaceted implications beyond any doubt. Having been challenged by multiple transformation, the Central and East European Countries (CEECs) assumed their rights just like obligations associated with EU membership upon completion of transitional periods intended to allow for as much a smooth integration process as possible. Accession to the EU reinforced their prestige internationally to the extent of intensity of their participation (i.e. in terms of “mere“ EU membership, or even complemented by a single currency in the Euro Area, and/or single external EU border in the Schengen Area). Gradually, they aspire to maximise their inward financial flow from the common EU budget while simultaneously “catching up“ with the “Western“ degree of political and economic development; post- Cold-war democracies increasingly engage in institutional representation, coalition building and pursuit of own interests amidst the EU arena, too. In this respect we streamline our focus to the Western Balkans and the shaping concept of the so-called Western Balkans Six with the aim to hint prospects of cooperation inspired by the Visegrad Group alias the Visegrad Four (V4). Key Words: European integration, European Union enlargement, Visegrad6,7, Visegrad Four, Western Balkans Six 5 This article results from scientific research conducted at the University of Economics in Bratislava in the framework of: the VEGA project No. -

Report on Cybersecurity Maturity Level in Albania
REPORT ON CYBERSECURITY MATURITY LEVEL IN ALBANIA CONTENTS DOCUMENT ADMINISTRATION ..................................................................................................................... 3 LIST OF ABBREVIATIONS .............................................................................................................................. 4 EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................................... 6 INTRODUCTION ................................................................................................................................ 14 DIMENSIONS OF CYBERSECURITY CAPACITY .................................................................................................. 15 STAGES OF CYBERSECURITY CAPACITY MATURITY .......................................................................................... 16 METHODOLOGY - MEASURING MATURITY ................................................................................................... 17 CYBERSECURITY CONTEXT IN ALBANIA ............................................................................................ 20 REVIEW REPORT............................................................................................................................... 22 OVERVIEW ............................................................................................................................................. 22 DIMENSION 1 CYBERSECURITY STRATEGY AND POLICY ................................................................... -

Scheda Progetto Per L'impiego Di Volontari In
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO ENTE 1) Ente proponente il progetto: CARITAS ITALIANA La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il senso cristiano della Carità. Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: CARITAS ITALIANA Via AURELIA,796 - cap 00165 - città ROMA Per informazioni: tel.06.66177001- fax 06.66177602 e-mail: [email protected] 2) Codice di accreditamento: NZ01752 3) Albo e classe di iscrizione: NAZIONALE 1a classe CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: Caschi Bianchi in Europa 2017 5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): Settore: SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO Area di intervento: Educazione e promozione culturale, Assistenza Codice: F11 (area prevalente), F07 6) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area geografica dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel paese o nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione dei partner esteri: Il progetto si esprime e si realizza nella area geografica dei Balcani, un’area in cui le tensioni sono tornate "al livello più pericoloso dalla fine della guerra degli anni Novanta". -

World Tax Advisor 25 April 2014
International Tax World Tax Advisor 25 April 2014 In this issue: Russia’s “de-offshoring” policy may affect foreign and domestic businesses ......................................................................... 1 European Union: Netherlands requested to end discriminatory taxation of dividend distributions to insurance companies .... 6 France: Measures announced to promote investment ........................................................................................................... 7 Germany: New treaty signed with China ............................................................................................................................... 7 Saudi Arabia: Tax bylaws retroactively amended ................................................................................................................... 8 United Kingdom: New policies affect PAYE reporting for employees on short-term business visits to the UK ......................... 9 In brief ............................................................................................................................................................................... 10 Tax treaty round up ............................................................................................................................................................ 11 Are You Getting Your Global Tax Alerts? ............................................................................................................................ 14 Russia’s “de-offshoring” policy may affect foreign and domestic -

Illegal Killing of Birds
Towards eradication of illegal killing, trapping and trade of wild birds version 4 - April 2014 Briefing on ongoing initiatives to tackle illegal killing of birds Since the 2011 Larnaca conference on Illegal killing, trapping and trade of birds (IKB), there has been an acceleration of international activity to combat illegal killing of birds. This is a condensed overview of ongoing initiatives where BirdLife Europe is involved and some further additions from other initiatives. For comments and additions please contact [email protected], thanks in advance. 1 EC Roadmap towards eliminating illegal killing, trapping and trade of birds The European Commission identified actions to be taken at EU, Member State, agency or NGO level with a view to increase effectiveness in measures aimed at eliminating illegal killing, trapping, and trade of birds in the EU. The Roadmap is a non-binding instrument for cooperation and prioritization, a first version was produced in December 2012. The working group following up the Roadmap is formed by the EC, Bern Convention Secretariat, BirdLife Europe, FACE, AEWA-CMS, Impel and Interpol. Coordination by the nature unit of DG Env. 2 Tunis Action plan 2013-2020 for the eradication of illegal killing, trapping and trade of wild birds. The Bern Convention developed an action plan to eradicate IKB during the 2nd conference on IKB in Tunisia (May 2013) covering enforcement and legal aspects, biological and institutional aspect and awareness aspects. The action plan was approved by the contracting parties in December 2013. Coordination by the Secretariat of the Bern Convention. 3 CMS Working Group on Poisoning of Birds This WG has developed global guidelines to counter effects on migratory birds by insecticides, lead, poison- baits, rodenticides and veterinary pharmaceuticals (NSAIDs). -

UBT Annual International Conference on Business, Technology and Innovation
Proceedings of the 4th UBT Annual International Conference on Business, Technology and Innovation Chapter: Architecture and Spatial Planning Chapter: Civil Engineering, Infrastructure and Environment November, 2015 1 ISBN 978-9951-550- 13 - 0 © UBT – Higher Education Institution International Conference on Business, Technology and Innovation Durres, Albania 6-7 November 2015 Editor: Edmond Hajrizi Organizers: Albert Qarri, Felix Breitenecker, Krenare Pireva, Evelina Bazini, Kozeta Sevrani, Betim Gashi Co-organizes: Ardian Emini, Muzafer Shala, Lulzim Beqiri, Mimoza Sylejmani, Besian Sinani, Xhemajl Mehmeti, Murat Retkoceri, Bertan Karahoda, Ermal Lubishtani, Albulena Jahja, Erveina Gosalci, Alfred Marleku, Ibrahim Krasniqi, Ylber Limani, Naim Preniqi, Rexhep Kera, Muhamet Sherifi, Ermal Gashi Authors themselves are responsible for the integrity of what is being published. Copyright © 2015 UBT. All rights reserve Publisher, UBT 2 EDITOR SPEECH International Conference on Business, Technology and Innovation is an international interdisciplinary peer reviewed conference which publishes works of the scientists as well as practitioners in different research area. The main perspective of the conference is to connect the scientists and practitioners from different disciplines in the same place and make them be aware of the recent advancements in different research fields, and provide them with a unique forum to share their experiences. It is also the place to support the new academic staff for doing research and publish their work in international -

Ongoing Initiatives to Tackle Illegal Killing of Birds
Strasbourg, 14 March 2016 T-PVS/Inf (2016) 6 [Inf06e_2016.docx] CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS Standing Committee 36th meeting Strasbourg, 15-18 November 2016 __________ 3rd MEETING OF THE SPECIAL FOCAL POINTS ON ILLEGAL KILLING, TRAPPING AND TRADE OF WILD BIRDS Tirana, Albania, 14-15 April 2016 - ONGOING INITIATIVES TO TACKLE ILLEGAL KILLING OF BIRDS- Document prepared by BirdLife International This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. T-PVS/Inf (2016) 6 - 2 - BRIEFING ON ONGOING INITIATIVES TO TACKLE ILLEGAL KILLING OF BIRDS Since the 2011 Larnaca conference on Illegal killing, trapping and trade of birds (IKB), there has been an increasing number of international initiatives to fight illegal killing, taking and trade of wild birds. This is a condensed overview of ongoing regional initiatives in which BirdLife Europe is involved and some further additions on other initiatives in more than one country. Please contact [email protected] for comments and additions, thanks in advance! Recent additions since previous version 1: new version EC roadmap, 2: new contacts Tunis AP; 5: ENEC weblink poisoning plan; 6: review ikb Med: article published; 9: tackling trapping in Italy, Cyprus and Malta; 13: 2016 IMPEL actions; 14: COTF Greece; 17: contacts Med TF CMS; 18 A Europol – IPEC report; 18 D: EnviCrimeNet EC Roadmap towards eliminating illegal killing, trapping and trade of birds The European Commission identified actions to be taken at EU, Member State, agency or NGO level with a view to increase effectiveness in measures aimed at eliminating illegal killing, trapping, and trade of birds in the EU.